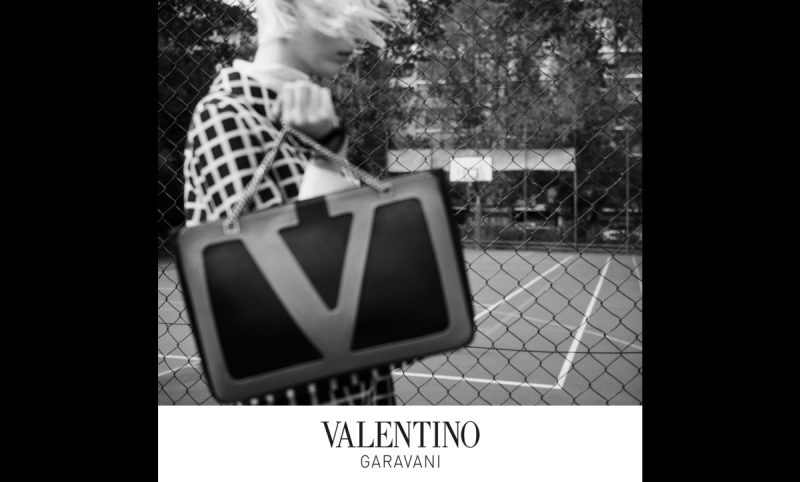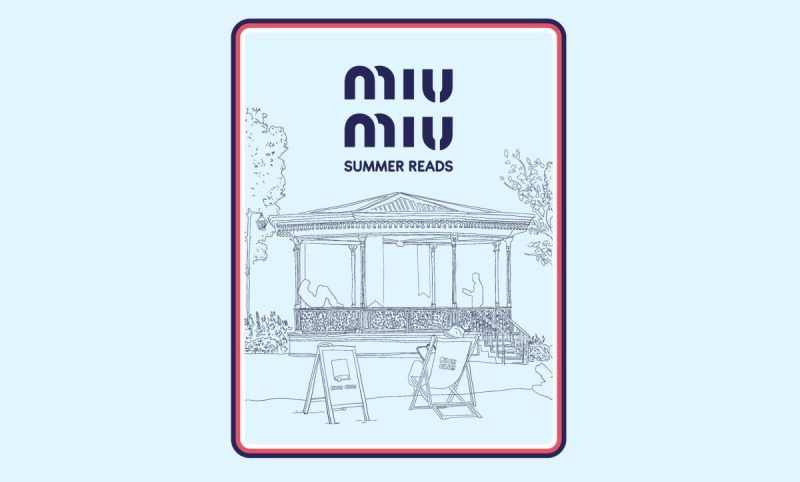Interamente in bianco e nero, è ispirata alla scena artistica degli anni Settanta ed è stata ideata dal Direttore Creativo Alessandro Michele e fotografata da Drew Vickers.
Cosa significa oggi stile italiano?
In un periodo sempre più complicato per l’industria della moda, le sfilate di Milano riflettono l’incertezza del momento storico, tra sartorialità formale e rincorsa alla giovinezza.

In una recente conversazione, una persona molto intelligente ha spiegato (a me e alle altre persone sedute al tavolino di un bar) il perché la filiera italiana non sia la scelta migliore quando si tratta di produrre determinati materiali come il denim, la pelle e il jersey. La ragione è che tutto quello che viene prodotto in Italia ha, immancabilmente, una mano italiana: è cioè rifinito in ogni dettaglio, ha un effetto finale impeccabile, è lussuoso, o almeno questo è quello che abbiamo sempre venduto al mondo (anche se le recenti notizie sul lavoro nero di quella stessa filiera raccontano un’altra storia, ne avevo scritto qui). Non sempre quell’effetto è ciò che si vuole ottenere: se si cerca un tocco più ruvido, un risultato meno ripulito e più “usato”, allora bisogna andare altrove. Era ovviamente una semplificazione, ha aggiunto quella persona che di mestiere fa la stilista, ma è tuttavia una notazione che mi ha fatto riflettere, tanto più guardando alle collezioni sulle passerelle durante quest’edizione della moda uomo. Lo stile italiano, storicamente, si è definito proprio per quelle caratteristiche di rifiniture, morbidezza, portabilità: una concretezza figlia dell’artigianalità italiana che ha avuto molte declinazioni, ma che è rimasta una delle qualità imprescindibili della nostra moda. Le collezioni di questi giorni, ho pensato, parlano ancora la lingua di quello stile italiano, eppure è innegabile che qualcosa stia cambiando: su tutto aleggia infatti una certa decadenza, un’ironia a volte malinconica che finisce per dare nuovi significati al “vestire bene” per cui siamo famosi nel mondo. È un processo in fieri e probabilmente si collega al momento storico, tanto quello ristretto del settore, che attraversa una crisi innegabile dopo la sbornia dello shopping post Covid, quanto quello più ampio che riguarda l’instabilità geopolitica: tutto si ripercuote sulla “voglia” di moda della nostra società. Abbiamo ancora voglia di moda?

Prada Spring Summer 2025. Photo courtesy of Prada
Luca Magliano si è ispirato a Pinocchio, con una collezione che mantiene tutti i codici stilistici che lo hanno reso lo stilista che è: interessato alle persone che i vestiti li indossano, ai loro corpi, alle loro vite e ai loro ricordi. Proprio l’archeologia dei ricordi d’infanzia si riflette nella stratificazione degli abiti e nella loro apparente confusione. Come la memoria spesso è selettiva, confonde e riscrive il nostro passato, così nel “middlewear” di Magliano le destinazioni d’uso dei capi, le loro funzioni (o «disfunzioni», si legge nella nota ufficiale) si invertono: il cappotto ha l’asciugamano integrato, il pantalone diventa costume da bagno, il nodo diventa decoro, il grembiule capo da sera. Nella spiaggia libera di Magliano le persone si incontrano, come nella vita, anche quando fanno lo stesso lavoro e anche in un ambiente in cui è d’abitudine farsi la guerra su Instagram: i maglioni ricamati Cormio/Magliano sono allora il simbolo di «un’alleanza incondizionata tra colleghi», qualcosa che ci libera, almeno per una sfilata, dall’enormità degli ego che affliggono quest’industria. Lo stile italiano di Magliano non ha niente a che fare con l’idea turistificata del nostro Paese (il dolcefarniente che spopola su TikTok), si muove sì nel solco del mito della moda italiana, e di quella portabilità di cui sopra, ma non può essere, nel 2024, una glorificazione di un qualsivoglia jet-set. È invece il risultato di un interesse, una tensione, verso tutto quello che è stato storicamente messo da parte, nascosto, dimenticato.
Anche Miuccia Prada e Raf Simons hanno voluto interessarsi alla sovrapposizione tra verità e finzione, reale e irreale: la collezione che ha sfilato nel Deposito della Fondazione Prada, su una passerella claustrofobica che si apriva con una casetta “rave” dai contorni fiabeschi, erano all’apparenza semplici, ma da vicino rivelavano dettagli distorti. Il fil di ferro che attraversa colletti e orli imprime ai capi un dinamismo irreale, irrigidendoli in posizioni innaturali, mentre le pieghe e le lavorazioni stropicciano, invecchiano, rivelano i segni del tempo: «l’imperfezione è un altro segno di vita, di realtà». Guardando i modelli succedersi veloci era impossibile non pensare a come si vestono certi ragazzi oggi, quando mescolano i capi “thrifted” con gli accessori del momento, quelli che possono permettersi ora che non esistono più punti di accesso al mondo dei marchi del lusso: rubando dall’armadio dei fratelli più grandi o dai genitori, questi ragazzi riutilizzano, riadattano, inventano.

JW Anderson Spring Summer 2025. Photo courtesy of JW Anderson
Anche Jonathan Anderson ha raccontato, parlando con i giornalisti, di come sia rimasto colpito nell’osservare il modo in cui le persone si vestono oggi, soprattutto i più giovani: in un momento in cui la moda sembra «sempre meno radicale», basta farsi un giro a un festival (Anderson è stato recentemente al Primavera Sound) per rendersi conto che c’è ancora voglia di sperimentare con la moda. «Quello che fanno i ragazzi oggi con i vestiti è incredibile. Quando ho iniziato, probabilmente la mia moda per l’uomo poteva sembrare controversa, ma credo che oggi la percezione [dei miei abiti, nda] sia ben più moderata», nota con la lucidità che lo contraddistingue. Ecco perché Jonathan Anderson è il più bravo della sua generazione: è uno che sa cosa significa essere ossessionato da qualcosa (uno che sogna di dormire, quindi scrive sui suoi maglioni “Real Sleep”), sa bilanciare i riferimenti più alti con quelli più bassi (non solo nel marchio che porta il suo nome ma anche da Loewe, dove mescola collaborazioni d’arte e meme, ne parlavamo nell’ultima newsletter Industry) e non rinuncia mai a quell’elemento di leggerezza surrealista che è sempre una boccata di aria fresca: i palloncini/festoni sgonfi attaccati al cappotto? Yes, please. Un tocco che non mancava a Franco Moschino, il cui marchio è oggi disegnato da Adrian Appiolaza (con un passato proprio da Loewe), alla sua seconda collezione da Direttore creativo. Appiolaza ha un compito difficile, com’è difficile reinterpretare qualsiasi archivio: senza Moschino non sarebbe esistito Virgil Abloh e Appiolaza è rispettoso nell’approccio, che filtra con il suo sguardo. Il suo Moschino è forse meno gioioso di quello di Franco, l’ironia esuberante, che non è mai stata superficiale, è ora velata da una certa amarezza: amari sono però i tempi, e i direttori creativi hanno bisogno di tempo.

Gucci Spring Summer 2025. Photo courtesy of Gucci
Sembra invece più a suo agio nel ruolo Sabato De Sarno da Gucci, che ha scelto, per il suo show, di aprire le porte della Triennale di Milano. «Non mi piace la moda che spaventa, quella che allontana le persone», ha raccontato ai giornalisti, «Credo che la mia sia una moda che accoglie, fatta di dettagli». La collezione, come già a gennaio, era fresca e capace di raccontare al meglio l’idea di Gucci del suo nuovo Direttore creativo: le silhouette precise ma mai rigide, le lavorazioni impercettibili all’occhio ma frutto di una minuziosa ricerca sui tessuti, espressione di uno stile italiano contemporaneo dove anche la giacca a doppio petto diventa morbida e la sartorialità è al servizio di una mascolinità più aperta. Particolarmente azzeccata, poi, la campagna che ha anticipato la collezione, con protagonisti i modelli Clément Chabernaud e George Barnett, volti indimenticabili per i Millennial appassionati di moda. Massimo Giorgetti, da MSGM, ha festeggiato i quindici anni del suo marchio con una collezione ispirata al Mediterraneo dove ai rimandi marinareschi si accostano stampe e colori acidi come le bombe di pittura che, durante la sfilata, vengono lanciate su delle superfici bianche, in un allestimento curato da Fabio Cherstich.
Da Jordanluca, invece, hanno guardato al mondo del balletto, ma attraverso il loro filtro: il tutù e le ballerine, per uomo e per donna, si imbevono di nero e ribellione punk, provando a ribaltare anche la più classica delle discipline secondo nuove prospettive. Jordan Bowen e Luca Marchetto servono molto alla moda di Milano, e la speranza è che rimangano qui. Da Emporio Armani, invece, il tema era il ritorno alla natura e agli spazi aperti dei campi, che si riflettono nella palette di colori e nella rilassatezza delle linee, così come da Zegna, dove Alessandro Sartori ha scelto di sfilare in uno spazio industriale all’interno del quale era stato ricostruito un campo di piante di lino. Qui le linee classiche del menswear vestono uomini più maturi, come l’attore Mads Mikkelsen che ha chiuso la sfilata, una contrapposizione che è sembrata particolarmente evidente durante queste sfilate. Era un omaggio a Marcello Mastroianni la collezione di Dolce&Gabbana, che sono tornati all’estetica anni Cinquanta, «periodo d’oro dell’Italia» come scrivono nel comunicato stampa. Ma se c’è qualcuno che ha saputo ricostruire il maschile è di certo Giorgio Armani, uno dei pochi show dove i modelli non erano appena ventenni ma uomini adulti. Gioventù e maturità, ricordi d’infanzia e angoscia del presente, reale e irreale, corpi muscolosi e corpi efebici: questi pochi giorni di moda uomo si sono mossi su molte dicotomie, come d’altronde è il racconto sul maschile oggi. Un racconto, però, a cui mancano molti capitoli, che speriamo prima o poi di leggere qualche parte.
In apertura: Magliano Spring Summer 2025. Photo courtesy of Magliano.

Il weekend lungo dedicato alle collezioni maschili, sempre più ristretto e sempre meno affollato, racconta bene la bizzarra situazione della moda oggi, che sembra non voler più lanciare grandi messaggi ma nascondersi nei vestiti che produce. Segno di tempi complicati o irrilevanza?

I Guest Designer di questa edizione – Homme Plissé Issey Miyake, Niccolò Pasqualetti e Post Archive Faction – sono tre diversi esempi di come oggi i marchi, sia quelli con un heritage alle spalle che quelli di nuova generazione, provano a raccontarsi in un panorama sempre più difficile.