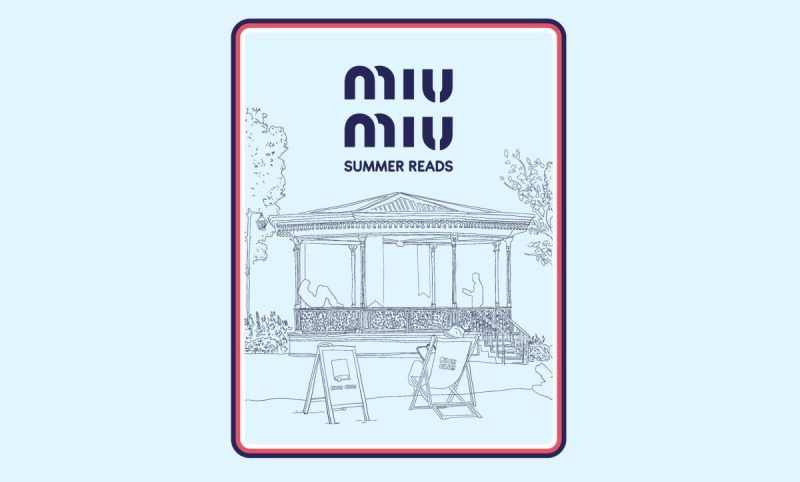Dopo le riuscite campagne di marketing dell’ultimo settimana, lo stilista nordirlandese ha fatto il suo debutto da Direttore creativo con una collezione che setta l’inizio del nuovo corso alla sua maniera.
La surreale settimana della moda di Milano
Le notizie dall’Ucraina hanno inevitabilmente segnato l’edizione che doveva essere la prima quasi del tutto in presenza dall’inizio della pandemia.

Prima dell’attacco russo in Ucraina, i problemi della settimana della moda di Milano, che si è tenuta dal 22 al 28 febbraio, sembravano i soliti. A cominciare dal calendario sempre più ristretto, di fatto tre giorni pienissimi che si sono sommati a uno sciopero dei mezzi e una manifestazione in centro città che hanno reso ancora più scomodi gli spostamenti, mettendo a rischio la visibilità dei marchi più piccoli, schiacciati dagli eventi dei grandi brand che spesso hanno occupato ben più dell’ora prevista dal programma ufficiale. Tra il 23 e il 24 febbraio, però, a quelli che tutto sommato sono crucci degli addetti ai lavori, si è aggiunta la crisi ucraina, che ha avvolto l’intera manifestazione in uno strato di surrealtà difficile da ignorare. Che senso hanno le sfilate in un momento in cui le bombe cadono in un Paese a noi vicino? E che differenza c’è con quelli lontani, perché di conflitti il mondo pullula, ma non tutti sembrano interessarci allo stesso modo? Cosa dovrebbero fare designer, team di marketing, giornalisti e influencer in momenti come questi? Smettere di postare le Stories dagli show, abdicare in toto l’evento come ha fatto il curatore del Padiglione Russia della prossima Biennale d’arte, oppure continuare a fare il proprio lavoro?
Quest’estate era stata la caduta dell’Afghanistan in mano ai Talebani a irrompere negli ultimi scampoli di vacanze social, e già allora l’effetto era a dir poco straniante: aperitivi al mare e foto di persone in fuga, spiegoni su Instagram e meme pieni di strafalcioni, in un susseguirsi di contenuti caotico e spesso privo di senso. Quest’ultima settimana della moda è andata più o meno così, segnale ulteriore di come non abbiamo ancora imparato, collettivamente, a gestire il modo in cui l’attualità viene raccontata e consumata sulle piattaforme digitali, e di come a oggi ci sia richiesta, quale che sia il nostro ruolo nel mondo e rispetto a ciò che vi succede, di esprimerci, schierarci, testimoniare la nostra posizione. È una richiesta che, nel caso della moda, è del tutto valida: perché la moda pretende di intuire e rappresentare i cambiamenti sociali, per sua stessa definizione, ma che di fronte a questo tipo di eventi finisce per trovarsi inevitabilmente in una posizione scomoda.
Non può ricorrere ai minuti di silenzio, come nelle partite di calcio, perché la fashion week non è abbastanza nazionalpopolare da permettere a tutt* di sentirvisi partecipi emotivamente, e non può ignorare il fatto che nelle sue tante ramificazioni è spesso al centro del dibattito geopolitico. Si prenda ad esempio la discussione sulle sanzioni da imporre alla Russia: avranno un peso sul settore, sebbene l’entità delle esportazioni sia notevolmente diminuita negli anni, come segnala un report di Business of Fashion, anche se al momento è difficile calcolarne l’entità e le eventuali ricadute, come ha spiegato il presidente di Camera della Moda Carlo Capasa a Pambianco.
È insomma una grande contraddizione, che appare ancora più stridente in un campo dove la capacità di comunicazione e di amplificazione dei messaggi sono alla base di tutto. Personalmente, ho quasi apprezzato il fatto che i marchi di Milano non si siano lanciati in patetici messaggi di supporto e che i più abbiano scelto un silenzio, si spera consapevole, sebbene quel silenzio non può che farci riflettere, tanto più in uno dei Paesi, il nostro, con una delle più grandi comunità ucraine in Europa. Solo Giorgio Armani ha scelto di sfilare senza l’accompagnamento della musica, un gesto di consapevolezza e una dimostrazione di genuino rispetto. A mancare però è stata una risposta di sistema, una presa di coscienza unanime, di fronte a quello che sta succedendo.
Un peccato oltre che una grande fonte di imbarazzo: chi lavora nella moda dovrebbe superare il proprio complesso di inutilità e provare a utilizzare e condividere lo spazio che ha a disposizione al di là di hashtag e attivismo di circostanza, perché saranno anche vestiti e borsette, ma quante cose possono essere dette, e fatte, con quei vestiti e quelle borsette. Ed è un peccato anche perché questa è stata un’ottima stagione per Milano, in quella che è stata la prima settimana della moda in presenza dall’inizio della pandemia, un’edizione in cui, nonostante le carenze sistemiche di cui la gestione comunicativa della crisi ucraina non è stata che l’ultima dimostrazione, la città ha saputo esprimere una propria idea, convincente, in fatto di abiti.
Tra le sfilate più attese c’erano sicuramente i debutti alla direzione creativa. Come quello di Glenn Martens da Diesel, la prima collezione meglio riuscita che si sia vista da molto tempo a questa parte: il designer di Y-Project sa maneggiare il jeans, fulcro del marchio di Renzo Rosso, con una visione che è sapiente, complessa, ironica. I suoi cappottoni in simil pelliccia – che non è pelliccia, ma denim – e i pantaloni tenuti insieme da cinture al limite dell’equilibrismo sono un sunto perfetto di come Martens tratta la materia prima: piegandola, sminuzzandola, ricomponendola fino a darle una nuova forma. Benjamin A. Huseby e Serhat Işık, il duo dietro a GmbH chiamato a ridisegnare Trussardi, hanno scelto di dare un taglio netto rispetto al passato, partendo dalla decostruzione di quello che loro hanno individuato come un immancabile del guardaroba dei milanesi, ovvero il piumino 100 grammi. Che nella loro idea diventa tutt’altro, una colata di look neri e teatrali che giocano, rifiutandola, con l’idea dell’omologazione: manca ancora la portabilità di Trussardi, hanno notato in molti, ma è presto per dire che non funzioni: ogni simbolo ha significati diversi per generazioni diverse, e Huseby e Işık sono solo all’inizio del loro percorso. Come lo è Matthieu Blazy, che ha scelto invece di riportare Bottega Veneta alla sua espressione di lusso artigianale dopo l’addio improvviso di Daniel Lee dello scorso autunno. Una collezione piena di spunti, non tutti pienamente sviluppati ma con immancabili tocchi di eccellenza (si veda il lavoro fatto sugli accessori e sull’intrecciato), che accennava a un’identità in divenire.
I contributi più energetici, però, li hanno dati i nuovi nomi di Milano, che finalmente iniziano a emergere e a farsi riconoscere. A cominciare da Sunnei, che con un’idea semplice ha coinvolto i suoi ospiti in un gioco-performance che ha poi messo in risalto la loro collezione, un’altra prova di maturità dopo quella di settembre: solo video in slow-motion dei modelli che attraversano la passerella-strada correndo, un trucco intelligente che ha portato una boccata d’aria fresca nel format avariato della sfilata tradizionale. Chiarezza di pensiero e know-how social, i punti forti di Loris Messina e Simone Rizzo. Oppure come ha fatto Marco Rambaldi con il suo show, supportato da Valentino e Pierpaolo Piccioli, che era seduto in prima fila: una dimostrazione di mecenatismo nella quale più grandi marchi si dovrebbero cimentare. La sfilata era come sempre una celebrazione gioiosa e irriverente di corpi e di comunità, un nuovo inizio che, speriamo, porti al consolidamento del brand.
I corpi, e la diversità di forme che possono assumere, erano al centro della collezione di Act N°1, a dimostrazione di come per designer come Luca Lin e Galib Gassanoff sia naturale immaginare gli abiti in base alle persone che li indosseranno (in passerella c’erano Elenoire Ferruzzi e l’atleta paralimpico Alessandro Ossola, tra gli altri), così come è naturale il remix degli elementi differenti del loro background. Particolarmente degno di nota è poi il collettivo Vitelli, che a partire dalla maglieria ha costruito un progetto piuttosto unico a Milano: la loro “Gioventù cosmica” era uno schiaffo alla concezione egomaniaca del design di moda, una rivendicazione della nobiltà dell’approccio artigiano e una sperimentazione nelle pratiche rigenerative nella maglieria, con la creazione di un nuovo tessuto ibrido realizzato con filati di maglieria riciclati e lavorati su macchine meccaniche degli anni Settanta. A proposito di sostenibilità, quella vera. L’ultima a sfilare, domenica pomeriggio, è stata poi Jezabelle Cormio (l’avevamo intervistata qui) che ha scelto di modellare la sua collezione sui Giovani Cantori di Torino, che si sono esibiti all’interno della Casa Cardinale Ildefonso Schuster. Una classe di giovanissimi dalle voci portentose che sembravano usciti da un film di Wes Anderson e che si sono meritati l’applauso coinvolto del pubblico presente (le scarpe erano di Gucci, un’altra partnership creativa che è una buona idea di come i grandi possano supportare i piccoli). In generale, questi marchi sono quelli che hanno offerto una visione più aperta, ampia, intimista e contemporanea.
Corpi diversi si sono visti anche da Blumarine, dove continua la favola Y2K [lo stile anni 2000, ndr] di Nicola Brognano e Lotta Volkova, e da GCDS, ennesimo segnale di quante sfumature può avere il sexy oggi: iniziamo lentamente a considerare normali le forme nelle donne, in un futuro non troppo lontano succederà anche per gli uomini? Più classiche, ognuna con i propri codici, sono state poi le sfilate di N°21 e Tod’s, entrambe (ennesime) ottime prove dei direttori creativi Alessandro dell’Acqua e Walter Chiapponi. E poi ci sono Prada e Gucci, che hanno voluto portare a Milano un po’ dell’internazionalità di Parigi, a partire dagli ospiti: Kim Kardashian da Prada e Rihanna e Asap Rocky da Gucci. La loro comparsa, unita al delirio che hanno causato tra i fan ammassati per vederli e il traffico che ne è conseguito, è stato un altro dei momenti surreali di questa surreale fashion week.
Miuccia Prada e Raf Simons hanno continuato nel solco avviato con la collezione maschile, che aveva come tema centrale il lavoro, concentrandosi questa volta sulla quotidianità, “disturbando” i capi pragmatici del guardaroba di tutti i giorni con elementi preziosi: gli abiti tipicamente maschili si trasformano «con l’irruzione del femminile», i cappotti si aprono sul collo o sulla schiena. Ad aprire la sfilata c’è Kaia Gerber e a chiuderla Hunter Schafer di Euphoria, ma sono le super modelle che sfilano nel mezzo, che hanno dai quaranta ai cinquant’anni (come Erin O’Connor), a rappresentare al meglio quella filosofia Prada che oggi sembra aver trovato un nuovo equilibrio nella collaborazione fra i due designer, amici e colleghi.
E poi c’è Alessandro Michele, che ha voluto tornare a Milano per questa stagione con uno show bombastico che riassumeva tutti i motivi che l’hanno reso oggi lo stilista italiano più popolare e pop della nostra epoca, come ha suggellato la bella intervista a Che tempo che fa, raro momento in cui alla moda viene riservato un posto d’onore nella trita televisione pubblica. In una sala di specchi che incitava le vertigini, Michele ha presentato la sua nuova collaborazione, con adidas, e ridisegnato ancora una volta il suo universo di piccole, grandi cose preziose, tra cappellini con doppia visiera, bustini ricavati da quella che doveva essere una tuta, inediti abiti da sposa in nero a tre strisce e veli che passano dagli uomini alle donne, indistintamente, perché lui, come ha detto in conferenza stampa, l’etichetta del “gender-fluid” l’ha scoperta dagli altri: per Alessandro Michele ci sono solo le persone, e le loro tante, sfaccettate, identità. Dopo questi giorni intensi, ora il testimone passa a Parigi: continueremo a vedere sfilate e aggiornamenti sulla guerra nei nostri feed social, e continueremo a sentirci dissociati, in attesa di capire come sbrogliare la matassa digitale delle informazioni che consumiamo ogni giorno.

Il weekend lungo dedicato alle collezioni maschili, sempre più ristretto e sempre meno affollato, racconta bene la bizzarra situazione della moda oggi, che sembra non voler più lanciare grandi messaggi ma nascondersi nei vestiti che produce. Segno di tempi complicati o irrilevanza?

I Guest Designer di questa edizione – Homme Plissé Issey Miyake, Niccolò Pasqualetti e Post Archive Faction – sono tre diversi esempi di come oggi i marchi, sia quelli con un heritage alle spalle che quelli di nuova generazione, provano a raccontarsi in un panorama sempre più difficile.