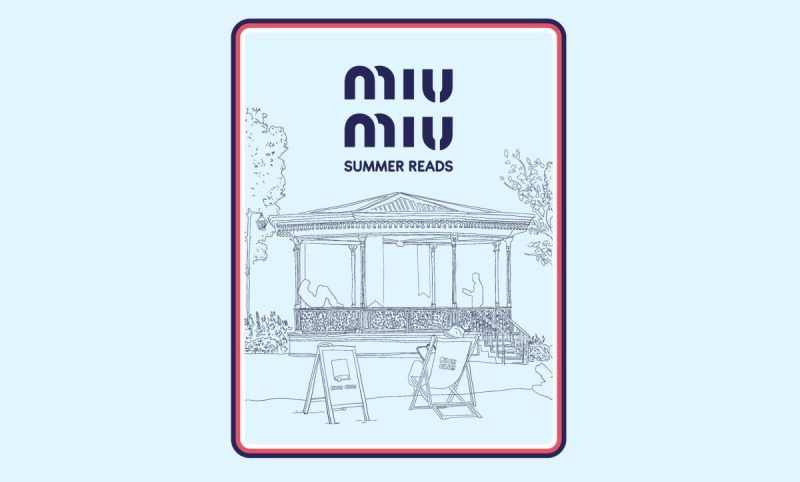Dopo le riuscite campagne di marketing dell’ultimo settimana, lo stilista nordirlandese ha fatto il suo debutto da Direttore creativo con una collezione che setta l’inizio del nuovo corso alla sua maniera.
Milano Moda Donne
Cormio, Garbagecore e Adriana Hot Couture: tre marchi, due designer e un collettivo, tre visioni della moda (e di Milano) completamente diverse fra loro. Sono tra le cose più interessanti al momento e un ottimo punto di osservazione sulla città e il suo sistema.

Inizio con una precisazione. L’idea di raccontare tre marchi diversi, o meglio ancora tre storie legate alla moda diverse, e di intitolare il pezzo “Milano Moda Donne” non è un modo per riempire delle pagine con vicende necessariamente “femminili”, obbligandoci a quell’idea di politicamente corretto che terrorizza oggigiorno gli editor delle riviste – “non ci sono donne”, “non ci sono neri”, “non ci sono asiatici”– quanto piuttosto il tentativo di presentare tre delle cose più interessanti che succedono di questi tempi nella capitale della moda italiana. E succede che queste cose le facciano delle donne, incidentalmente, e che tutte facciano vestiti per donne, anche, ma alla fine quei vestiti se li può mettere un po’ chi vuole. La pedanteria è perciò necessaria, per meglio sgomberare il campo e lasciare lo spazio giusto a quelle storie, e alle loro protagoniste. Dopo più di un anno di pandemia, ripensare ai rituali della moda fa quasi un po’ strano, con le ultime sfilate del febbraio 2020 sfocate in un ricordo ormai lontano, soppiantato da una serie di fashion week “digitali” che ci hanno regalato tempi sicuramente più rilassati, meno assembramenti e psicologia futile da prime file, qualche progetto degno di nota, ma anche una grande sensazione di stanchezza. Soffermarsi su quanto di nuovo è nato in città negli ultimi anni, perché qualcosa è nato, può servire allora a ritrovare un certo senso delle cose, e allo stesso tempo a guardare in prospettiva a quelle strutture che Milano, e la moda fatta a Milano, la tengono in piedi. Chiacchierando con Jezabelle Cormio di Cormio, Giuditta Testa di Garbagecore e Adriana (spiegherò poi) di Adriana Hot Couture, la sensazione immediata è che chi oggi decide di lanciarsi nell’incauta avventura di avviare un marchio di moda in Italia, sappia già di non avere un percorso tracciato da seguire, o meglio, che quel percorso è quasi impossibile da seguire pedissequamente, e che alla fine si dovrà fare come si può, ma anche un po’ come si vuole. Ma andiamo con ordine.
Jezabelle ha trent’anni ed è cresciuta a Roma, ha studiato alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa, dove per la prima volta ha dato forma a quello che poi sarebbe diventato Cormio, la cui prima espressione embrionale risale almeno al 2013, quando Humberto Leon e Carol Lim, all’epoca direttori creativi di Opening Ceremony, la scelgono insieme ad altri due studenti per sviluppare una collezione per il loro marchio. Vari progetti e quattro collezioni complete alle spalle, l’ultima uscirà quando questo giornale sarà in edicola, oggi Cormio è una di quelle cose che – esattamente come Garbagecore e Adriana Hot Couture, coincidenza curiosa ma forse no – conoscono e apprezzano più all’estero che qui da noi. Buyer e giornalisti che hanno l’occhio per il nuovo l’hanno notato da un po’, questo marchio che ha al centro della sua estetica, almeno finora, una bizzarra fascinazione per il folklore tirolese, che poi è un modo di indagare le fissazioni borghesi tipiche degli italiani. Quando le chiedo che idea si è fatta di Milano, e di Milano che produce moda nello specifico, le viene naturale il paragone con Anversa, che anche non è certo perfetta: «Anversa è uno spazio che è abituato a ricevere idee, a masticarle, a celebrarle. Se hai studiato moda ad Anversa e fondi il tuo piccolo brand, nessuno ti chiede “come mai hai lanciato il tuo brand?”, perché è ovvio. Perché no! Mentre in Italia è una domanda che ti fanno sempre, e non è neanche una domanda stupida, perché la competizione qui a Milano è pesante e molto spesso bisogna confrontarsi con brand molto grandi, anche solo per trovare i talenti con cui lavorare, modelle, stylist, fotografi. Credo che qui ci sia un approccio verso i brand indipendenti che è un po’ “out of touch” con le reali difficoltà che un piccolo marchio si trova ad affrontare, e parlo delle aspettative dei fotografi, delle agenzie di modelle, dei fornitori», spiega. E ha ragione, perché se siamo tutti consapevoli del problema sistemico della città, che è rimasta cristallizzata alla grande stagione che l’ha resa quella di oggi, è vero anche che certi meccanismi, e certe impalcature, sono fermamente inchiodate non solo nelle istituzioni e in chi le presiede, ma anche in tutti quelli che ci lavorano, non importa l’età anagrafica, perché è così che si fa. Certo, diventa un problema secondario quando lo si inquadra nel quadro più generale, e ovvero quella della difficoltà di fare imprenditoria in Italia, tanto più se sei giovane.
Visualizza questo post su Instagram
Farsi riconoscere se si fanno le cose in modo diverso dal seminato, anche se quel seminato è impossibile da praticare, non è mai facile nel nostro Paese: «Quello che ho notato è che il mio progetto, non so se per la sua estetica o per il mio modo di presentarlo su Instagram, ha iniziato a ricevere attenzione prima all’estero che in Italia. Mi ritrovo in una sorta di comunità che è ancora ritenuta underground, ma non underground nel senso di “alternativa”, quanto nel fatto che non riesce proprio a emergere, perché probabilmente esprime delle cose che non sono tanto in linea con la città», dice Giuditta Testa, classe 1994, che ha studiato Fashion Design alla Naba di Milano e si è laureata nel 2017 con un progetto di tesi che poi è diventato il suo, di marchio, e cioè Garbagecore, lanciato a tutti gli effetti nel marzo del 2019. «Il problema principale rimane quello dei mezzi economici, perché arrivi a un punto in cui avresti bisogno di fare il salto e quella è la parte più difficile. Credo poi che la cosa che mi è mancata molto è avere un mentore, una persona che abbia più esperienza di te [nell’industria, nda] ma che allo stesso tempo abbia una visione, che riesca cioè a comprendere come qualcuno di una generazione più giovane guarda al futuro», spiega. Testa lavora solo con tessuti usati e ha messo al centro del suo processo creativo la pratica dell’upcycling, per cui ogni suo capo è un pezzo unico, cosa che le ha permesso di costruire intorno a Garbagecore una community online di clienti interessati a un’esperienza d’acquisto differente, per i quali la sostenibilità è un fattore fondamentale. A guardare le previsioni sulle abitudini di consumo, è certamente uno dei trend più importanti per il futuro prossimo ed è interessante che un marchio italiano stia provando a ridisegnare il made in Italy secondo quella sensibilità: «Lavorando molto con compratori esteri, mi sono accorta che esiste ancora il fascino del fatto in Italia: sottolineare che si tratta di pezzi unici, fatti a mano e fatti a Milano, ha ancora la sua attrattiva». E meno male, a dirla tutta.
Visualizza questo post su Instagram
Non sembra tanto italiana ma sicuramente un po’ milanese lo è, invece, Adriana che, come mi scrive via mail, fa parte anche lei, anzi ne è l’espressione mononima, del collettivo Mindstream composto da Elisa Zaccanti, Bianca Luini e Greta Gerardi, che tutte insieme danno vita ad Adriana Hot Couture. Il primo post su Instagram di Adriana è del marzo 2016, oggi il suo account ha più quasi 23.000 followers e tra i suoi clienti ci sono, mi scrive, «Sita Abellan, Miley Cyrus, Jared Leto e Rihanna, che hanno indossato i nostri pezzi e che per noi rappresentano un po’ il cliente tipo», ovvero tutti coloro che si sento attratti da quell’estetica «che è sempre un equilibrio strano tra trash, “puccioso” e underground». Vestivano Adriana Hot Couture “Le ragazze di Porta Venezia” di M¥SS KETA e il carro più colorato e divertente del Gay Pride nel luglio 2019, l’ultimo prima del Covid-19, quando a Milano si poteva ancora fare festa. A rendere interessante il progetto di Adriana è il modo in cui ha scomposto, anche lei, le parti che tradizionalmente compongono un brand di moda, che non era poi l’obiettivo che si è posta quando ha dato il via al progetto: «Ho conosciuto Elisa Zaccanti anni fa, lei in quegli anni lavorava da Vogue Italia e le piaceva come mi vestivo, avevo sempre robe strane e ha scoperto che me le facevo io. Così abbiamo iniziato a collaborare per i suoi servizi fotografici. Ci vedevamo con i moodboard e iniziavamo a ragionare sugli accessori che potevo creare in base alla storia. Siamo partite dagli accessori perché quella era l’unica zona dove eravamo abbastanza libere. Quando sono usciti i primi pezzi serviva un nome per i crediti del giornale e cosi è nato “Adriana Hot Couture”. Poi abbiamo iniziato a collaborare sempre più spesso anche se in realtà per noi era un gioco, avevamo la stessa visione e ci piaceva fare cose insieme».
La volontà di sfuggire alle dinamiche del “perché si fa così” cui si accennava prima – «Ci piace fare quello che vogliamo, quando vogliamo e senza essere schiave di nessun sistema» – la dice lunga su quale siano gli ostacoli cronici che il nuovo incontra a Milano, e il mix di styling, celebrity culture e utilizzo di Instagram di Adriana è qualcosa che se fosse fuori dall’Italia, beh, meno male che grazie a internet si può essere ovunque e da nessuna parte. Anche se Instagram è vecchio, mi scrive sempre Adriana, perché oggi i giusti stanno su OnlyFans e Twitch, così come sono vecchi i magazine di moda (concordo), ha dato la possibilità a tutti e tre questi marchi di costruire la propria nicchia di appassionati e farsi strada anche senza tutto il carrozzone che siamo abituati ad associare alla moda. «La ragione per la quale io mi immagino le mie collezioni sulle nostre clienti, almeno su quelle che conosco, e ne conosco sempre di nuove perché magari ci taggano su Instagram, è perché so che si tratta di donne intelligenti e so che possiamo giocare insieme. Sapendo che tu sei una donna intelligente io come designer posso metterti un vestito da bambolina, per fare un esempio (e lasciami usare questo termine che io oramai non disprezzo più), e possiamo divertirci con complicità», dice infatti Jezabelle. Milano ci senti?

Il weekend lungo dedicato alle collezioni maschili, sempre più ristretto e sempre meno affollato, racconta bene la bizzarra situazione della moda oggi, che sembra non voler più lanciare grandi messaggi ma nascondersi nei vestiti che produce. Segno di tempi complicati o irrilevanza?

I Guest Designer di questa edizione – Homme Plissé Issey Miyake, Niccolò Pasqualetti e Post Archive Faction – sono tre diversi esempi di come oggi i marchi, sia quelli con un heritage alle spalle che quelli di nuova generazione, provano a raccontarsi in un panorama sempre più difficile.