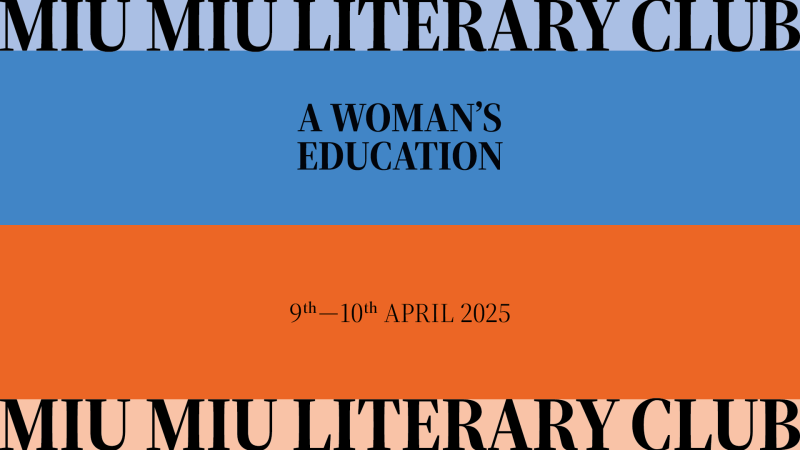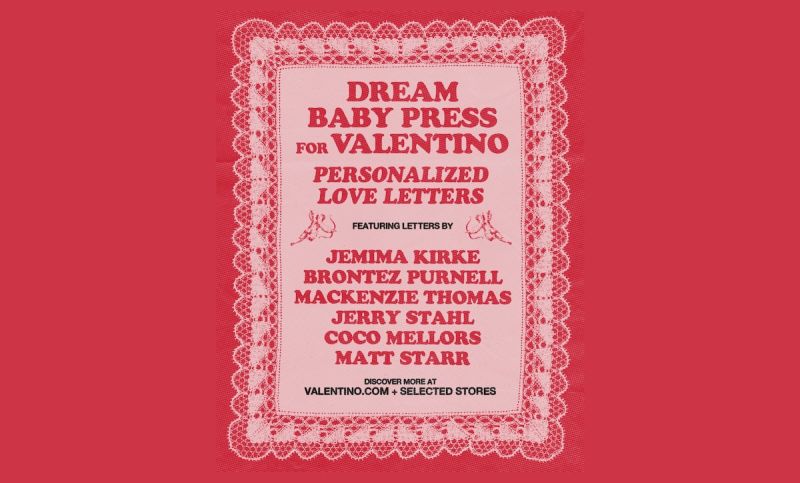Le riviste di moda tra politica e pandemia
La notizia delle dimissioni di Alexi McCammond da Teen Vogue a causa di una serie di tweet razzisti è solo un altro tassello del complicato tentativo da parte dell’editoria di riemergere da una crisi profonda.

Per qualche giorno Anna Wintour e tutta la Condé Nast hanno difeso la loro scelta. Ma tenere il punto su Alexi McCammond, ventisettenne ex giornalista di Axios scelta per guidare Teen Vogue dopo la dipartita di Lindsay Peoples Wagner, a un certo punto è diventato impossibile. La nomina di fine febbraio è stata seguita da accuse di razzismo a causa di una serie di tweet rivolti contro le persone di origine asiatica pubblicati dieci anni fa, quando McCammond era un’adolescente, già riesumati nel 2019 e per i quali aveva chiesto scusa in quella sede. Quelle affermazioni sono tornate al centro della scena, anche perché la decisione della casa editrice è arrivata quasi contemporaneamente alle sparatorie di Atlanta, durante le quali sono state uccise otto persone, di cui almeno sei erano donne asiatiche (con sospetto movente razziale). Non sono bastate le rinnovate scuse di McCammond e il pubblico annuncio in cui la direttrice di Vogue spiega di essere a conoscenza dei tweet e di aver valutato insieme ad altri dirigenti dell’azienda che quelle scuse testimoniavano una maturazione della giovane giornalista. Perché nemmeno Anna può molto davanti alla cancel culture. Nel giro di poche settimane venti membri dello staff della rivista hanno pubblicato una nota di dissenso, il brand Ulta Beauty ha sospeso un mega investimento stagionale e l’account Instagram del magazine è stato invaso dalle critiche sulla falsariga di quella dell’attivista Xiye Bastida: «Teen Vogue ha fatto così tanto per dare spazio a voci diverse, non buttate via tutto per Alexi!».
Se in Italia non abbiamo ancora trovato il modo giusto di affrontare il tema applicandolo alla nostra realtà, il dibattito in America è accesissimo: pur essendo Teen Vogue un titolo relativamente piccolo, si è distinto negli anni per un atteggiamento progressista e attivista che è riuscito a fare presa sulla Generazione Z, con il conseguente aumento dei ricavi grazie a nuovi accordi pubblicitari e all’evento Teen Vogue Summit, tra i più interessanti del panorama in termini di ospiti e di temi affrontati, ma anche una grande attenzione sui suoi contenuti e sulle persone che li producono. Se McCammond avesse le carte in regola per guidare una delle poche testate tradizionali che provano a rivolgersi a un pubblico di giovanissimi (con il budget giusto per essere influente) non è dato saperlo perché il tornado è arrivato nel momento, anzi nell’anno, sbagliato. La pandemia ha congelato gli investimenti pubblicitari dell’intero settore – con un taglio fino all’80 per cento e un non determinante rimbalzo nella seconda metà del 2020, come riporta l’agenzia Digital Luxury Group – proprio quando questo sperava che il maggiore impiego economico in nuovi formati digitali restituisse i primi frutti. Invece raggruppamento del personale e condivisione dei contenuti sono i nuovi mantra. Alla fine del 2020 Condé Nast ha annunciato una grande ristrutturazione internazionale che ha messo quasi tutto il potere in mano alla sede americana e ha reso le testate degli altri Paesi molto più dipendenti da quella centrale. Non solo Wintour è stata nominata direttore editoriale globale di Vogue, ma Edward Enninful, dal 2017 direttore dell’edizione britannica e da molti ritenuti il naturale erede della direttrice, ha guadagnato il titolo di “supervisore” editoriale di Vogue Paris, diretto da Emmanuelle Alt, e di Vogue Italia, diretto da Emanuele Farneti.
Intanto si è deciso per l’uscita di altre due direttrici europee, Christiane Arp di Vogue Germany e Eugenia de la Torriente di Vogue Spain, oltre che la riduzione della frequenza di molte testate del gruppo e una centralizzazione anche del ruolo di amministratore delegato. Ma, soprattutto, con la nuova organizzazione le varie testate prevedono condivisione di una fetta dei contenuti, a cominciare dalle recensioni delle sfilate, ora scritte da un solo giornalista per tutte le testate con buona pace della casta di penne che ha dominato i giudizi sulle collezioni negli ultimi anni. E a una serie di servizi fotografici e pezzi prodotti per i numeri speciali e unificati, come quello sulla creatività di questo marzo.
Ultima in ordine cronologico è arrivata la nomina di Margaret Zhang, ventisettenne influencer di madrelingua inglese, oggi direttrice di Vogue China al posto della storica Angelica Cheung (ora Strategic Advisor di Ermenegildo Zegna, ma quella dei giornalisti che passano dall’editoria alla consulenza aziendale è un’altra storia). C’è chi sostiene che la Zhang sia stata scelta più per le sue attività di consulenza in fatto strategie di espansione sul territorio e per la sua vicinanza al team newyorkese, più che per la reale presa sul pubblico cinese. Su Weibo, infatti, ha solo 30.000 follower, contro il milione di Instagram.
In questo contesto di ristrutturazione le accuse di insensibilità alle questioni razziali nei confronti della casa editrice hanno fatto tanti danni quanti il virus. A giugno scorso, quando l’omicidio di George Floyd ha scatenato una nuova ondata di proteste del movimento Black Lives Matter, proprio Anna Wintour era stata travolta da un’andata di critiche per la poca diversità all’interno dei suoi team. La sua sedia ha tremato, e molto, ma a differenza di quella di altri (come il direttore di Bon Appétit, Adam Rapoport) non è caduta e lei ha promesso di impegnarsi in un profondo cambiamento. A marzo è arrivato il primo report aziendale dei dipendenti americani di Condé Nast: il 68 per cento è bianco, il 10 per cento asiatico, il 7,5 per cento nero e il 5,5 per cento latino; tra i redattori in capo il 54 per cento è bianco, il 15 per cento asiatico, il 15 per cento nero e il 15 per cento multirazziale; tra i dirigenti senior il 77 per cento è bianco, il 10 per cento asiatico, il 5,5 per cento nero e il 3 per cento latino. Ma questo è solo un inizio e una recente inchiesta del New York Times racconta che, se in termini di immagine i magazine di moda oggi sono decisamente più inclusivi, le redazioni non lo sono affatto. E il tentativo di assunzione di McCammond è solo un piccolo pezzo di un processo difficile e lento, che rischia di non salvare Condé Nast in tempo.
Ma non si lavora a questo processo difficile e lento sono negli uffici di Vogue, Teen Vogue, Vanity Fair e Gq: anche altrove si fanno dei tentativi. Come quelli di Samira Nasr, neo direttrice della versione americana di Harper’s Bazaar (Hearst), e di Lindsay Peoples Wagner, che ha lasciato Teen Vogue per tornare a The Cut, il verticale del New York Magazine (oggi di proprietà di Vox Media) con focus su moda e beauty che è passato da 2,2 milioni di utenti unici mensili nel 2012 ai 14 milioni nel 2020. I cambiamenti apportati dalla prima sono visibili dal numero di marzo, il primo in pieno restyling, con Megan Thee Stallion in versione (quasi) naturale sulla copertina e tutta una serie di nuove rubriche che provano a conciliare la moda con il mondo dell’arte, della cultura e della politica piuttosto che presentarla come un catalogo di shopping di lusso. E attraverso i contenuti dell’account Instagram e le interviste di Nasr, incentrati sulla ricerca di un contatto diretto con le lettrici della rivista di moda più antica. Se per la primavera estate 2021 tornano di tendenza gli zoccoli, ora la proposta di Hermès è fotografata, sì, ma è abbinata alla storia sulla chef Alex Raij, immortalata nel suo paio di Dansko. Wagner, invece, che lo scorso giugno ha co-fondato l’associazione Black in Fashion Council e in pochi mesi è riuscita a collaborare con tutte le grandi aziende di settore americane, da Capri Holdings a PVH, da L’Oreal e IMG, per dare più opportunità di leadership ai professionisti afroamericani, ha esordito con un tributo a Breonna Taylor, la giovane afroamericana uccisa nella sua casa il 13 marzo 2020 durante una perquisizione. Con lei The Cut mira a espandersi tra gli inserzionisti del lusso, quelli che oggi chiedono formati innovativi e capacità di parlare in maniera inclusiva.
Ma questa non è una sfida solo americana. Anche le tre riviste più celebri del panorama britannico si stanno muovendo per evolversi, sia in termini di rappresentazione che di modelli di business. Da una parte c’è Dazed&Confused che ha nominato direttore Ibrahim Kamara, stylist nato in Sierra Leone e ora richiestissimo da tutto i grandi brand tra cui Louis Vuitton di Virgil Abloh, per cui Kamara ha curato la presentazione digitale Autunno Inverno 2021. Il suo obiettivo da Dazed sarà quello di «non guardare a Londra, New York e Loa Angeles come i soli centri della cultura». Dopo un round di licenziamenti il magazine di Jefferson Hack sta anche compiendo grossi sforzi per aumentare il suo traffico mensile online e rinnovando gli uffici per inaugurare un co-working creativo dopo la pandemia. Quindi c’è i-D: rinforzato da ulteriori risorse dopo che la casa editrice Vice Media ha cessato il rapporto con Garage, sta sperimentando con un formato in potenziale crescita, quello delle zine sponsorizzate. Infine, The Face, tornato sulla scena nel 2019 come testata digitale affiancata da una talent agency con focus su TikTok, che offre anche consulenze ai marchi per approcciarsi ad azioni di marketing sull’app. Il tutto mentre il modo di informarsi delle persone si modifica, forse per sempre, tra gruppi Facebook che diventano il punto di riferimento, come High Fashion Talk, che abbiamo raccontato sull’ultimo numero di Rivista Studio, e giornalisti che diventano creator digitali con strutturati piani di business, tra i quali proprio l’ex Teen Vogue Philip Picardi, ora autore della newsletter a pagamento Fruity. La domanda che resta da porsi rimane una sola, però: quando è troppo tardi per chiedere scusa?