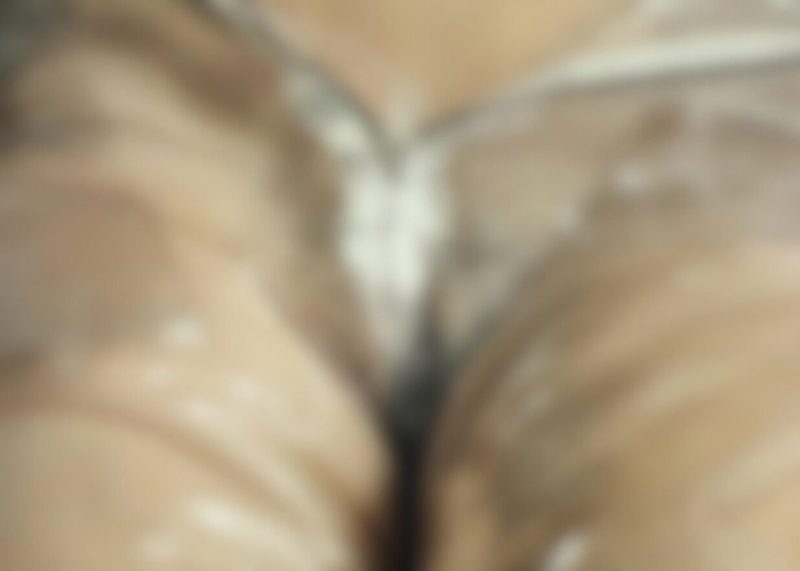Prende ispirazione da una giacca cult indossata da Liam, quella di Berghaus, di cui è volto pubblicitario.
La resurrezione di Demi Moore come attrice di culto
Per tutta la sua carriera è stata considerata una popcorn actress, come ha raccontato nel discorso dopo la vittoria del Golden Globe. Adesso, grazie a The Substance, per lei è cambiato tutto.

«La rivincita di Demi Moore»: ecco qual è il titolo più abusato dalle testate italiane dopo il trionfo dell’attrice all’ultima edizione dei Golden Globe per la sua interpretazione in The Substance di Coralie Fargeat. La rivincita di una popcorn actress, come lei stessa ha raccontato di essere stata definita da un produttore nell’acceptance speech già divenuto a tutti gli effetti il manifesto dei sottovalutati. Emma Specter su Vogue US chiarisce che «un popcorn film è un film misurato in base al suo valore di intrattenimento e agli incassi al botteghino più che sulla sua accoglienza critica o al contributo al discorso filmico; una popcorn actress è appunto colei che tende a recitare in quella tipologia di film». Moore, dal canto suo, è stata una delle star più redditizie degli anni ’90, con all’attivo titoli come Ghost, Codice d’onore, Proposta indecente, Striptease, Soldato Jane: la prima domanda da porsi sarebbe se è oggettivamente una cosa negativa essere una popcorn actress (no, non lo è), ma forse non è nemmeno questo il punto.
Per chi è stata teenager proprio negli anni ’90, Moore ha rappresentato un benchmark estetico e in un certo senso culturale, nonché una precorritrice in tempi non sospetti di mode e movimenti che avrebbero successivamente influenzato in modo irreversibile lo zeitgeist. Partendo dal taglio di capelli a scodella sfoggiato in Ghost che tutte abbiamo provato a imitare salvo scoprire quando ormai era troppo tardi che stava bene soltanto a lei; passando per la citazione di Proposta indecente – «Se ami una persona, lasciala andare. Se torna da te è tua per sempre, se non lo fa non è mai stata tua» – che compariva puntualmente su qualsiasi Smemoranda di qualsivoglia liceale; arrivando alla tigna della Tenente Jordan O’Neill di Soldato Jane, che con la sua testa rasata a zero (di nuovo, solo lei poteva osare tanto) ci convinceva che non siamo da meno degli uomini nemmeno in una trincea col fango fino alle ginocchia.
Naturalmente bella, naturalmente sexy, così naturale da risultare quasi insolente e sfacciata: la chioma lunga e lucente, il corpo scolpito, le labbra perfette e il sorriso altrettanto perfetto si trasformano in una macchina da soldi che non si concede alle derive intellettuali e al cinema d’autore. Lei non se ne fa un cruccio e continua per la sua strada, forte anche di un matrimonio con l’allora re del box office, Bruce Willis, uno che però – a differenza della moglie – si è goduto un paio di incursioni nel cinema d’autore americano (Pulp Fiction e Il sesto senso) che hanno contribuito a consolidarne ancora di più la carriera.
La fine del matrimonio con Willis, nel 2000, per Moore coincide con l’inizio del declino professionale: curioso, se si pensa che la sua controparte dell’epoca, Julia Roberts, più o meno nello stesso periodo intraprende una parabola esattamente opposta grazie a Erin Brockovich – Forte come la verità, che la spoglia dei panni di Cenerentola e la fa uscire dalla gabbia della commedia romantica. Soderbergh, Nichols, Clooney, Verbinsky, Esmail e Ross catapultano Roberts nell’Olimpo di Hollywood e le permettono di acquisire – oltre a Oscar, Golden Globe e Bafta – lo status più ambito, ossia quello dell’attrice che può permettersi di fare qualunque cosa, boiate incluse, e di restare sempre e comunque una grande attrice.
Chissà quanto questo c’entra con la grazia innata, magnetica e l’allure multiforme di Roberts, che pare cresciuta a pane e glamour sin dagli esordi e che è totalmente priva di quella patina vagamente redneck e sfrontata che invece sembra portarsi dietro Moore. La quale, anziché inseguire il plauso della critica, preferisce inseguire l’amore: nel 2003 inizia la relazione con Ashton Kutcher, all’epoca un piccolo scandalo per via della differenza d’età tra i due, e da popcorn actress si trasforma nell’antesignana delle Milf. Lo stesso anno esce Charlie’s Angels – Più che mai, secondo sfortunatissimo capitolo a cui fanno seguito film dimenticabili e (giustamente) dimenticati, la separazione da Kutcher nel 2011 e poi l’oblio.
Il taglio a scodella viene ricordato in qualche sporadico articolo di costume; la citazione sugli amori che vanno lasciati liberi comincia a puzzare di patriarcato; per competere con gli uomini abbiamo capito che non è più necessario raparsi a zero: è la fine del moorismo per come lo conosciamo, e la diva che ci aveva insegnato le regole del desiderio non tiene il passo con colleghe non più brave ma più furbe, meno facilmente etichettabili. «Qualche anno fa ho pensato che fosse finita, forse ero completa, forse avevo fatto ciò che dovevo fare. E mentre ero in questo momento di crisi, sulla mia scrivania è arrivata questa sceneggiatura magica, audace, coraggiosa, fuori dagli schemi, assolutamente folle, intitolata The Substance. E l’universo mi ha detto “non hai finito”».
Coralie Fargeat, non a caso una donna, non a caso non americana, la sceglie per un film dove le sue vicende personali e professionali s’intrecciano al limite dell’autobiografico con la storia della protagonista: presentato in anteprima allo scorso Festival di Cannes, The Substance riceve un’ovazione di ben tredici minuti e stavolta pubblico e critica sono compatti. Sì, abbiamo di fronte un’opera debordante, esagerata, spericolata, pronta a divenire un cult, e sì, l’interpretazione di Demi Moore è, appunto, da premio: la sua Elisabeth Sparkle parla alle donne delle loro paure, raccontando attraverso metafore, citazioni, corpi nudi ed ettolitri di sangue quanto è mostruoso invecchiare inseguendo a tutti i costi la bellezza perduta.
Nessuno avrebbe potuto essere più credibile di Moore nel ruolo di Sparkle, e la vittoria del suo primo grande riconoscimento in 45 anni di carriera ne è la conferma. Lei, in un Armani platino che la rendeva ancora più radiosa, ai Golden Globe ha incantato la platea con un discorso che da solo avrebbe meritato un premio e che si è concluso con una delle espressioni anglosassoni più belle e difficilmente traducibili, «I do belong»: «appartengo», «merito di essere qui», «è questo il mio posto».
Nuovamente, curioso che nella categoria Migliore attrice in un film drammatico concorressero assieme a Moore anche Nicole Kidman (per Babygirl di Halina Reijn) e Pamela Anderson (per The Last Showgirl di Gia Coppola), altre due attrici che stanno vivendo un personale rinascimento, sfidando l’antichissima legge hollywoodiana secondo la quale la carriera di un’attrice non può durare oltre i 50 anni (lo dice, esplicitamente, il personaggio interpretato da Dennis Quaid proprio in The Substance). Kidman, ormai icona del cinema, è una brillante Ceo che decide di abbracciare le proprie pulsioni e di farsi volutamente umiliare e dominare sessualmente da uno stagista trent’anni più giovane. Anderson, sogno erotico di un’intera generazione, è una ballerina di Las Vegas che si ritrova a un bivio inaspettato quando lo spettacolo in cui ha lavorato per trent’anni chiude improvvisamente. Tre film, tre registe e tre attrici in quelli che, a detta di tutti, sono i tre ruoli della vita: e non è forse questa un’ulteriore riprova del fatto che they do belong?
Foto in copertina: Stefano Rellandini, AFP via Getty Images