Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.
La democrazia è sopravvalutata?
L'elezione di Trump, la Brexit, i populismi: il suffragio universale sta creando mostri. Un libro molto attuale propone di modificarlo.

Della democrazia Winston Churchill diceva quello che alcune comari di paese dicono dell’invecchiare: è una gran brutta cosa, però è sempre meglio dell’alternativa. Siamo talmente abituati a dare per scontato la superiorità del modello democratico – quel sistema che prevede che la scelta dei leader di un governo spetti al popolo tutto, attraverso il suffragio universale, magari controbilanciato da istituzioni che evitino che la volontà popolare possa trasformarsi in dittatura della maggioranza: costituzioni, indipendenza del potere giudiziario, eccetera – siamo talmente convinti del valore intrinseco della democrazia, si diceva, che abbiamo quasi smesso di ragionarci sopra e chiederci da dove arrivi questa convinzione. Recentemente un giovane filosofo della Georgetown University, Jason Brennan, ha pubblicato un saggio contro la democrazia. Il libro, Against Democracy (Princeton University Press), è uscito a gennaio, però sulla stampa americana se n’è parlato soprattutto in questi ultimi giorni: sospetto c’entri qualcosa con l’elezione di Donald Trump, o con il timore precedente che potesse vincere.
Gli elettori, è stato detto, sono capaci di decisioni scellerate, rovinose per se stessi e per il loro Paese. In Europa lo si era già visto con la Brexit, e c’è chi teme di rivederlo in Francia, dove si vocifera di una possibile vittoria di Marine Le Pen. Non sarebbe più assennato, allora, delegare l’elezione dei governanti soltanto a chi possiede gli strumenti per fare scelte più giuste, razionali e produttive? Non è mancato chi, imperturbabile davanti ai pericoli della reductio ad hitlerum, ha tirato in ballo la vecchia storia di Hitler, che anche-lui-è-stato-eletto. Per colpa del popolo bue, il mondo rischia di andare a rotoli: forse la democrazia è sopravvalutata. In questo filone di ragionamenti post-trumpiani, s’inseriscono bene le tesi di Brennan, che suggerisce di rimpiazzare il suffragio universale con un sistema dove a decidere siano le persone più intelligenti e preparate: facciamo votare solo i cittadini più istruiti, o facciamo in modo che il loro voto conti di più.

La tentazione sarebbe chiudere la questione come una provocazione gratuita e contraria al comune senso della decenza, oppure contrapponendo osservazioni empiriche ispirate alla storia recente e alla politica contemporanea. Va bene, il suffragio universale produce dei mostri e continuerà a produrne con effetti catastrofici, ma quale sarebbe l’alternativa? Il comunismo, le dittature militari, le monarchie assolute, l’apartheid e le post-democrazie le abbiamo già provate tutte: non è che sia andata un granché bene (per quanto almeno due persone, all’indomani del voto americano, mi abbiano fatto notare che «a Singapore non si sta poi così male»). Come diceva il sopracitato Churchill «la democrazia è la peggior forma di governo possibile, eccezion fatta per tutte le altre», allora perché metterla in dubbio? Brennan però, quando critica questa forma di governo, non la paragona a «tutte le altre», cioè quelle già viste e bocciate, ma avanza l’ipotesi di un modello ideale non ancora sperimentato. La sua tesi sarà anche incompatibile con la bussola morale di molti, inclusa la mia, però il docente fa esattamente quello che i filosofi spesso fanno: prendere un’idea e testarla fino allo sfinimento, che è cosa ben diversa dal produrre soluzioni concrete. Cercare di risolvere problemi della società spesso richiede l’applicazione del buonsenso, criterio rispettabilissimo per quanto in via d’estinzione; sottoporre un concetto a un crash test intellettuale invece implica mettere il common sense in un cassetto, almeno per un po’.
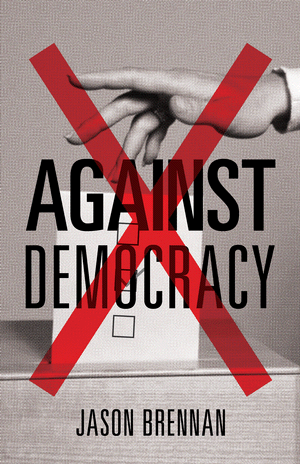 Brennan ragiona per sillogismi, ragionamenti concatenati astratti: è innegabile che alcuni siano più saggi di altri; contemporaneamente è innegabile che gli stupidi tendano a provocare danni alla comunità con le loro scelte politiche; ne consegue che gli idioti e gli ignoranti vanno arginati, dunque limitare il loro accesso alle urne è nell’interesse della comunità. A chi obietta che nella nostra cultura il voto è considerato un diritto inalienabile, qualcosa d’inestricabile dal nostro sentimento di dignità e giustizia, l’autore risponde che sono valori relativi: un tempo gli indigeni della Papuasia associavano il rispetto per i morti al mangiare le loro carni. Brennan propone dunque di stabilire un sistema di “governo dei bene informati,” riprendendo spunti da Platone e John Stuart Mill, senza però soffermarsi molto su come implementarla. Magari, ipotizza, si può concedere alle persone meritevoli di votare due o tre volte, oppure istituire un consiglio di saggi con il diritto di veto, o ancora introdurre un test per ottenere il diritto di voto: l’importante, dice, è limitare il potere degli ignoranti, e anche degli hooligan, quelli che seguono la politica a mo’ di tifoseria calcistica.
Brennan ragiona per sillogismi, ragionamenti concatenati astratti: è innegabile che alcuni siano più saggi di altri; contemporaneamente è innegabile che gli stupidi tendano a provocare danni alla comunità con le loro scelte politiche; ne consegue che gli idioti e gli ignoranti vanno arginati, dunque limitare il loro accesso alle urne è nell’interesse della comunità. A chi obietta che nella nostra cultura il voto è considerato un diritto inalienabile, qualcosa d’inestricabile dal nostro sentimento di dignità e giustizia, l’autore risponde che sono valori relativi: un tempo gli indigeni della Papuasia associavano il rispetto per i morti al mangiare le loro carni. Brennan propone dunque di stabilire un sistema di “governo dei bene informati,” riprendendo spunti da Platone e John Stuart Mill, senza però soffermarsi molto su come implementarla. Magari, ipotizza, si può concedere alle persone meritevoli di votare due o tre volte, oppure istituire un consiglio di saggi con il diritto di veto, o ancora introdurre un test per ottenere il diritto di voto: l’importante, dice, è limitare il potere degli ignoranti, e anche degli hooligan, quelli che seguono la politica a mo’ di tifoseria calcistica.
Contempla anche obiezioni, di carattere più empirico. C’è chi potrebbe dire un governo dei “governo dei bene informati,” categoria che spesso coincide con l’élite economica, permetterebbe loro di proteggere i loro interessi, a sfavore di quelli delle classi svantaggiate. Non per nulla quando le donne ancora non potevano votare, i loro diritti – giuridici, economici e in materia di salute – ne hanno sofferto non poco. Brennan ribatte che però spesso gli elettori non votano in base ai loro interessi personali, dunque i “bene informati” provvederebbero a proteggere i diritti dei loro concittadini peggio informati. Altri potrebbero obiettare che misure restrittive del voto sono state già applicate in passato con l’obiettivo preciso di mantenere in uno stato d’oppressione gruppi sgraditi: nel Sud degli Usa si effettuavano test per verificare la capacità di leggere e scrivere proprio per evitare il voto dei neri; in Italia, si potrebbe aggiungere, s’è applicato a lungo il voto censitario per evitare che i popolani, specie nel Meridione, alzassero troppo la testa. Brennan risponde che ci sarebbero modi di tutelare le minoranze diseredate, per esempio con delle quote di rappresentazione. Quando passa sul piano empirico l’autore diventa meno convincente: l’assunto che le élite non votano per preservare i propri interessi è tutto da verificare, e la veemenza con cui i gruppi al potere si sono battuti in passato per evitare che i disgraziati votassero né è una conferma (basta guardare Selma, raro caso di film brutto che racconta una storia bella). Però le corde che tocca, specie in un lettore italiano ed europeo, sono altre.

È da un po’ che ci ritroviamo a seguire con un certo disagio la retorica dell'”uno vale uno” dei movimenti populisti nostrani. Da un lato la convinzione che ogni cittadino abbia diritto a esprimere il suo voto con peso uguale, legata a criteri morali, a un senso profondo di giustizia, di fairness, e non soltanto di mera logica. Dall’altro un imbarazzo davanti all’idea sempre più diffusa, e ai limiti dell’abbrutimento, che quell’uno-vale-uno si estenda ben oltre le urne, che ogni opinione abbia valore uguale indipendentemente dal suo legame con la realtà: democrazia, in base a questa ossessione, non è solo il diritto universale al voto, ma anche il diritto universale a decidere se l’olio di palma fa male, o se i vaccini causano l’autismo, quasi la verità scientifica fosse una questione di maggioranza. È evidente che, se si parla di questioni mediche, l’opinione di un chirurgo e quella di un analfabeta di ritorno non possono avere la stessa dignità. Allora, verrebbe da pensare, perché è desiderabile che abbiano lo stesso peso il voto di chi di politica ne capisce e quello di chi invece non ne capisce? Messa così, per un momento le tesi di Against Democracy non sembrano più così slegate dal mondo reale. Soltanto per un momento, però. Perché esistono alcuni fatti e dati, assai reali, che dipingono un quadro assai diverso.
Brennan parte dal presupposto che i “bene informati” tendano a prendere decisioni migliori. Ora, in Europa s’è visto che non è sempre così. L’Unione europea, dicono i suoi critici e non soltanto loro, s’è a lungo affidata a tecnici, assai ben preparati ed eletti in modo indiretto, con un deficit di rappresentatività popolare; eppure non c’è bisogno di essere dei feroci euroscettici per rendersi conto che abbiano commesso errori gravissimi: Bruxelles non è quel che si dice un buono spot per la tecnocrazia. Che sia una massa di ignoranti a fare i peggiori danni in politica è una storia che ci raccontiamo spesso. Trump, ripetiamo, l’hanno votato i poveracci, quelli che non hanno studiato, la cosiddetta white trash. In realtà i sondaggi post-elettorali – per carità, da prendere con le pinze – hanno dimostrato che non c’è un divario d’istruzione tra gli elettori di Donald e quelli che hanno votato Hillary. La candidata Democrat è andata un po’ meglio con gli elettori dotati di un PhD, ma tra i laureati i due contendenti hanno ottenuto risultati simili. Qualcun altro ha fatto notare che sono soprattutto i genitori benestanti e istruiti a non vaccinare i figli per scelta. Brennan, certo, vorrebbe un governo dei “bene informati” e degli intelligenti, non un governo dei laureati, però ammette che uno dei modi più semplici per stabilire l’affidabilità intellettuale di un cittadino è guardare al suo livello d’istruzione. Quello che forse non coglie è che, quando si prende un ignorante e lo si manda all’università, solitamente ciò che si ottiene è un ignorante istruito.
Immagini Getty Images
Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.



