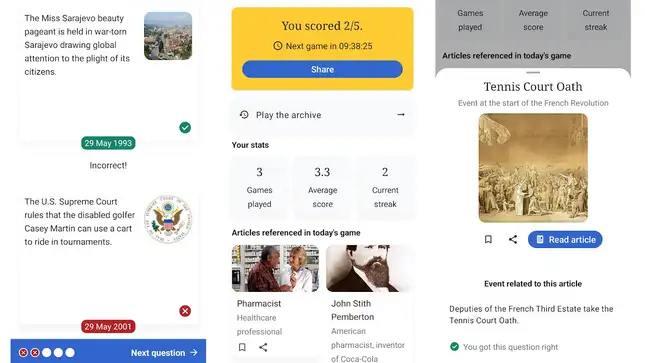Il piano era di proiettarlo nelle sale americane per tutto il mese di luglio, ma ovviamente qualcuno ne ha fatto un video con lo smartphone.
La rivincita dei Millennial su Clubhouse
Chi c'è e di cosa si parla sul social fatto solo di audio? Un resoconto personale.

Su Clubhouse ci sono solo milanesi. Salta subito agli occhi, o meglio alle orecchie, ravanando nell’app per la prima volta. Tutto un susseguirsi di accenti sbagliati che sembra quasi una lezione di lombardo standard. All’inizio lo spaesamento è totale, poco testo e niente immagini, momenti di paranoia “mi staranno mica sentendo?” e la stessa diffidenza neofobica che si notava in nonni o genitori poco avvezzi durante le Zoom call del primo lockdown. La popolazione dicevo è milanesissima, almeno per ora, con particolare focus su editoria, influencer vari ed eventuali, molta moda, molto commento politico, molti YouTuber. Può darsi però che anche qui sia già tutta una questione di bolle e che la colpa sia mia, che quando all’inizio, per darmi un tono, ho messo come miei interessi “knowledge”, “world affairs” e “arts” (che qui include un po’ tutto, dalla cucina alla moda alla pubblicità ai libri, in un grandissimo ma che ce frega) mi sono direttamente infilato nella solita combriccola di bocconiani di sinistra (senza offesa).
Forse c’entra anche l’atavica fascinazione milanese per la selezione all’ingresso, che in questo periodo di locali chiusi viene sublimata così. Non è infatti possibile iscriversi a Clubhouse come a qualsiasi altro social. Serve l’invito di qualcuno che è già dentro, un iniziato, oppure ci si può mettere in lista d’attesa finché qualche amico confermi il tuo esserne degno confermando il tuo essere una persona per bene e non un barbaro, un po’ come il famoso “lui è con me” in discoteca. E poi, naturalmente ,è disponibile solo su iOS. Forse la bolla me la merito, avrei dovuto puntare sul gruppo identity (Black, East Asian, Baby Boomer, Bipoc, Lgbtq+). L’entusiasmo comunque è palpabile. Oltre che per milanesi ci si accorge subito che il nuovo social di cui, ma soprattutto in cui, tutti parlano e che piace alla gente che piace non è posto per regazzini.
È invece luogo per splendidi e orgogliosi trentenni, che lo stanno arrembando come in adolescenza avrebbero occupato un liceo: tagliati fuori da TikTok, dove nelle competizioni vengono massacrati da adolescenti bellissimi, autoironici e capaci di performance coreutiche inimmaginabili, hanno trovato il riscatto su questa piattaforma di sola voce che non richiede né chiome né addominali. E infatti come al liceo okkupato ci tengono a rifuggire programmaticamente il cazzeggio e a ostentare impegno, approfondimenti e divulgazione con una solerzia che suona sospetta e a tratti disperata. Calendarizzano a rotta di collo: solo oggi nella mia lista di amici aggiunti un po’ a caso e un po’ per cortesia dimostrando un entusiasmo da setta ci sono delle room su “Come si formano i formatori?”, “Koreans welcome party” con inintelligibile descrizione in coreano, un panel su come promuovere il mio business (quale?), una sulla musica francese, una sull’influencer marketing, una per commentare i risultati del mandato esplorativo di Roberto Fico.
Ieri sera mi ero ripromesso di ascoltare “Politica italiana, parliamone” con Luis Sal e Nicola Porro ma all’ultimo non me la sono proprio sentita. Una questione al momento irrisolta riguarda il logo, che in effetti logo non è: piuttosto la foto in bianco e nero di un tizio sorridente che tiene in mano un basso o una chitarra, tizio che sarebbe potuto essere il tipico protagonista di uno spot Apple dei primi anni 2000. Forse scelto anche lui per fare breccia nel cuore dei trentenni, ricordando madeleine di iPod e appunto pomeriggi liceali. Chi è questo personaggio misterioso? Assurgerà a simbolo generazionale e memetico come un Tom di Myspace? Oppure ce ne dimenticheremo come finì con Google+? Ad ogni modo, quando si entra in una room la sensazione sta un po’ a metà tra un video ASMR domestico di YouTube, tipo quelli in cui guardi un influencer mangiare cibo croccante o scolarsi una ciotola gigante di noodles, e le lezioni dell’Università UniNettuno su Rai Notte in cui ci si imbatteva durante lo zapping notturno e insonne e prima dell’arrivo di Netflix. L’eloquio degli speaker è generalmente amichevole e, fatti salvi gli habitué dei video, dei podcast o della retorica unidirezionale come ad esempio i professori, amatoriale. Si nota l’incertezza dissimulata di qualcuno che si trova a prendere la parola per la prima volta a un consiglio d’istituto o a una riunione di condominio.
Certo spesso la mancanza di abitudine fiacca un po’ l’intrattenimento, e dati anche i numeri per ora molto limitati dei partecipanti ai consessi, di solito mai più di 20 per le room italiane senza celebrity, si passa da un inizio quasi istituzionale a una chiacchierata da tavolata estiva. Il ché non è male, anzi. A chi sta lì ad ascoltare senza intervenire può capitare di trovarsi in quella sensazione rassicurante che si prova quando dopo un pranzo coi parenti con nonchalance ci si sposta sul divano lasciandosi cullare da quel sottofondo di chiacchiere oziose e suoni di stoviglie. L’altra sera mentre ascoltavo dei teenager britannici discutere per più di un’ora della figura di Craig Green e del suo ruolo nella moda inglese contemporanea mi sono addormentato benissimo.