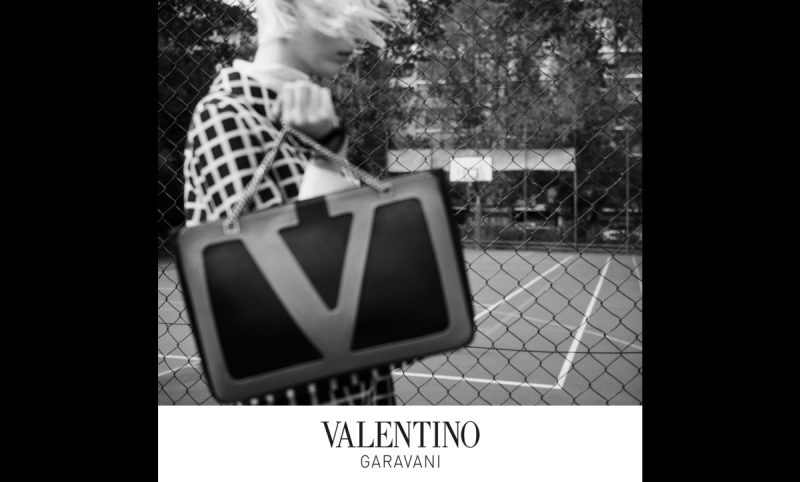L’ultima sfilata Couture di Balenciaga segna – questa volta in maniera definitiva – la fine dell’era Demna. Dieci anni in cui il Direttore creativo georgiano ha scritto la sua parte di storia della moda.
La moda a Milano un po’ wow, un po’ meh
Le collezioni di questi giorni confermano come quello attuale sia il momento più strano, e preoccupante, mai attraversato dall’industria della moda, soprattuto in Italia, dove le nuove voci faticano a trovare il loro spazio.

Più si cerca un angolo da cui interpretare le sfilate, più ogni discussione finisce per impantanarsi sulla rilevanza stessa di quest’ultime. I mercati si contraggono, i prodotti si moltiplicano, i marchi si confondono tra loro: non è importante se un capo, un accessorio o un’intera estetica sia originale, va bene anche se fake, anzi dupe, tanto nessuno guarda più alla moda come a una religione. O meglio, forse la moda non è più capace di colpire e modulare l’attenzione delle persone. Tante delle discussioni che attraversano i social si riducono all’ospite famoso, al dileggio del direttore creativo di turno o alla mera comparazione di look. È quasi paradossale osservare la grande macchina della fashion week muoversi, pachidermica eppure velocissima, mentre i risultati economici del settore si fanno sempre più allarmanti (ne scrivevo nell’ultima edizione della nostra newsletter) e i cambiamenti di certi mercati, dalla Cina all’India, rimangono dei misteri che nessuno al momento sa come interpretare. A chi sono destinati tutti questi vestiti? Chi indosserà tutte queste borse e tutte queste scarpe? Lo scorso giugno, in occasione delle sfilate dedicate alle collezioni maschili, era sembrato che lo stile italiano avesse trovato modo, in qualche luogo, di riformularsi, e che il “vestire bene” per cui siamo conosciuti nel mondo, ora ammantato da una certa decadenza, potesse ancora raccontarci qualcosa. Cathy Horyn si è chiesta su The Cut che fine abbia fatto la tradizionale portabilità del made in Italy, quando tanto di quello che si è visto in passerella in questa ultima settimana di collezioni donna per la Primavera Estate 2025 è sembrato invece pesante, quasi rigido, inadatto alla stagione estiva. Il suo è un punto di vista che tiene conto delle necessità del mercato americano, che storicamente hanno contribuito a formare e istituzionalizzare la nostra moda: se non siamo più quelli che vestono i ricchi del mondo, chi siamo?

Bottega Veneta Primavera Estate 2025. Photo courtesy of Bottega Veneta
Da Bottega Veneta, Matthieu Blazy è partito proprio dal concetto di “power dressing” armaniano ma con un twist tutto suo: quello del bambino che gioca con l’armadio dei genitori, un po’ come il Pinocchio a cui Luca Magliano si era ispirato nella sua ultima collezione. Il risultato è un ready-to-wear morbido e divertente con dei tocchi di sana follia stilistica, dalla gonna con una gamba pantalone (pants-skirt? gonna mono-pantalone?) alle spille-rana (simbolo di metamorfosi), dalla fibbia-coniglio (simbolo di rinascita e buon augurio) alle uscite finali con i copricapo di frange in pelle. È una delle collezioni più riuscite di questi giorni, così come riuscito era il set: ogni ospite sedeva infatti su un Sacco Zanotta, originariamente progettato nel 1968 da Piero Gatti, Cesare Paolini e Franco Teodoro e appositamente commissionato per la sfilata (sì, Jacob Elordi aveva il sacco coniglio, per fare il verso alla campagna virale degli ultimi mesi).
«Potere del wow», l’ha definito Blazy, un guizzo di giocosità, tra l’arca di Noè e American Psycho, un elemento che è mancato a molte altre collezioni. Era divertente e variegato anche il parterre degli ospiti, che oltre ai testimonial Elordi e A$AP Rocky comprendeva Jools Lebron, che ha lanciato il trend “very demure”, la pugile algerina Imane Khelif, alla quale il pubblico fuori dalla sfilata ha cantato “Sei bellissima”, l’astista Mondo Duplantis e la coppia Nara e Lucky Blue Smith, tutti popolarissimi su TikTok: qualcuno da Bottega Veneta sa quali sono le storie che ci interessano oggi. Anche nella collezione di Francesco Risso da Marni c’era il rimando a un coniglio bianco, come quello che porta verso un mondo fantastico: meno astratto delle altre volte, Risso questa volta ha voluto creare una sfilata drammatica e per certi versi molto nostalgica, dal trucco alla coreografia, curata da Sharleen Chidiac, con cui i modelli hanno attraversato la passerella, spezzando la classica camminata in percorsi alternativi.

Prada Primavera Estate 2025. Photo courtesy of Prada
C’era un elemento di randomness da Prada, anzi la randomness è proprio il punto della collezione di Miuccia Prada e Raf Simons, misticamente intitolata “Infinite Present”. Se questa è l’era dell’iper informazione e del flusso di contenuti guidati da algoritmi che non ci divertono più – ne ha scritto sul New Yorker Kyle Chayka, autore di Filterworld: How Algorithms Flattened Culture – allora la risposta è accettare quell’illogicità e sovvertirla, provando a rimettere al centro l’essere umano e la sua individualità. Un po’ come gli Easter Egg nei videogiochi, la collezione era disseminata di piccoli grandi tesori, ogni look un rimando a un preciso momento della storia di Prada e dell’epoca che ha raccontato. Non era la nostalgia a prevalere, quanto quella Prada-ness di cui più volte la coppia di co-direttori ha parlato da quando è iniziata la loro avventura insieme. Se non c’è passerella dove non ci sia un rimando a Prada e non c’è thread su X, video su TikTok o Youtube dove tra gli appassionati non si rivisiti questa o quella collezione di Prada, allora perché non far sfilare, da Prada, le tante creature di Prada? La prima uscita è un ragazzo in abito a fiori i cui orli sono irrigiditi da un filo interno ed è proprio l’hardware in metallo a tenere insieme la collezione, si perdoni il gioco di parole: dai ganci che rumoreggiano sull’abito di pelle o tengono attaccati gonna e cintura, scoprendo la pancia, agli occhiali incorporati nel foulard, dalle zeppe altissime (quelle dell’Autunno Inverno 2012) ai cerchi Space Age su gonne e cappelli alle minigonne laser fino ai mocassini con il risvolto e gli occhiali omaggio a John French, questa collezione è come un viaggio su Tumblr negli anni d’oro, che i ragazzi di oggi cercano di riprodurre nei social senz’anima che gli abbiamo consegnato. Silhouette anni Sessanta si sono viste anche da N°21, riviste però attraverso lo sguardo ribelle di Alessandro Dell’Acqua, che ha vissuto gli anni Novanta: una sicurezza, così come sicuri ora Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che hanno dedicato un’intera collezione a Madonna, eccezionalmente presente allo show. Per chi si preoccupa della “citazione” a Jean Paul Gaultier (il bustino con i seni a punta c’era in tutti look), dovrebbe sapere che allo stesso Gaultier le citazioni piacciono, soprattutto quelle che lo riguardano.
Si intitolava “Counterpoint 3”, invece, la terza prova di Simone Bellotti da Bally, che si conferma uno degli stilisti più interessanti di Milano. Nel campo libero lasciatogli dall’infelice esperienza di Rhuigi, Bellotti sta costruendo una sua visione in un marchio che non ha alcuna -ness, alcun archivio, almeno in fatto di vestiti, tra cui rovistare, il che per certi versi è una fortuna. Ispirandosi allo spirito (anche qui) giocoso del dadaismo, la collezione è un esercizio riuscitissimo dove a dominare è la silhouette a campana che definisce cappotti, giacche e gonne e che ricorda quella della tunica in acciaio indossata dal poeta Hugo Ball. Una silhouette che non risulta mai rigida, al contrario ha una sua stravaganza contenuta e molto contemporanea, che ben si lega con il cast, uno dei più azzeccati della settimana, e alla colonna sonora curata dall’artista svizzera Aisha Devi. Quello di Bellotti è un approccio fresco, intellettuale ma mai pieno di sé, di cui Milano ha tremendamente bisogno. Gli archivi pesano tanto, invece, da altre parti: da Moschino, ad esempio, dove Adrian Appiolaza però mantiene il suo tocco leggero e sceglie di partire da un lenzuolo bianco, come bianchi erano i “panni” appesi nello spazio che ha ospitato lo show. Le perle, così come molte delle ossessioni di Franco, diventano punk e dialogano con i pezzi di archivio dell’artista inglese Judy Blame, con la cui fondazione Appiolaza ha collaborato, mentre i pois non sono solo sui vestiti ma anche sulla pelle e gli Smiley si alternano a borchie e punte.

Gucci Primavera Estate 2025. Photo courtesy of Gucci
«Il momento in cui vado in archivio è uno dei miei preferiti», ha raccontato Sabato De Sarno durante l’anteprima stampa della nuova collezione che si intitola “Casual Grandeur” e ha sfilato, come lo scorso giugno, nelle sale di Triennale Milano. C’è, ovviamente, il rimando a Jackie Kennedy e al jet-set che in quel periodo vestiva Gucci, ci sono i grandi cappotti, che De Sarno sa fare benissimo, e le gambe esposte da gonne e mini-dress, e c’è un focus sull’archivio, in particolare sugli anni che vanno dal 1972 al 1983. Uno dei fili conduttori della collezione era la Gucci Bamboo 1947, il cui manico per l’occasione diventa anche gioiello, borsa che è stata celebrata anche con uno speciale progetto lanciato la scorsa estate per i sessant’anni della presenza di Gucci in Giappone. Artisti e artigiani locali sono stati coinvolti nel “riciclo creativo” di sessanta borse vintage, che sono poi state esposte presso la Gucci Ginza Gallery a Ginza, Tokyo, mentre dieci di queste borse sono arrivate anche in sfilata. A un anno dal suo debutto, questa è di certo la collezione più compiuta di De Sarno, che si è trovato ad affrontare una congiuntura particolarmente difficile e un’azienda, Kering, non preparata a supportarlo al meglio. Però questo primo anno l’ha superato, accollandosi anche il peso emotivo di critiche feroci che ad altri (vedi Kim Jones da Fendi o Daniel Lee da Burberry) sono state invece risparmiate. Una dimensione più intima gioverebbe forse ai suoi show, così come una direzione artistica, soprattutto sulle campagne, più incisiva, ma è di Gucci che parliamo: niente può essere fatto senza grandeur, casual e non.
Il passato di un marchio è un fardello pesante e a meno di non essere Giorgio Armani, che da Emporio Armani rimane nel solco dello stile che lo ho reso uno dei pochi marchi che oggi può permettersi di stare fuori da certe dinamiche dell’industria, i problemi sorgono. Lo si vede chiaramente da Fendi, dove Kim Jones, bravissimo da Dior Men e prima ancora da Louis Vuitton, fa ancora fatica a trovare il suo angolo di racconto in un’azienda che aveva le donne al suo centro; così come da Ferragamo Maximilian Davis, pur essendo talentuoso, non è ancora riuscito a trovare la chiave per far sua la storia del brand. A volte essere liberi da quei fardelli aiuta e lo dimostra il caso di Sunnei, che ha festeggiato i suoi dieci anni, un vero e proprio traguardo per un marchio italiano di nuova generazione, con una sfilata che aveva solo modelli over 50 (tutti bellissimi, tra l’altro). L’età può essere un limite mentale, soprattutto in Italia, e la strafottenza di Sunnei è una boccata d’aria fresca in un panorama affollato di heritage, storytelling e know-how.
Era invece dedicata all’archetipo della “party girl”, colonna portante di certa moda italiana soprattutto negli anni Duemila, la collezione di Gilda Ambrosio e Giulia Tordini per Attico. Intitolata “The Sound of Breaking Glass”, si ispirava al più canonico dei momenti nella vita di una giovane donna: quando una relazione finisce prima dell’estate. Anche Andrea Adamo, tornato a sfilare dopo una pausa, ha in mente le ragazze disinibite e sicure di sé, fasciate nei suoi abiti, mentre Marco Rambaldi, che nonostante le difficoltà è ancora in calendario, ha mandato in passerella una delle sue collezioni più belle, “Tante care cose”: la sua voce, il suo sguardo sulla femminilità, la sua delicatezza nel guardare e vestire il corpo delle ragazze e delle donne è qualcosa di prezioso, che a Milano non valorizziamo abbastanza. Lo stesso si potrebbe dire per tutti quei brand – Cormio, Vitelli, Act N°1, Adriana Hot Couture – che hanno scelto altre modalità fuori e dentro la fashion week: sarebbe opportuno non aspettare che si accorgano di loro i giornalisti americani, tra dieci anni.
In apertura: Bally Primavera Estate 2025. Photo courtesy of Bally

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.