Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.
I libri del mese
Cosa abbiamo letto a settembre, e cosa stiamo leggendo in redazione.

Leonard Michaels – Sylvia (Adelphi) trad. V. Vergiani
Le relazioni tra gli esseri umani sono tutte uguali. Seguono il medesimo schema, sempre: quello che le fa differire è l’intensità con cui vengono vissute. È per questo che Sylvia fa paura. È un libro breve e forte (direi “intenso”, se non fosse una parola così abusata nei confronti dei libri, che spesso sono bellissimi senza essere intensi) e racconta, banalmente, di una relazione che va a pezzi. Sono cose ordinarie, piccole, cattive: i litigi, i fastidi, i nervi che sfrigolano ed esplodono. Di chi è la colpa è una questione più terziaria che secondaria. Quello che c’è di centrale, in Sylvia, è la quantità di odio presente in ogni storia di coppia. Una relazione è come un pianeta, ogni pianeta ha la sua atmosfera particolare: il diossido di carbonio è necessario alla vita, in certe quantità. 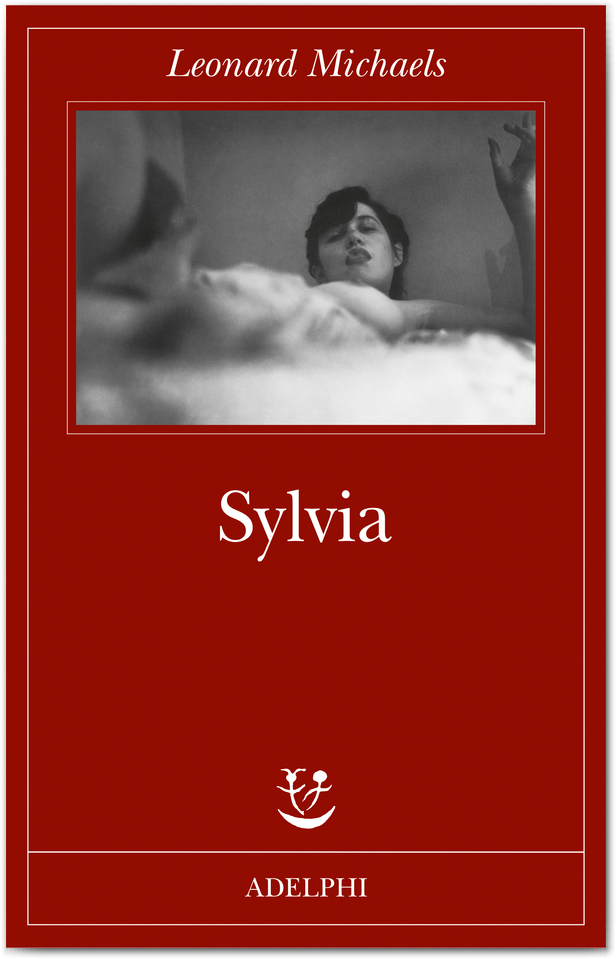 Quando supera quelle quantità è troppo, e la impedisce. Non credo di aver mai ritrovato descrizioni di litigi così puntuali, in un libro (forse qualcosa in James Salter, ma più probabilmente no), che sappiano mostrare al lettore con precisione quando si spezza il filo dell’equilibrio e si precipita verso la pazzia. Come: «Un pomeriggio, seduto sui gradini di casa in attesa che Sylvia tornasse dall’università, la vidi in lontananza che camminava piano. Quando s’accorse che la stavo guardando, rallentò ulteriormente. La suola del suo sandalo destro si era quasi staccata e sbatteva a ogni passo. Finalmente arrivò dinanzi a me e mi mostrò un chiodo che le si era conficcato nella suola. Era tornata a casa camminando sul chiodo, con la suola che sbatteva e il piede che sguazzava nel sangue. Cos’altro avrebbe potuto fare? Sorrise debolmente, dolorante, ma di buonumore Dissi che avrebbe potuto far riparare il sandalo o camminare scalza o chiamare un taxi. C’era una nota di impazienza nella mia voce, non potevo annullarne l’effetto. Per giorni e giorni Sylvia continuò ad andare in giro per Cambridge premendo il piede sul chiodo e sanguinando. Si rifiutava di mettere altre scarpe. Supplicai, discussi con lei. Finalmente lasciò che la portassi a far riparare il sandalo. Gliene fui grato. Lei no. Non fui perdonato». Naturalmente, l’odio e la follia, in Sylvia, sono presenti in quantità soffocanti. Ma funzionano comunque: sono uno specchio, sono gli stessi che conosciamo tutti. Naturalmente, lei si uccide. Naturalmente, la storia raccontata è una storia vera. (Davide Coppo)
Quando supera quelle quantità è troppo, e la impedisce. Non credo di aver mai ritrovato descrizioni di litigi così puntuali, in un libro (forse qualcosa in James Salter, ma più probabilmente no), che sappiano mostrare al lettore con precisione quando si spezza il filo dell’equilibrio e si precipita verso la pazzia. Come: «Un pomeriggio, seduto sui gradini di casa in attesa che Sylvia tornasse dall’università, la vidi in lontananza che camminava piano. Quando s’accorse che la stavo guardando, rallentò ulteriormente. La suola del suo sandalo destro si era quasi staccata e sbatteva a ogni passo. Finalmente arrivò dinanzi a me e mi mostrò un chiodo che le si era conficcato nella suola. Era tornata a casa camminando sul chiodo, con la suola che sbatteva e il piede che sguazzava nel sangue. Cos’altro avrebbe potuto fare? Sorrise debolmente, dolorante, ma di buonumore Dissi che avrebbe potuto far riparare il sandalo o camminare scalza o chiamare un taxi. C’era una nota di impazienza nella mia voce, non potevo annullarne l’effetto. Per giorni e giorni Sylvia continuò ad andare in giro per Cambridge premendo il piede sul chiodo e sanguinando. Si rifiutava di mettere altre scarpe. Supplicai, discussi con lei. Finalmente lasciò che la portassi a far riparare il sandalo. Gliene fui grato. Lei no. Non fui perdonato». Naturalmente, l’odio e la follia, in Sylvia, sono presenti in quantità soffocanti. Ma funzionano comunque: sono uno specchio, sono gli stessi che conosciamo tutti. Naturalmente, lei si uccide. Naturalmente, la storia raccontata è una storia vera. (Davide Coppo)
Don DeLillo – Zero K (Einaudi) trad. F. Aceto
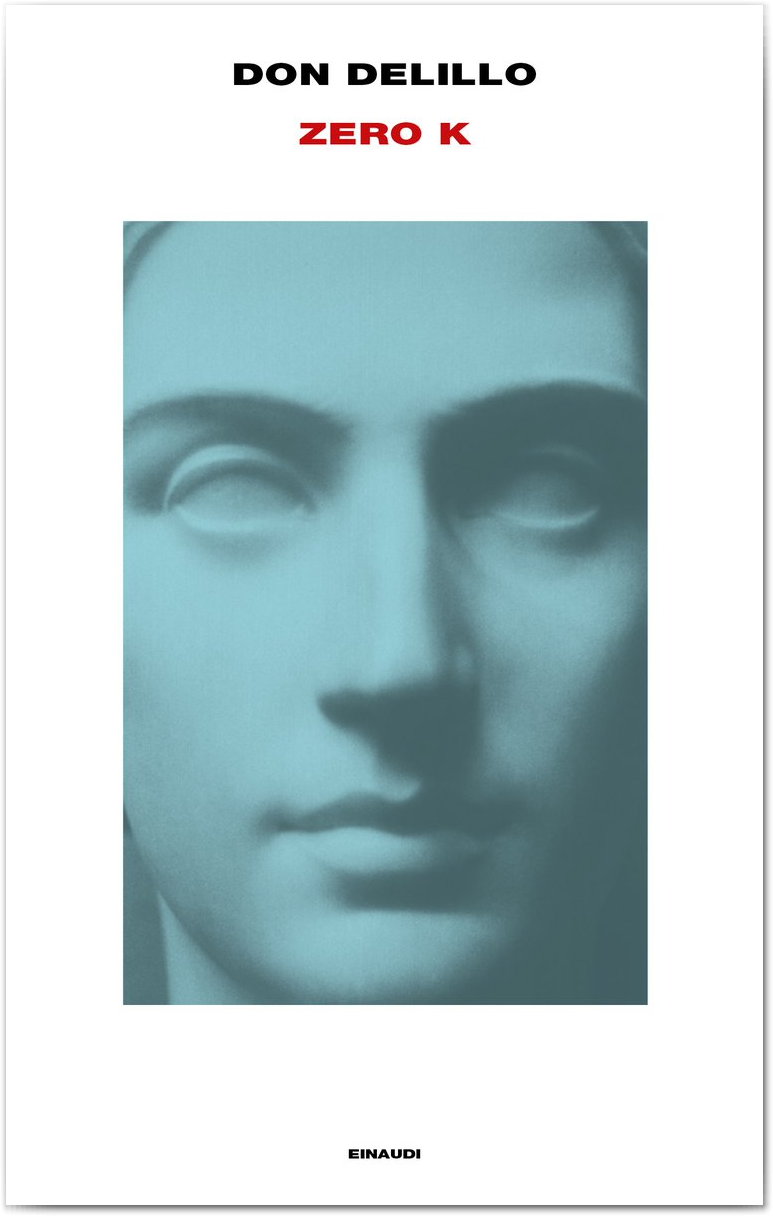 “Delilleggiare” potrebbe essere diventato un verbo, per quanto lo stile del grande, forse il più grande, scrittore americano vivente sia riconoscibile, imitato, e anche auto-cannibalizzato sfiorando a tratti la maniera. È anche per questo che dopo Underworld DeLillo ha cercato delle strade che lo portassero lontano dalla sua opera-mondo, sperimentando nella struttura e lasciando sempre fermo lo stile, inconfondibile, fatto soprattutto di quegli irrealistici dialoghi profetici che mette in scena coi suoi personaggi. Sono tra quelli che hanno amato il non molto amato Point Omega, suo penultimo libro e insieme a Body Art tentativo di fissione dell’atomo letterario, cioè di dire tutto riducendo le questioni all’osso. Al contrario non ho trovato riuscitissimi i suoi ultimi due libri medi (nel senso della lunghezza) Cosmopolis e L’uomo che cade. Romanzi forse dove la barra si sposta troppo sull’interpretazione della realtà, mentre mi sembra che la vecchiaia per questo scrittore frutti molto meglio sulle questioni metafisiche. Sto leggendo in bozze Zero K e mi sembra un tentativo di ricondurre a unità queste due linee della sua ultima produzione letteraria, sia nel senso del rapporto sottrazione/accumulazione sia nel senso del rapporto trascendenza/società. Mi sembra un libro anche meno delilliano del solito, dove lo stile mostra una forma di saggezza secolare, dove non si sente quel richiamo a imitare se stesso. Si parla di vita, di morte, di futuro. E sembra un gran libro. (Cristiano de Majo)
“Delilleggiare” potrebbe essere diventato un verbo, per quanto lo stile del grande, forse il più grande, scrittore americano vivente sia riconoscibile, imitato, e anche auto-cannibalizzato sfiorando a tratti la maniera. È anche per questo che dopo Underworld DeLillo ha cercato delle strade che lo portassero lontano dalla sua opera-mondo, sperimentando nella struttura e lasciando sempre fermo lo stile, inconfondibile, fatto soprattutto di quegli irrealistici dialoghi profetici che mette in scena coi suoi personaggi. Sono tra quelli che hanno amato il non molto amato Point Omega, suo penultimo libro e insieme a Body Art tentativo di fissione dell’atomo letterario, cioè di dire tutto riducendo le questioni all’osso. Al contrario non ho trovato riuscitissimi i suoi ultimi due libri medi (nel senso della lunghezza) Cosmopolis e L’uomo che cade. Romanzi forse dove la barra si sposta troppo sull’interpretazione della realtà, mentre mi sembra che la vecchiaia per questo scrittore frutti molto meglio sulle questioni metafisiche. Sto leggendo in bozze Zero K e mi sembra un tentativo di ricondurre a unità queste due linee della sua ultima produzione letteraria, sia nel senso del rapporto sottrazione/accumulazione sia nel senso del rapporto trascendenza/società. Mi sembra un libro anche meno delilliano del solito, dove lo stile mostra una forma di saggezza secolare, dove non si sente quel richiamo a imitare se stesso. Si parla di vita, di morte, di futuro. E sembra un gran libro. (Cristiano de Majo)
Pierre Michon – Vite minuscole (Adelphi) trad. L. Carra
 La prima volta che ho visto Vite minuscole era su Instagram, poi su Facebook, poi su Instagram, Instagram, ancora Instagram, Facebook… e a me è passata la voglia di comprarlo, anche se sentivo che era evidentemente un libro per me e per tutti quelli che sono cresciuti col mito dei vinti, da Tonio Kröger contro i Blauaugigen a Hans Schnier, passando per il Soccombente. Poi ho ceduto, ho lasciato che le cose andassero come dovevano e ho scoperto che: Michon è quello che sarebbe voluto essere Kent Haruf, se solo fosse nato in Francia; Michon è Annie Ernaux senza le cose che non mi piacciono di Annie Ernaux; Michon parla la lingua dei miei nonni – usa parole come turacciolo, gelso, zolfanello – parla di scolopendre, ha avuto una nonna ostetrica (sage-femme) e sa come muoiono i gatti – la faccia storta delle persone quando dici che ne hai avuti tredici, già. Compatisce il mondo invece di mostrare soltanto quant’è cattivo e quando i suoi personaggi mangiano la minestra sono credibili, non “carveriani”. Michon sa cosa vuol dire essere poveri, miseri, minuscoli, sa che il sacrificio è pornografico, conosce il rimpianto e il rimorso di essere stato costretto a cauterizzare le appendici delle proprie origini – perché delle origini non ci si libera mai – il senso di colpa del sopravvissuto per tutto ciò che ha ricevuto e che gli è stato concesso; parla della quantità di amore che possono contenere le anime semplici, senza descriverle come babbuini allo zoo, ne parla con cognizione di causa, come Van Gogh dipingeva i mangiatori di patate, ne parla con commozione, sapendo di essere uno di loro, sapendo di non esserlo. Ma soprattutto lo fa con una lingua ricchissima e perfetta, a metà tra quella di Bernhard e di Manganelli. Michon non è realista, non è folcloristico, non è un autore di autofiction, Michon è un grande scrittore. E come tutti i contadini che scoprono la Bella Lingua – senza ottenerne grandezza, ma la tortura quotidiana della sua nostalgia – non ha paura di affiancare riferimenti raffinati a teiere smiccate e a macchine vecchie, e pur sapendo che i suoi personaggi non li capiranno mai, ha smesso di odiarli, o di vergognarsi di loro, li ama senza risentimento, li prende un po’ in giro, ma soprattutto prende in giro se stesso per non averli capiti prima. (Lucia Brandoli Bousquet)
La prima volta che ho visto Vite minuscole era su Instagram, poi su Facebook, poi su Instagram, Instagram, ancora Instagram, Facebook… e a me è passata la voglia di comprarlo, anche se sentivo che era evidentemente un libro per me e per tutti quelli che sono cresciuti col mito dei vinti, da Tonio Kröger contro i Blauaugigen a Hans Schnier, passando per il Soccombente. Poi ho ceduto, ho lasciato che le cose andassero come dovevano e ho scoperto che: Michon è quello che sarebbe voluto essere Kent Haruf, se solo fosse nato in Francia; Michon è Annie Ernaux senza le cose che non mi piacciono di Annie Ernaux; Michon parla la lingua dei miei nonni – usa parole come turacciolo, gelso, zolfanello – parla di scolopendre, ha avuto una nonna ostetrica (sage-femme) e sa come muoiono i gatti – la faccia storta delle persone quando dici che ne hai avuti tredici, già. Compatisce il mondo invece di mostrare soltanto quant’è cattivo e quando i suoi personaggi mangiano la minestra sono credibili, non “carveriani”. Michon sa cosa vuol dire essere poveri, miseri, minuscoli, sa che il sacrificio è pornografico, conosce il rimpianto e il rimorso di essere stato costretto a cauterizzare le appendici delle proprie origini – perché delle origini non ci si libera mai – il senso di colpa del sopravvissuto per tutto ciò che ha ricevuto e che gli è stato concesso; parla della quantità di amore che possono contenere le anime semplici, senza descriverle come babbuini allo zoo, ne parla con cognizione di causa, come Van Gogh dipingeva i mangiatori di patate, ne parla con commozione, sapendo di essere uno di loro, sapendo di non esserlo. Ma soprattutto lo fa con una lingua ricchissima e perfetta, a metà tra quella di Bernhard e di Manganelli. Michon non è realista, non è folcloristico, non è un autore di autofiction, Michon è un grande scrittore. E come tutti i contadini che scoprono la Bella Lingua – senza ottenerne grandezza, ma la tortura quotidiana della sua nostalgia – non ha paura di affiancare riferimenti raffinati a teiere smiccate e a macchine vecchie, e pur sapendo che i suoi personaggi non li capiranno mai, ha smesso di odiarli, o di vergognarsi di loro, li ama senza risentimento, li prende un po’ in giro, ma soprattutto prende in giro se stesso per non averli capiti prima. (Lucia Brandoli Bousquet)
Jonathan Safran Foer – Eccomi (Guanda) trad. I. A. Piccinini
 C’è una storia ricorrente nella produzione culturale ebraico-americana: un padre di famiglia sente la terra franargli sotto i piedi, ogni certezza si sgretola, la famiglia che non è più una famiglia, l’uomo che non è più uomo, i riti religiosi infranti o dimenticati, persino la sicurezza fisica viene meno. È un ordine sociale che scricchiola mentre la tempesta s’avvicina. L’hanno raccontata in molti, da Singer ai Fratelli Coen, e adesso è il turno Jonathan Safran Foer in Eccomi, tradotto da Irene Abigail Piccinini per Guanda. Del libro e del suo autore si sono già dette molte cose, belle e brutte, e non credo di avere molto da aggiungere, se non su quello che Foer evoca, più che racconta: il piccolo lattaio di Sholem Aleichem, che grida al cielo «Tradizione!», camera fissa sugli arredi sacri, mente le figlie cominciano a pensare con la loro testa e arrivano i cosacchi; il protagonista di A Serious Man che fissa la tempesta, mentre il rabbino non ha risposte e la tipa dei Jefferson Airplane canta «When the truth is found to be lies, don’t you want somebody to love?»; Solomon Kugel, l’alter ego di Shalom Auslander ossessionato dalle «ultime volte» in un mondo che sembra affascinato dalle prime. Eccomi gronda di riferimenti ebraici, che però Foer utilizza a mo’ di linguaggio per parlare di temi più universali. «Eccomi» è la frase ripetuta da Abramo, il patriarca che avrà anche tentato di uccidere due figli piccoli, ma era pur sempre una presenza solida, una certezza, mica quei genitori distratti ed evaporati di oggi: lo nota, guarda caso, un ragazzino che deve preparare il Bar Mitzvà mentre i suoi si stanno separando, e il rabbino non capisce un cazzo. Non c’è bisogno di avere mai partecipato a un Bar Mitzvà per capire di cosa parla, in compenso avere visto una separazione da vicino aiuta. Piccola provocazione finale: questa cosa di universalizzare i temi ebraici sta riuscendo agli americani molto più che agli europei, per lo meno dai tempi di Rachele litiga con Dio di Stefan Zweig. (Anna Momigliano)
C’è una storia ricorrente nella produzione culturale ebraico-americana: un padre di famiglia sente la terra franargli sotto i piedi, ogni certezza si sgretola, la famiglia che non è più una famiglia, l’uomo che non è più uomo, i riti religiosi infranti o dimenticati, persino la sicurezza fisica viene meno. È un ordine sociale che scricchiola mentre la tempesta s’avvicina. L’hanno raccontata in molti, da Singer ai Fratelli Coen, e adesso è il turno Jonathan Safran Foer in Eccomi, tradotto da Irene Abigail Piccinini per Guanda. Del libro e del suo autore si sono già dette molte cose, belle e brutte, e non credo di avere molto da aggiungere, se non su quello che Foer evoca, più che racconta: il piccolo lattaio di Sholem Aleichem, che grida al cielo «Tradizione!», camera fissa sugli arredi sacri, mente le figlie cominciano a pensare con la loro testa e arrivano i cosacchi; il protagonista di A Serious Man che fissa la tempesta, mentre il rabbino non ha risposte e la tipa dei Jefferson Airplane canta «When the truth is found to be lies, don’t you want somebody to love?»; Solomon Kugel, l’alter ego di Shalom Auslander ossessionato dalle «ultime volte» in un mondo che sembra affascinato dalle prime. Eccomi gronda di riferimenti ebraici, che però Foer utilizza a mo’ di linguaggio per parlare di temi più universali. «Eccomi» è la frase ripetuta da Abramo, il patriarca che avrà anche tentato di uccidere due figli piccoli, ma era pur sempre una presenza solida, una certezza, mica quei genitori distratti ed evaporati di oggi: lo nota, guarda caso, un ragazzino che deve preparare il Bar Mitzvà mentre i suoi si stanno separando, e il rabbino non capisce un cazzo. Non c’è bisogno di avere mai partecipato a un Bar Mitzvà per capire di cosa parla, in compenso avere visto una separazione da vicino aiuta. Piccola provocazione finale: questa cosa di universalizzare i temi ebraici sta riuscendo agli americani molto più che agli europei, per lo meno dai tempi di Rachele litiga con Dio di Stefan Zweig. (Anna Momigliano)
Nicolò de Rienzo – Grand Hotel Italia (add editore)
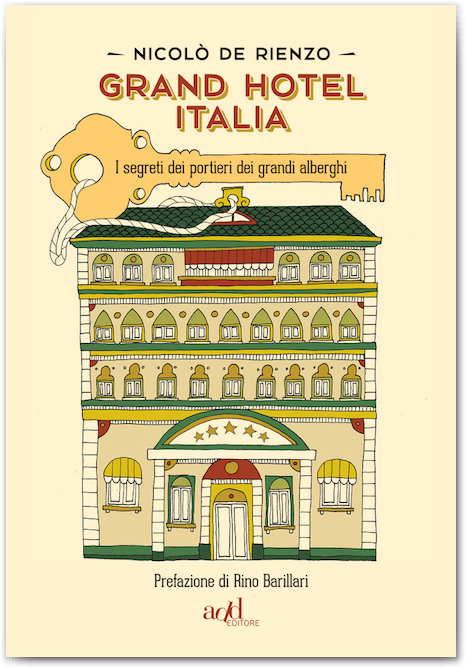 «Quando ho cominciato, le star erano erano poche e di una grandezza incommensurabile». La prefazione di Grand Hotel Italia è di Rino Barillari, il “King of Paparazzi” così simbiotico alle strade romane che contano da aver ottenuto di diritto un cameo ne La grande bellezza di Sorrentino. Nelle 280 pagine di interviste e racconti curate da Nicolò de Rienzo oltre alle «star» però compaiono reception, banconi e stanze da cui filtra un’antropologia da commedia all’italiana: famiglie nobili elegantissime e gentili, parvenu di provincia rampanti e cafoni, cafonissima piccola borghesia e giovani camerieri seduttori di ricche mogli annoiate. Se è vero, come si afferma a pagina 51 del libro, che «è il grande cliente a fare grande il portiere», allora le testimonianze raccolte da de Rienzo diventano piccole epiche di regni perduti, luoghi mitici in cui era normale passare una serata con Naomi Campbell o assistere a un litigio di coppia tra Rock Hudson e la moglie. I tempi sono cambiati, «una volta Gianni Agnelli arrivava con la Cinquecento e non se ne accorgeva nessuno» (a parte Barillari, l’autore della citazione), forse questi grand hotel non esistono più, forse hanno cambiato forma, forse ora le celebrità si servono di meno personale. E proprio per questo queste storie di hotellerie, i loro personaggi, le loro atmosfere, hanno qualcosa di intrinsecamente, nostalgicamente italiano. (Davide Piacenza)
«Quando ho cominciato, le star erano erano poche e di una grandezza incommensurabile». La prefazione di Grand Hotel Italia è di Rino Barillari, il “King of Paparazzi” così simbiotico alle strade romane che contano da aver ottenuto di diritto un cameo ne La grande bellezza di Sorrentino. Nelle 280 pagine di interviste e racconti curate da Nicolò de Rienzo oltre alle «star» però compaiono reception, banconi e stanze da cui filtra un’antropologia da commedia all’italiana: famiglie nobili elegantissime e gentili, parvenu di provincia rampanti e cafoni, cafonissima piccola borghesia e giovani camerieri seduttori di ricche mogli annoiate. Se è vero, come si afferma a pagina 51 del libro, che «è il grande cliente a fare grande il portiere», allora le testimonianze raccolte da de Rienzo diventano piccole epiche di regni perduti, luoghi mitici in cui era normale passare una serata con Naomi Campbell o assistere a un litigio di coppia tra Rock Hudson e la moglie. I tempi sono cambiati, «una volta Gianni Agnelli arrivava con la Cinquecento e non se ne accorgeva nessuno» (a parte Barillari, l’autore della citazione), forse questi grand hotel non esistono più, forse hanno cambiato forma, forse ora le celebrità si servono di meno personale. E proprio per questo queste storie di hotellerie, i loro personaggi, le loro atmosfere, hanno qualcosa di intrinsecamente, nostalgicamente italiano. (Davide Piacenza)
In lettura
Estratti da libri che stiamo leggendo
Marco Rossari – Le cento vite di Nemesio (e/o)
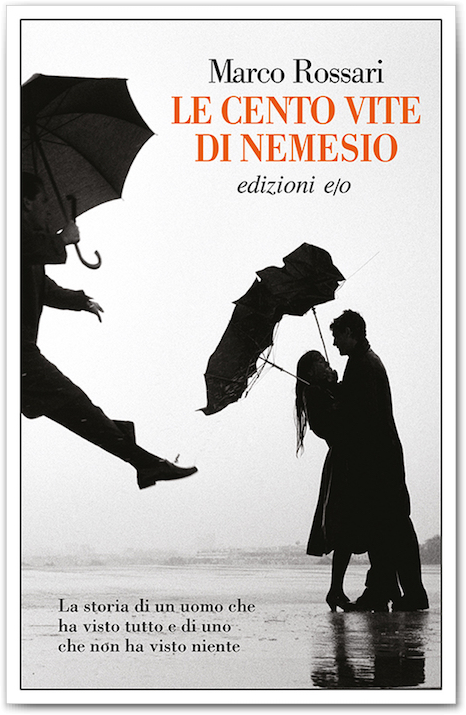 Il maltempo di quella mattina aveva regalato a Nemo un meschino brivido di piacere: se non altro, pioveva. Perché bisognava aggiungere una cosa: non solo quel giorno era il compleanno del suo grande nemico, non solo Nemesio il Vecchio arrivava trionfante al giro di boa – cento anni “da protagonista”, come avrebbero titolato tutti i giornali che Nemo non avrebbe acquistato – ma nel tardo pomeriggio il Comune avrebbe reso onore a uno dei suoi figli più illustri (e longevi, certo) con l’inaugurazione di una mostra antologica nella cornice di Palazzo Reale, a due passi dal Duomo, proprio dietro il muro delle sale dove Nemo lavorava come maschera.
Il maltempo di quella mattina aveva regalato a Nemo un meschino brivido di piacere: se non altro, pioveva. Perché bisognava aggiungere una cosa: non solo quel giorno era il compleanno del suo grande nemico, non solo Nemesio il Vecchio arrivava trionfante al giro di boa – cento anni “da protagonista”, come avrebbero titolato tutti i giornali che Nemo non avrebbe acquistato – ma nel tardo pomeriggio il Comune avrebbe reso onore a uno dei suoi figli più illustri (e longevi, certo) con l’inaugurazione di una mostra antologica nella cornice di Palazzo Reale, a due passi dal Duomo, proprio dietro il muro delle sale dove Nemo lavorava come maschera.
Era l’ultima consacrazione. O così si sperava.
Una retrospettiva con tutte le tappe salienti della sua sfolgorante carriera, intitolata dall’assessore alla cultura in un momento di straripante originalità Sulle spalle di un gigante. Vita e opere di Nemesio Viti. Nemo non poteva non immaginare una versione tutta sua: Sulle palle di un gigante. In primis per la faccenda dello sperma vecchio. E poi perché padre e figlio si detestavano.
Vintage
Estratti da libri che stiamo rileggendo
Primo Levi – Il sistema periodico (Einaudi)
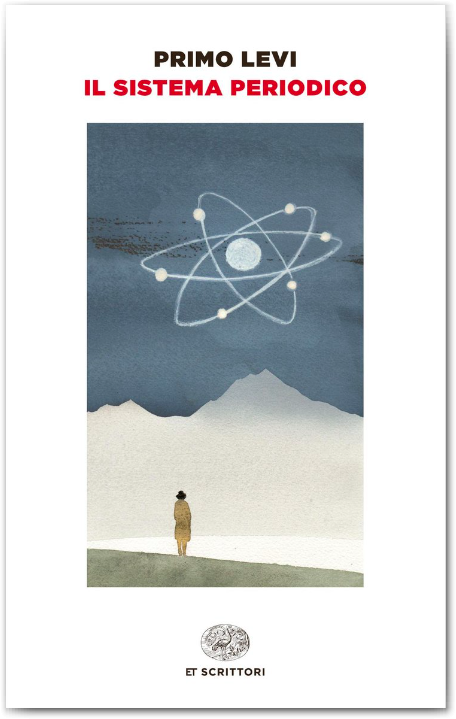 Ci dissero che la nostra insofferenza beffarda non bastava; doveva volgersi in collera, e la collera essere incanalata in una rivolta organica e tempestiva: ma non ci insegnarono come si fabbrica una bomba, né come si spara un fucile. Ci parlavano di sconosciuti: Gramsci, Salvemini, Gobetti, i Rosselli; chi erano? Esisteva dunque una seconda storia, una storia parallela a quella che il liceo ci aveva somministrata dall’alto? In quei pochi mesi convulsi cercammo invano di ricostruire, di ripopolare il vuoto storico dell’ultimo ventennio, ma quei nuovi personaggi rimanevano “eroi”, come Garibaldi e Nazario Sauro, non avevano spessore né sostanza umana. Il tempo per consolidare la nostra preparazione non ci fu concesso: vennero in marzo gli scioperi di Torino, ad indicare che la crisi era prossima; vennero col 25 luglio il collasso del fascismo dall’interno, le piazze gremite di folla affratellata, la gioia estemporanea e precaria di un paese a cui la libertà era stata donata da un intrigo di palazzo; e venne l’8 settembre, il serpente verdegrigio delle divisioni naziste per le vie di Milano e di Torino, il brutale risveglio: la commedia era finita, l’Italia era un paese occupato, come la Polonia, come la Jugoslavia, come la Norvegia. In questo modo, dopo la lunga ubriacatura di parole, certi della giustezza della nostra scelta, estremamente insicuri dei nostri mezzi, con in cuore assai più disperazione che speranza, e sullo sfondo di un paese disfatto e diviso, siamo scesi in campo per misurarci. Ci separammo per seguire il nostro destino, ognuno in una valle diversa.
Ci dissero che la nostra insofferenza beffarda non bastava; doveva volgersi in collera, e la collera essere incanalata in una rivolta organica e tempestiva: ma non ci insegnarono come si fabbrica una bomba, né come si spara un fucile. Ci parlavano di sconosciuti: Gramsci, Salvemini, Gobetti, i Rosselli; chi erano? Esisteva dunque una seconda storia, una storia parallela a quella che il liceo ci aveva somministrata dall’alto? In quei pochi mesi convulsi cercammo invano di ricostruire, di ripopolare il vuoto storico dell’ultimo ventennio, ma quei nuovi personaggi rimanevano “eroi”, come Garibaldi e Nazario Sauro, non avevano spessore né sostanza umana. Il tempo per consolidare la nostra preparazione non ci fu concesso: vennero in marzo gli scioperi di Torino, ad indicare che la crisi era prossima; vennero col 25 luglio il collasso del fascismo dall’interno, le piazze gremite di folla affratellata, la gioia estemporanea e precaria di un paese a cui la libertà era stata donata da un intrigo di palazzo; e venne l’8 settembre, il serpente verdegrigio delle divisioni naziste per le vie di Milano e di Torino, il brutale risveglio: la commedia era finita, l’Italia era un paese occupato, come la Polonia, come la Jugoslavia, come la Norvegia. In questo modo, dopo la lunga ubriacatura di parole, certi della giustezza della nostra scelta, estremamente insicuri dei nostri mezzi, con in cuore assai più disperazione che speranza, e sullo sfondo di un paese disfatto e diviso, siamo scesi in campo per misurarci. Ci separammo per seguire il nostro destino, ognuno in una valle diversa.
Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.



