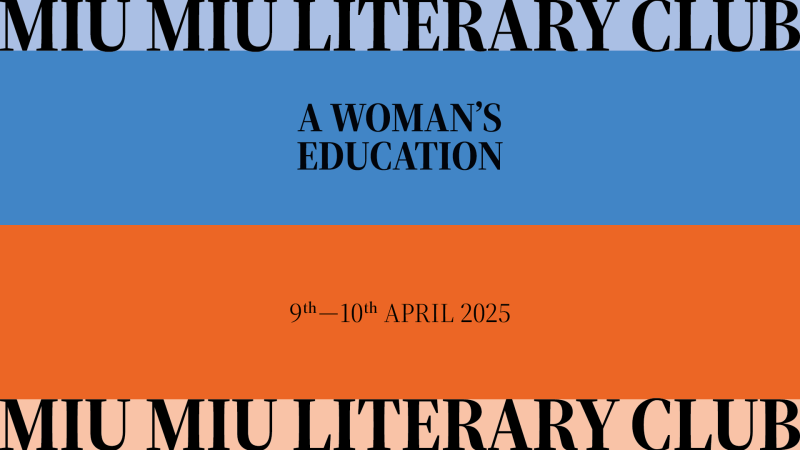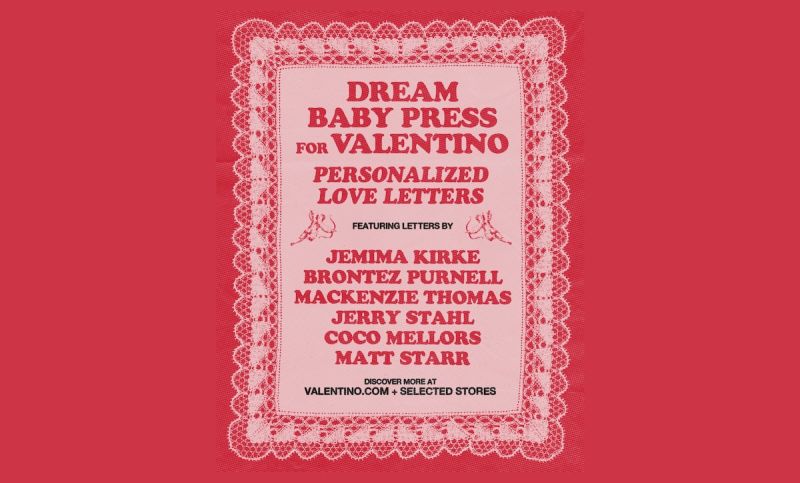Parlare di vestiti senza parlare di moda
Intervista a Olivier Saillard ed Emanuele Coccia su Le molte vite di un abito, la mostra che accompagna l’ultima edizione di ITS Contest, il premio che ogni anno porta a Trieste giovani creativi provenienti da tutto il mondo.

Se c’è un tema centrale che emerge dai progetti dei finalisti dell’ultima edizione dell’ITS Contest e dalla mostra allestita negli spazi dell’affiliata Arcademy, è che la moda è uno strumento privilegiato per l’espressione di sé. Fondato nel 2002 da Barbara Franchin, ITS Contest è il premio che ogni anno riunisce a Trieste giovani creativi provenienti da tutto il mondo con lo scopo di individuare e lanciare una nuova generazione di designer emergenti. Come spiega Olivier Saillard, storico della moda e direttore della Fondation Azzedine Alaïa, ospite di questa edizione e collaboratore di lungo corso della manifestazione: «ITS è qualcosa di più di un premio, è una collezione». Nel corso degli anni, infatti, i quasi 15 mila portfolio dei candidati, che tengono traccia degli immaginari e delle ispirazioni che li hanno mossi nella realizzazione delle collezioni, sono stati conservati e, insieme agli abiti realizzati dai finalisti, costituiscono un immenso patrimonio che lo scorso maggio ha trovato una nuova casa nell’ITS Arcademy, il primo museo italiano interamente dedicato alla moda contemporanea. Un archivio vivo, quindi, destinato ad ampliarsi costantemente per accogliere le nuove proposte che, anno dopo anno, si aggiungono ai progetti dei partecipanti delle edizioni passate (da qui sono passati Demna, Nicolas di Felice, Chopova Lowena e Matthieu Blazy, solo per citarne alcuni). Si tratta di lavori unici, di opere prime che testimoniamo la libertà nella sperimentazione e la purezza nella creatività di chi ancora non è entrato nell’industria. E sono collezioni estremamente personali, frutto della sensibilità di chi le ha create, e variegate negli esiti estetici e concettuali a cui approdano. Così, tra le proposte dei finalisti di quest’anno, per la prima volta invitati a prendere parte a una residenza creativa di una settimana, si incontrano riletture della storia del proprio Paese d’origine (come nel caso di Ivan Delogu e Mert Serbest), racconti intimi e personali (Daniel Bosco e Momoka Sato, vincitrice di quest’edizione) o ancora riflessioni sul nostro rapporto con il mondo che ci circonda (Shanon Poupard e Richard Farbey). Tutte collezioni legate, oltre che da una forte e consapevole spinta all’innovazione tecnica, da un lucidissima presa di posizione rispetto al mondo e all’industria della moda.

© Massimo Gardone
Le creazioni dei sedici finalisti saranno esposte negli spazi di Arcademy, dove fino al prossimo 6 gennaio è possibile visitare la mostra Le molte vite di un abito. Co-curata da Saillard, già curatore della prima mostra presentata da ITS (ne parlavamo qui), insieme al filosofo Emanuele Coccia, autore di testi e seminari che indagano la relazione tra filosofia e moda, Le molte vite di un abito parte dall’idea che ogni vestito è una mostra attraverso cui ciascuno di noi prova ad esporre se stesso. Concentrandosi non tanto, o non solo, sull’abito inteso come oggetto tessile, la mostra si propone di offrire un nuovo sguardo sulla moda, mettendo in luce il rapporto che i vestiti instaurano con il corpo che li indossa e con lo spazio che li circonda e celebrando il radicale approccio alla curatela di moda che ha contraddistinto la carriera trentennale di Saillard. Il percorso della mostra è scandito da dodici stazioni che corrispondono ad altrettante modalità dell’abito di influenzare la nostra vita: dalla selezione quotidiana dal nostro guardaroba fino ai «musei di moda popolari» che sono le vetrine dei negozi, passando per il momento speciale della prova nei camerini, quando, come spiega Coccia, «l’abito cessa di essere un’esperienza puramente visuale e diventa incarnato». Ma c’è anche la stazione dedicata al ruolo degli abiti nella letteratura e quella relativa agli abiti perduti che, abbandonati dal corpo che li ha posseduti, si riversano nelle strade in attesa di una seconda vita che forse non arriverà mai. Così come la sezione dedicata al rapporto intimo con i propri vestiti che, come ci hanno raccontato i curatori, ha coinvolto direttamente la città di Trieste e i suoi abitanti.
ⓢ A un anno dalla prima mostra realizzata per ITS, quali erano le vostre intenzioni dietro a Le molte vite di un abito?
Olivier Saillard: È stata una grande sfida perché non volevamo ripeterci. Quando Barbara mi ha suggerito l’idea di lavorare con qualcuno, ho immediatamente pensato a Emanuele Coccia, che è un filosofo interessato alla moda e ai vestiti. Emanuele ha accettato e l’unica cosa che sapevamo è che volevamo fare qualcosa di più teorico: analizzare la moda, ancora prima di mostrarla. Sapevamo poi che dovevamo includere alcuni look della collezione ITS e abbiamo trovato un buon modo per farlo che è più in linea con l’idea di laboratorio che con quella di museo.
ⓢ In svariate occasioni ha raccontato di avere una relazione speciale con le parole. Come è stato, a questo proposito, confrontarsi con Coccia e la sua formazione filosofica?
Olivier Saillard: Credo derivi da questo l’interesse di Emanuele per le mie mostre e performance: è vero che ho una grande passione per le parole. Se dovessi abbandonare la curatela di moda, passerei tutto il tempo a leggere poesie e letteratura. È un’attività che amo e probabilmente è ciò che mi connette a Emanuele. Spesso quando facciamo tante cose non siamo capaci di trovare le parole giuste per descriverle ma, con il suo linguaggio, Emanuele ha reso tutto più chiaro e mi ha rivelato quali aspetti potevano essere spinti ulteriormente: io introducevo un’idea, lui introduceva un linguaggio e così abbiamo sviluppato la mostra.
ⓢ In passato ha dichiarato di non voler ricorrere all’uso dei manichini per esporre i vestiti, favorendo soluzioni alternative, spesso di natura installativa. In questo caso come ha voluto mostrare gli abiti e la loro relazione con il corpo che li abita?
Olivier Saillard: Devo confessare che ho spesso detto questa cosa ma a volte c’è davvero bisogno di usare i manichini: è il caso, per esempio, degli abiti di Cristobál Balenciaga e Christian Dior. In questa mostra, però, si parla della relazione tra l’abito e il suo proprietario, piuttosto che di marchi o etichette. Per esempio, una giacca poggiata su una sedia richiama immediatamente il corpo che l’ha appena lasciata, e questo è un aspetto molto più facile da mostrare senza manichini. Al contempo, abbiamo trovato un nuovo modo per presentare le creazioni della collezione ITS in una maniera che non fosse statica: li abbiamo fatti indossare a manichini che assumono le posizioni e i gesti dei visitatori della mostra. Tutti sono chinati a leggere i testi o rivolti verso gli abiti selezionati: questo cambia lo spazio e fa sentire i visitatori come parte della mostra. In effetti, ci sono tre mostre in una: la mostra sulle modalità di presentazione degli abiti, a casa o in un museo, quella dei finti visitatori che indossano i look dell’Arcademy e infine quella dei veri visitatori, che entrano anch’essi a far parte della mostra.
ⓢ Ha quindi voluto, come nelle sue performance, mostrare un lato più intimo della moda.
Olivier Saillard: Sì, è una cosa su cui ragiono da tempo e che mi appassiona. Ricordo che Issey Miyake diceva: «Quando un abito lascia il mio studio, è finito a metà. Solo quando qualcuno lo indossa allora è completamente finito». Ed è vero, perché un capo non è niente senza un corpo capace di imprimere su di esso una storia. Questo aspetto è stato tradotto nella mostra: abbiamo costruito una vetrina speciale in cui esporre, a turno, gli abiti personali degli abitanti di Trieste, che sono stati invitati a prestare un capo amato per la durata della mostra. Per l’inaugurazione è stato scelto un abito da sposa [realizzato da Valentino Garavani per l’ex modella Alda Balestra, nda] ma ci saranno anche vestiti ordinari. Ne sono molto fiero perché era qualcosa che sognavo di fare da tanto.

© Massimo Gardone
ⓢ Durante la conferenza stampa ha detto di aver spinto Saillard «a fare le cose più folli». Come è stato lavorare con lui nello sviluppo della mostra?
Emanuele Coccia: È stato molto bello. Io e Olivier ci conosciamo da tempo e ho un’enorme ammirazione per quello che ha fatto. È una persona molto rispettosa nel lavoro e quindi c’è stata un’alchimia perfetta. La mostra dell’anno scorso già aveva cartografato l’archivio e farne una seconda dello stesso tipo sarebbe stato noioso per Olivier e per il pubblico. Quindi mi sono detto che avremmo potuto inventare una mostra su cosa significa fare mostre, sviluppando una specie di retrospettiva su ciò che Olivier ha fatto finora. Lui è uno capace di inventare e creare, quindi ho spinto tantissimo per andare verso la massima radicalità, e Olivier ne è stato contento. È stato un andirivieni tra le sue idee e le mie: io provavo a “battezzare” e nominare le sue intuizioni e viceversa.
ⓢ Ha scritto e riflettuto sul rapporto tra moda e filosofia: in che misura queste riflessioni sono entrate a far parte della mostra?
Emanuele Coccia: Innanzitutto credo che la mostra in sé sia una forma di pensiero. Non c’è bisogno di trasportare un pensiero nella mostra, che è anzi una delle forme di pensiero più contemporanee. Siamo a abituati a credere che pensare significa scrivere o recitare parole dentro la nostra testa, però in fondo la mostra è un mezzo molto più radicale perché ti permette di pensare con qualsiasi cosa: con un pezzo di tessuto, con lo spazio, con dei profumi, con le atmosfere, con i colori e con le forme. È la forma di pensiero più universale e complessa, e io credo sempre di più che è attraverso le mostre che le città iniziano a pensare e che le culture possono definire la propria natura o anticipare ciò che vorrebbero essere. Quindi, più che di una trasfusione dentro la mostra di pensieri già formulati, si è trattato di capire come tradurre in parole il pensiero che la mostra compie attraverso gli abiti e lo spazio.
ⓢ Le molte vite di un abito racconta i nostri vestiti come piccoli musei ambulanti che, come ha spiegato, influenzano anche il paesaggio urbano. In che modo la mostra racconta questo aspetto?
Emanuele Coccia: Nella mostra c’è l’idea di fare una specie di fenomenologia museale dell’abito che inizia ogni mattina quando ci alziamo e apriamo il nostro armadio: questo è già un primo museo, una prima mostra in cui scegliamo come rappresentarci. E tutta la nostra vita è costellata da questi piccoli musei: le vetrine, ovviamente, ma anche gli abiti abbandonati a casa su una sedia, quelli lasciati sulla strada o i libri che parlando di abiti. Abbiamo voluto mimare e riprodurre nello spazio museale l’insieme di musei che gli abiti, in ogni loro postura, producono nel nostro quotidiano.
La foto in copertina è di © Massimo Gardone