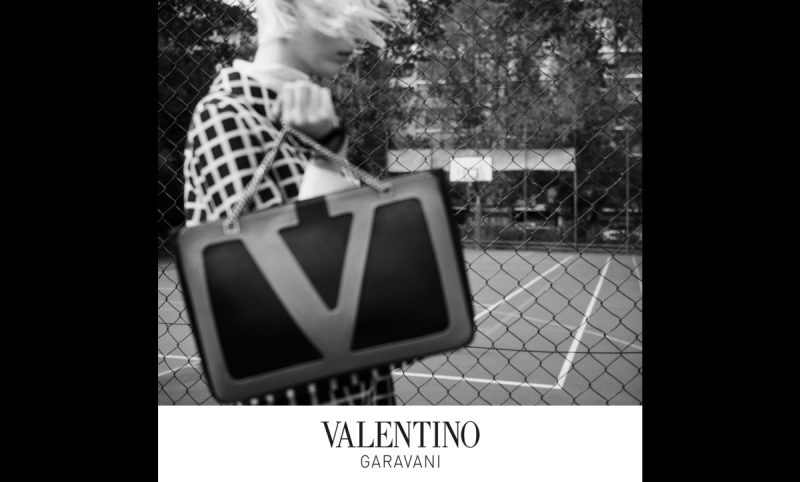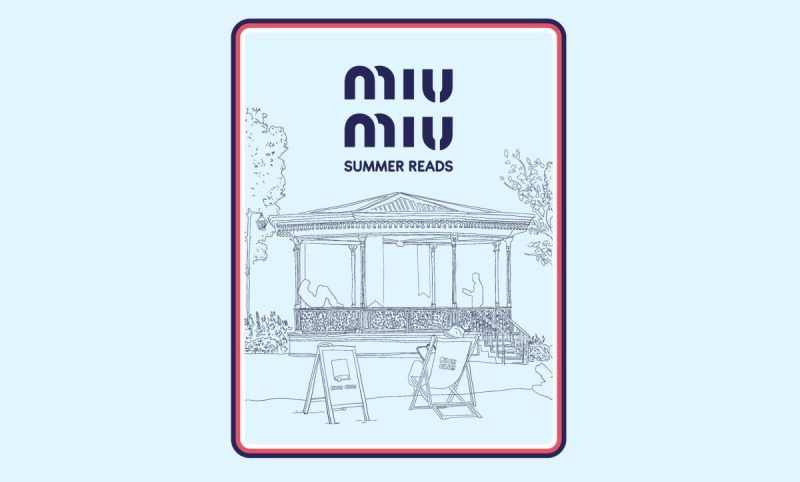Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.
Karl Lagerfeld, popstar
Si è spento a Parigi lo stilista che più di ogni altro ha saputo costruire il mito di se stesso.

Quando se ne va uno come Karl Lagerfeld trovare un angolo per raccontarlo è cosa difficile, viene bene a chi l’ha conosciuto, magari, o a chi ci ha lavorato insieme, mentre a noialtri non rimane che la leggenda, l’aneddotica, la lista dei traguardi, l’accenno alle polemiche, la citazione da postare su Instagram o su Facebook, anche perché lo stilista che ha disegnato Chanel per più di trent’anni e Fendi per più di cinquanta (cinquanta!) era uno di quelli che attraversava le nicchie e le categorie social, lo hanno ricordato in queste ore la stylist del magazine di ricerca di base a Berlino e la signora che compra Grazia. Perché Karl Lagerfeld era una popstar, d’altronde, e la sua scomparsa è affare di tutti. Mentre nelle timeline si moltiplicano i suoi ritratti in bianco e nero e gli articoli che ne raccontano la formidabile carriera, è d’obbligo riconoscergli quella capacità unica di costruire il mito attorno a se stesso, lui che dallo strombazzato dimagrimento dei primi Duemila – The Karl Lagerfeld Diet, il bestseller più bizzarro che un collezionista di libri e lettore fortissimo come lui potesse partorire – s’è cristallizzato nella forma eccentrica di aristocratico rock’n’roll con il codino bianco e cotonato, i jeans Diesel e la giacca Dior Homme, gli anelli e gli stivaletti a punta, con il tacco.
Come quelli prima di lui che la celebrità l’avevano afferrata, digerita e rigurgitata, Lagerfeld sapeva che cosa sarebbe piaciuto a tutti gli altri, prima del tempo, sapeva già del merchandising, per esempio, è s’è fatto portachiavi prima che stessimo qui a discutere di appartenenza e scene performative e diluizione delle controculture, sapeva già che la scure della democratizzazione digitale avrebbe investito l’elitario mondo della moda e ha inaugurato lui le collaborazioni del fast-fashion, nel 2004, quando Karl Lagerfeld e H&M nella stessa frase sembravano forieri di una promessa che tutto sarebbe cambiato per rimanere così com’era. È stato fotografo, editore, redattore, talent scout e consulente per i marchi prima che i nuovi direttori creativi andassero sbandierando il loro multitasking di necessità, è stato libero provocatore in un’industria che ancora non si accartocciava su stessa alla ricerca del suo ruolo nel mondo. A lui che amava il presente, come ci ricordano tutte le biografie di queste ore, piaceva la definizione di freelance, inteso nel senso più letterale possibile: libero di fare quello che voleva, come voleva, quando voleva. Come per i suoi monumentali show da Chanel, riedizioni in loop infinito di una grandiosità ormai quasi più sua che della fondatrice Coco, pure lei scaltrissima, e allora la spiaggia, il supermarket, le finte proteste femministe e il missile che va nello spazio, perché era uno dei pochi rimasti a poter fare tutto, sdoganare tutto, dire tutto.

Karl Lagerfeld nel 2016. Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images
Che non volesse più essere tedesco perché Angela Merkel accoglieva troppi migranti, ad esempio, lui tedesco borghesissimo di millantate origini aristocratiche che per ambientarsi a Parigi ha dovuto sgomitare come non mai, che Adele era bella e brava ma grassa, anche, e che molte di quelle attricette che l’ufficio del marketing gli proponeva come testimonial diosanto ma chi sono queste disperate, non ci sono più le attrici di una volta. Karl Lagerfeld era scorretto, anzi scorrettissimo, moderno e ancien régime allo stesso tempo, scevro da qualsiasi condizionamento che non fosse la sua stessa patologica dedizione al lavoro e la sua insaziabile curiosità intellettuale. Era arrivato da Fendi nel 1965, da Chanel nel 1983, Dior era sempre stata la sua fissazione, è rimasto a guardare le parabole tragiche e sfortunate di geni come Yves Saint Laurent e Gianfranco Ferré mentre il marchio che porta il suo nome rimaneva un divertissement e lui era solido e focalizzato sull’obiettivo come solo Hedi Slimane in tempi più recenti. È sopravvissuto alla maggior parte dei suoi pari che con lui hanno condiviso e reso grande la stagione lunghissima della moda come fenomeno mediatico, tutti per un periodo, più o meno ridotto, lui per tutti gli atti, tutte le puntate, tutto il film.
È morto a ottantacinque anni a Parigi, nel giorno in cui Londra e Milano si avvicendavano sul calendario delle sfilate, che noia la querelle sull’anno di nascita: finisce che ha rubato la scena ancora una volta e che gli hanno perdonato tutte le cattiverie, non che lui sembrasse uno a cui potesse importare qualcosa, d’altronde guarda cos’ha saputo costruire, per tutte le stylist e per tutte le signore che almeno una volta nella vita hanno desiderato una Chanel. Si porta con lui un’era, una sceneggiatura, un romanzo di quelli che non si scriveranno più, perché mancano le condizioni, sociali, economiche, culturali, se ne scriveranno altri, ne siamo sicuri, più belli o più brutti lo diremo poi. Karl Lagerfeld intanto se ne va da testimone, di se stesso prima di tutto e di un modo di fare e vivere la moda poi, e ci lascia un’enciclopedia da mandare a memoria, criticare e riscoprire da qui fino al prossimo best-seller. Lascia tutto al gatto Choupette, dicono ora le cronache, che aveva reso una social media star senza che noi potessimo mai varcare la soglia del suo privato, ennesima riprova che Karl Lagerfeld ci conosceva meglio di chiunque altro: chi ci piace, e ci rappresenta di più, dei gattini su internet?

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.

Il weekend lungo dedicato alle collezioni maschili, sempre più ristretto e sempre meno affollato, racconta bene la bizzarra situazione della moda oggi, che sembra non voler più lanciare grandi messaggi ma nascondersi nei vestiti che produce. Segno di tempi complicati o irrilevanza?