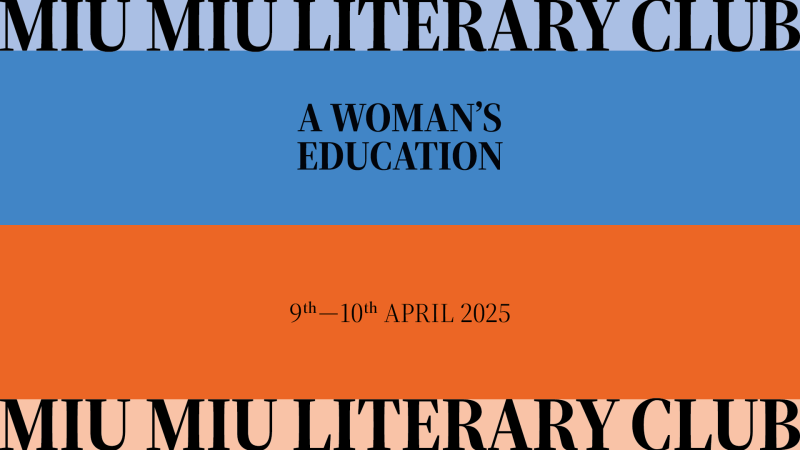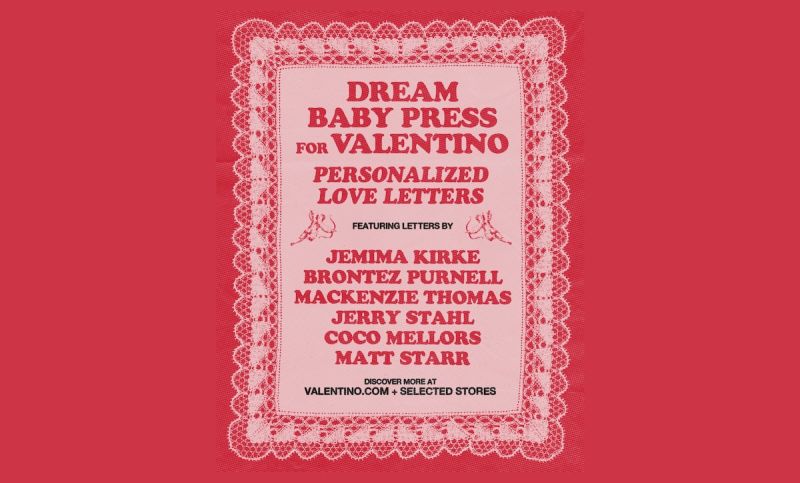Nascerà mai un grande gruppo della moda italiana?
Il post pandemia rafforza Lvmh, Kering e Richemont ma cambia anche le dinamiche interne dei nostri marchi. E ora Armani pensa a una collaborazione.

La moda in ripresa è anche la moda alla ricerca di simboli, di momenti da immortalare che dicano che sì, c’è vita oltre la crisi. E, infatti, il video che ritrae il presidente francese Emmanuel Macron ricevere l’applauso dei dipendenti del rinnovato grande magazzino di lusso Le Samaritane, a Parigi, riceve quasi 10 mila visualizzazioni, numeri alti per un contenuto social solitamente fruito dai soli addetti ai lavori. Ma quella riapertura non è un evento come un altro: fondato nel 1876 e chiuso nel 2005, Le Samaritane ha richiesto sedici anni di lavori e 750 milioni di investimenti al suo proprietario, Bernard Arnault, co-protagonista dell’evento di riapertura. Poche settimane fa Arnault era stato al centro di una giornata di news come colui che era riuscito a battere il patron di Amazon, Jeff Bezos, nella classifica degli uomini più ricchi al mondo. Il primo posto è durato solo qualche ora, ma ha dato il senso dell’impero che vi sta dietro. Il gruppo Lvmh, infatti, possiede 80 marchi, tra i quali alcuni dei più importanti nomi della moda – Dior e Louis Vuitton – e il distributore beauty Sephora. La riapertura del grande magazzino è un grande progetto, certo, e si appresta a dare lavoro a 3 mila persone tra il centro commerciale e l’adiacente hotel Cheval Blanc (sempre di proprietà Lvmh). Ma si inserisce in un’agenda fittissima, quella di Arnault, che solo negli ultimi mesi ha assunto il totale controllo del marchio Emilio Pucci, aumentato la sua partecipazione in Tod’s (ora al 10 per cento) e comprato Birkenstock e Tiffany&Co.(quest’ultimo dopo mesi di trattative complicate dalla pandemia).
Gli esperti avevano scommesso su un’impennata di fusioni e acquisizioni come prima grande conseguenza del settore dopo la crisi provocata dal Covid-19. Un’accelerazione che vede i forti diventare più forti, mentre i piccoli giocano di agilità per adattarsi ai cambiamenti e nel mezzo si apre una voragine. Lvmh non è l’unico ad aver dato uno sprint alle ricerche: lo stesso ha fatto il gruppo “rivale” Kering, sempre francese, guidato da François-Henri Pinault, già proprietario di marchi come Gucci, Saint Laurent e Balenciaga, che però si è concentrato su una tipologia di acquisizioni differenti. Arnault, infatti, punta sul consolidamento, così come aveva già fatto anni fa con l’acquisizione di Bvlgari che gli è valsa il raddoppio delle entrate. Pinault, invece, preferisce l’integrazione di parti della catena di approvvigionamento e investimenti sulle nuove tendenze di mercato. Ultimo in ordine cronologico è l’investimento in Cocoon, startup londinese specializzata nel noleggio di borse di lusso, preceduto da un grande round d’investimento nella piattaforma di rivendita di second hand e vintage Vestiaire Collective e da una nuova partecipazione nell’e-commerce Farfetch, che coinvolge il gruppo nella grande joint venture per la Cina voluta da Richemont e Alibaba.
E al di qua delle Alpi, cosa succede? La moda italiana ha una storia imprenditoriale diversissima da quelle francese, fatta, nel bene o nel male, da conduzioni familiari. I fratelli Mario (nonno di Miuccia) e Martino Prada aprono il loro primo negozio nel 1913, i coniugi Rosita Jelmini e Ottavio Missoni fondano la loro casa di moda nel 1953, Gianni Versace parte nel 1978 con l’aiuto dei fratelli Santo e Donatella, Valentino Garavani evita un’immediata bancarotta grazie all’entrata del socio e poi compagno di vita Giancarlo Giammetti, Giorgio Armani apre nel 1975 insieme a Sergio Galeotti, i Gucci vivono diverse vicissitudini familiari nel tentativo di controllo del marchio fondato da Guccio. Ognuna di queste storie ha seguito una traiettoria differente, eppure i protagonisti hanno qualcosa in comune: nessuno ha mai ambito ad acquisire gli altri. Chi più (oggi Giorgio Armani è il sesto uomo più ricco d’Italia) e chi meno (è nota l’allergia di Ottavio Missoni, scomparso nel 2013, all’idea di ingrandire l’azienda e dover lavorare quindi di più), ha guardato nel tempo all’espansione del proprio brand e non alla creazione di un conglomerato di marchi. La differenza è sostanziale anche in termini di competenze ai vertici dell’azienda: Arnault e Pinault sono imprenditori, Prada, Armani, Garavani e gli altri sono stilisti divenuti imprenditori.
Oggi di quella vecchia guardia non sono pochi i marchi rimasti, in parte o del tutto, ai fondatori originali: Giorgio Armani, Prada, Max Mara, Etro, Dolce&Gabbana, Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo. Ma altrettanti hanno venduto o accettato partecipazioni: Versace oggi fa parte della holding Capri, di proprietà di Michael Kors, Missoni ha ceduto il 40 per cento a FSI (Fondo Strategico Italiano), Gucci è di Kering, Fendi di Lvmh, Valentino di Mayhoola. Eppure qualcosa è cambiato anche da noi, complice l’entrata nel mercato di una generazione di proprietari con background e ambizioni che si distinguono da quella dei precedessori. Basti pensare a Remo Ruffini, proprietario di Moncler, che ha recentemente acquisito Stone Island, o a Renzo Rosso, fondatore di Diesel, ha riunito sotto la sua holding Only The Brave (OTB) marchi quali Maison Martin Margiela, Marni, Jil Sander, Amiri e Viktor&Rolf. Prima ancora la Aeffe di Alberta Ferretti aveva acquisito Moschino, Pollini e Philosophy di Lorenzo Serafini, mentre Liu Jo di Marco Marchi aveva rilevato la Blufin (Blumarine, Blugirl).
A guardarle da vicino le aziende che hanno abbandonato il modello familiare sono quelle che hanno anche subìto maggiori cambiamenti nella direzione creativa: Alessandro Michele da Gucci, Kim Jones da Fendi, Pierpaolo Piccioli da Valentino, infatti, sono tutti sono estranei alle dinamiche familiari precedenti, anche se vantano una lunga carriera nei marchi che poi sono andati a dirigere. Nel 2020 Miuccia Prada ha scritto il prossimo futuro del suo marchio con la scelta della co-direzione creativa insieme a Raf Simons. Ora, però, l’uomo al centro della conversazione è Giorgio Armani. Nel 2016 aveva creato una holding nel cui consiglio d’amministrazione risiedono lui, il collaboratore di lunga data Pantaleo Dell’Orco e il banker di Rothschild Irving Bellotti: l’obiettivo è di far proseguire nel tempo la sua idea di business. A luglio 2020, poi, Federico Marchetti, fondatore di Yoox e Amministratore delegato uscente di Ynap Group, è entrato nel consiglio di amministrazione della società, unico componente extra familiare (oltre a Dell’Orco ci sono la sorella Rosanna e i nipoti Roberta, Silvana e Andrea). Poi, nei primi mesi del 2021, le avvisaglie di una possibile apertura sono arrivate con l’intervista firmata da Jason Horowitz per Vogue Us nella quale Armani ha parlato per la prima volta di una possibile alleanza con un’altra grande azienda italiana, e non per forza del settore. Il nome ipotizzato nelle settimane seguenti è quello di Exor, la holding olandese controllata dalla famiglia Agnelli e che include tra i suoi investimenti Ferrari, marchio che recentemente ha presentato la sua prima collezione di abbigliamento e accessori disegnata da Rocco Iannone, ex ufficio stile Armani. Per ora l’affare è stato smentito o non ha ricevuto commenti ufficiali dai diretti interessati, con lo stilista che a Vogue.it ha detto di sentirsi ancora alla guida della sua azienda, anche se da anni preferisce «essere accompagnato da un autista». Ecco perché in molti auspicano di vederlo a capo di una nuova avventura, quella di una grande joint-venture italiana.