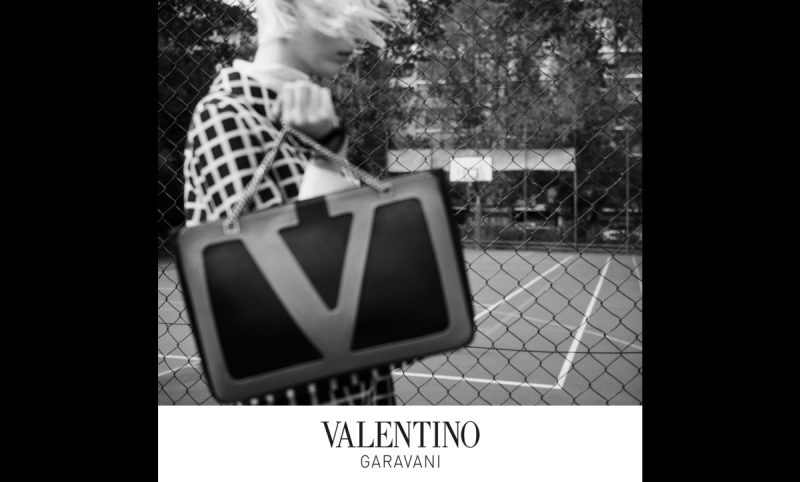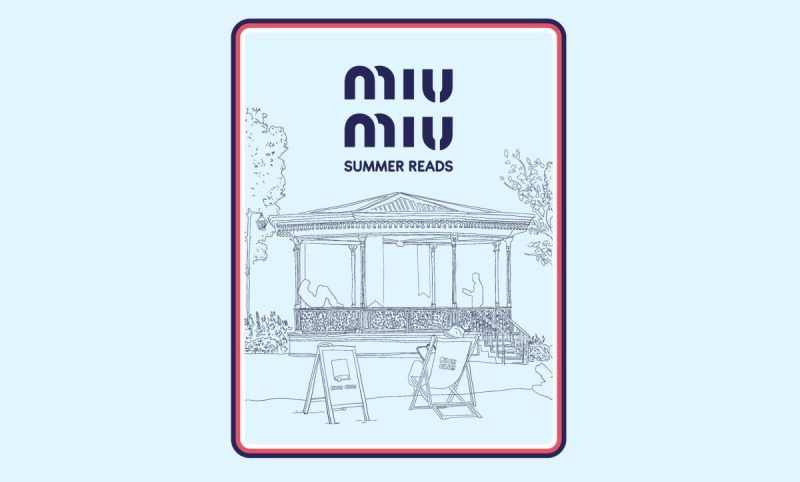È il secondo capitolo della collaborazione tra i due marchi, lanciata lo scorso settembre con una collezione maschile il cui testimonial d'eccezione era Martin Scorsese. Ora, per la prima volta, comprende anche una collezione donna.
A proposito di magliette brutte
Lo streetwear rivisitato ai limiti della parodia di Gosha Rubchinskiy e la curatela di Raf Simons: cosa è successo al Pitti di quest'anno.

A quanto pare, il russo Gosha Rubchinskiy ha trovato l’unico palazzo in tutta Firenze che in qualche modo richiamasse l’architettura sovietica, ovvero l’ex Manifattura Tabacchi, e lì ha deciso di tenere il suo show. L’ultimo fenomeno dello streetwear passatista, il designer di culto di quelli che leggono Hypebeast e Highsnobiety, il protetto di Rei Kawakubo e del marito Adrian Joffe (le menti creative dietro Comme Des Garçons e Dover Street Market), insomma, il Demna Gvasalia di questa seconda parte del 2016, ha portato alla novantesima edizione di Pitti Uomo il suo esercito di adolescenti arrabbiati, strafottenti e mal vestiti.

Gli stessi che avevamo visto durante l’ultima stagione dell’uomo a Parigi, ma chissà perché vederli sfilare nella città che ospita la più importante rassegna di moda maschile al mondo, ha sortito per molti un effetto quasi estraniante. Intanto perché, oggettivamente, Rubchinskiy disegna abiti “brutti”, ma non brutti à la Miuccia Prada, non brutti-filosofici o meta-belli, proprio brutti e basta. «Avevo una felpa simile della Fila comprata al supermercato. Al supermercato!», mi ha scritto una collega da Firenze. «E pensare a tutte quelle orrende felpe che ho buttato», ha scherzato un altro su Facebook. Proprio così: la collezione Primavera Estate 2017 di Gosha ha recuperato tutto quei marchi sportivi pre-Internet – come Fila appunto, ma anche Robe di Kappa e Sergio Tacchini – che ancora non erano classificabili né come sportswear né come athleisure, ma hanno segnato comunque intere generazioni. Chi non aveva quella famosa felpa di Fila? È il personale omaggio del designer allo “stile italiano”, che chiaramente qui non sembra essere quello classico.

O forse sì, a suo modo: lo ha notato Alexander Fury nella sua recensione, quando scrive «Quello che colpisce del debutto italiano di Gosha sono paradossalmente gli ensemble sartoriali, che offrono ai suoi abitué qualcosa di diverso e magari si assicurano nuovi clienti. Il completo gessato che ha aperto la sfilata, un paio di giacche di velluto a doppio petto, dai tagli ampi e liquidi sul corpo, avevano addirittura il tocco di un altro designer celebre per il modo in cui ha ridisegnato la silhouette. Giorgio Armani». E cosa c’è di più italiano di Giorgio Armani? L’altro grande elefante nella stanza era nientemeno che Pier Paolo Pasolini, al quale la collezione era dedicata, e si sa, quando c’è Pasolini di mezzo è sempre difficile azzeccare il tributo. In molti hanno scritto come i ragazzi di Gosha richiamassero (o volessero farlo) i ragazzi di vita pasoliniani, ma al di là degli accostamenti scivolosi, quello che è interessante notare della gang costruita ad arte dalla stylist Lotta Volkova – sì, sempre lei, quella di Vetements – è che vuole essere una rappresentazione, molto Instagram (ai ragazzi cool piace!) e scevra di intellettualismi, di un Paese, la Russia di Putin, che è a oggi fra i più feroci oppositori dei diritti degli omosessuali. E non è un caso che tutti siano emigrati a Parigi: viene da chiedersi se potrebbero fare le stesse cose nella madre patria. D’altronde, quella “post-sovietica” è molto più di un’estetica, come racconta il fotografo russo Egor Rogalev in una bella intervista a Dazed & Confused.

L’altro aspetto da indagare è il citazionismo: il designer ha infatti ottenuto, tramite accordi con i marchi sopracitati, la possibilità di utilizzare i loghi e di “customizzarli” – vedi le scritte russe che campeggiano sulle magliette o i Levi’s rivisitati –, il che se vogliamo è il risultato estremo del fenomeno delle collaborazioni, particolarmente rilevante nello sportswear. Quindi sì, se Gosha Rubchinskiy alzerà i prezzi delle sue brutte magliette – proprio come quella lì di Vetements – avremo tutti il diritto di alzare gli occhi al cielo e aspettare che questa brutta moda passi – in fondo è un tutto un ciclo no? Basta avere pazienza – altrimenti non ci resta che prendere atto che anche questo è menswear, sebbene abbia il sapore di una presa in giro.

La stagione del Pitti – dopo i pure interessanti divertissement di London Collections: Men – è sembrata insospettabilmente allineata con il presente, anche grazie alla sfilata di Raf Simons, il cui protagonista assoluto era un altro personaggio icona gay, Robert Mapplethorpe. Il lavoro del celebre fotografo, i suoi studi sulla nudità, le nature morte e i ritratti, diventano per il designer belga l’occasione di cimentarsi con un immaginario fetish che si amalgama felicemente al suo, popolato anch’esso da ossessioni molto simili. La collaborazione nasce per volontà della Fondazione Mapplethorpe, che ha individuato in Raf Simons il designer giusto per il progetto, nello stesso anno della doppia mostra dedicata al fotografo negli spazi del Getty Museum e del LACMA di Los Angeles e del documentario di recente uscita Look at the pictures!.

E ha funzionato: l’approccio di Simons è stato curatoriale, a partire dal setting della sfilata, che si è svolta alla stazione Leopolda. Le installazioni e i manichini vestiti con pezzi dell’archivio Simons, il consueto stand-up di tutti gli ospiti, le stampe che venivano fuori dai tagli slabbrati di giacche e camicie, i berretti di pelle: è molto più di un omaggio zoppicante o peggio disonesto, ma parliamo di Raf Simons, quindi non c’è da stupirsi che abbia fatto tutto bene, è pur sempre il primo della classe. I guest-designer stranieri, comunque, non sono stata l’unica cosa degna di nota di questa edizione numerologica di Pitti: come non citare Lucio Vanotti, ospite di Pitti Italics, che non ha bisogno di recuperare l’armentario dell’adolescenza per realizzare capi contemporanei e desiderabili?

Sullo sfondo, poi, c’è la fiera vera e propria, la più importante al mondo, dicevamo. Pitti è più solido che mai: ingloba il nuovo, accoglie e promuove, in qualche modo “istituzionalizza” la tendenza, ma non se ne fa mai travolgere e questo è particolarmente rilevante in un momento in cui la decisione di alcuni marchi di far sfilare le collezioni uomo e donna insieme, di cui si è discusso molto negli ultimi mesi, ha sollevato il dubbio che la prima vittima designata sarebbe stato proprio il menswear. Eppure, abbiamo spesso parlato della moda uomo come di quell’angolo felice dove era ancora possibile conquistare il mercato.
Con le dovute accortezze, quello maschile sembrava quasi l’ultimo scoglio a cui aggrapparsi nel mare di disillusione in cui naviga il settore oggi, tant’è che anche da Balenciaga e da Stella McCartney, per esempio, si son detti che era il momento giusto per provare a sfondare da quella parte. Nel giorno in cui la poetica africanista della giovane Claire Wales Bonner si aggiudica il prestigioso LVMH Prize – che equivale a 300.000 euro di contributo concreto per incrementare il suo business – e dopo la schizofrenica stagione delle Resort di cui si fatica a cogliere il senso (vedi Chanel a Cuba e Louis Vuitton a Rio), quello del guardaroba maschile rimane ancora un osservatorio interessante, sebbene, sì, siam finiti a parlare di magliette (brutte).
In testata: la sfilata di Gosha Rubchinskiy alla Ex Manifattura Tabacchi. Nel testo: foto 1 e 2 Gosha Rubchinskiy Primavera Estate 2017. Credits: Giovanni Giannoni Courtesy of Pitti Uomo; foto 3 la stylist Lotta Volkova, Credits: Courtesy of Pitti Uomo; foto 4 Raf Simons sistema i modelli della sua sfilata prima dell’uscita. Credits: Vanni Bassetti Courtesy of Pitti Uomo; foto 5 un modello durate la sfilata di Raf Simons. Credits: Giovanni Giannoni Courtesy of Pitti Uomo; foto 6 Modelli nel backstage della sfilata di Lucio Vanotti. Credits: Courtesy of Pitti Uomo
.

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.