Feltrinelli torna alla vittoria 20 anni dopo l'ultima volta.
Gli americani di Sullivan
Per Sellerio esce Americani, la raccolta di saggi di John Jeremiah Sullivan, scrittore e giornalista quarantenne tra i più interessanti della sua generazione, senza aver mai scritto una riga di pura fiction.
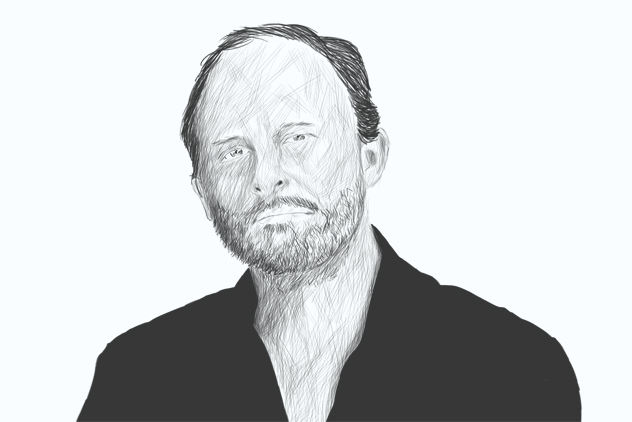
John Jeremiah Sullivan scrive o ha scritto per Harper’s, GQ America, New York Times Magazine, New York Magazine e Paris Review, della quale è anche southern editor. Ha pubblicato due libri. Il primo – Blood Horses: Notes of a Sportswriter’s Son del 2004 – è un saggio sull’origine delle corse di cavalli, sul presente delle corse di cavalli e sui cavalli tout-court, intrecciato a un lungo e mai patetico ricordo del defunto padre dell’autore, giornalista sportivo e tabagista terminale. Il secondo, Pulphead del 2011, è una raccolta di quattordici saggi brevi (dove per breve si intende da un minimo di dieci a un massimo di quaranta pagine) apparsi sulle riviste menzionate sopra. Americani, invece è il titolo dell’edizione italiana di Pulphead (traduzione di Francesco Pacifico) che Sellerio ha pubblicato appena poche settimane fa.
Negli ultimi tempi John Jeremiah Sullivan – che è nato a Louisville, Kentucky, nel 1974 – è diventato il mio “nuovo” scrittore americano di riferimento senza avere mai scritto una riga di pura fiction. Per chiarire cosa intendo con “di riferimento” devo specificare che, da quando ho letto Pulphead per la prima volta, ho sviluppato una specie di ossessione per la scrittura di Sullivan; nonché aggiungere che non appena ho saputo di questa uscita italiana, nel giro di dieci giorni sono andato a rileggermi praticamente tutta la sua produzione, nonostante in gran parte l’avessi già letta e in alcuni casi anche più volte. Il che significa che in dieci giorni ho letto pezzi incredibilmente profondi, commoventi, illuminanti, divertenti – a volte tutte queste cose insieme, altre semplicemente di una “stranezza” che non può lasciare indifferenti – sulle seguenti cose: Disney World, un naturalista francese dell’800 di nome Rafinesque, Michael Jackson, la crisi irlandese e John Synge, come si vive in una casa affittata per una sit-com, William Faulkner, il futuro di Cuba. E poi ancora: la più completa riflessione sul retroterra culturale del Tea Party che abbia letto, un disturbante ritratto di un intellettuale del Tennesse (tra i primi a pubblicare Cormac McCarthy) ormai in punto di morte, le sorelle Williams, Bunny Wailer, il reality di MTV Real World, bluesmen dimenticati, Axl Rose e infine due dei migliori saggi/recensioni mai scritti sul conto di due autori per cui in passato ho sviluppato una forma di dipendenza simile a quella per Sullivan: Denis Johnson e David Foster Wallace.
Sullivan ha scritto, tra l’altro, di: Disney World, un naturalista francese dell’800 di nome Rafinesque, Michael Jackson, come si vive in una casa affittata per una sit-com, William Faulkner, il futuro di Cuba. E poi ancora: la più completa riflessione sul retroterra culturale del Tea Party che abbia letto, un disturbante ritratto di un intellettuale del Tennesse ormai in punto di morte, le sorelle Williams, Bunny Wailer e il reality di MTV Real World.
Quello con Wallace oltretutto è l’accostamento che ricorre più spesso nelle numerose recensioni di Pulphead che ho letto e negli stessi blurb del libro. Secondo Wells Tower «è la raccolta di saggi più ispirata dai tempi di Una cosa divertente che non farò mai più», secondo il New York Times, i saggi di Sullivan «sono esoterici, in un modo al crocevia tra McPhee e Wallace», secondo il New Yorker JJS è «paragonabile a Tom Wolfe e David Foster Wallace, ma più benevolo del primo e meno nevrotico del secondo». Secondo Francesco Pacifico, che lo ha tradotto e a cui ho chiesto cosa pensava di questi paragoni nel corso di una breve chiacchierata su Skype in tema J.J., l’unico nesso tra i due è «che entrambi ti danno la sensazione di divorarli, di avere tra le mani una cosa complessa, interessante e di valore, in cui ti viene voglia di immergerti proprio a un livello fisico».
Il che mi ha senz’altro aiutato a sentirmi meno solo nella mia “ossessione” ma mi ha lasciato nel dubbio sulle ragioni che la alimentano. Cosa, io e alcune altre persone che sono state mesmerizzate dal talento di questo scrittore non-fiction, troviamo in lui di tanto attraente? Cosa ce lo fa percepire come un autore così importante da consumare? A questo punto stavo pensando di fare un elenco di alcune delle qualità che amo della scrittura di Sullivan, poi mi sono ricordato di alcuni paragrafi che Sullivan ha scritto a proposito di Wallace nel saggio già menzionato:
«Quando si dice che era uno scrittore generazionale, che “parlava per una generazione”, in un certo senso è pressoché scientificamente vero. Tutto ciò che sappiamo sul modo in cui la letteratura si crea suggerisce l’esistenza di una connessione tra il talento individuale e la società che lo produce, l’organismo sociale. La cultura estrae geni nello stesso modo in cui un alveare proclama una nuova regina dopo la morte della precedente, e oggi possiamo guardare a Wallace come a una di esse. Ricordo, abbastanza bene da sapere che non si tratta di uno scherzo della memoria, di aver sentito parlare e poi di aver letto Infinite Jest a vent’anni, e di aver provato immediatamente qualcosa tipo: “Ecco, ci siamo!”. Qualcuno di noi ci sta provando. Sta provando a catturare la sensazione di essere in vita in una superpotenza spezzata, sul finire del ventesimo secolo. È arrivato qualcuno dotato di un intelletto potenzialmente abbastanza robusto da riflettere il panorama e un rigore morale abbastanza sviluppato da volerlo fare, in primo luogo. Pressoché nessuno dei suoi contemporanei–compresi quelli che in termini di pura abilità potevano competere con lui–si è preso il rischio di un fallimento più grande».
Sullivan conclude così quel saggio:
«Il lavoro di Wallace verrà visto come un incredibile fallimento, non in senso peggiorativo, ma in quella peculiare accezione intesa da Faulkner quando, in proposito dei romanzieri americani, disse: “Ci valuto sulla base dei nostri splendidi fallimenti nel fare l’impossibile”. Wallace ha fallito meravigliosamente».
Non ho citato questi due paragrafi per protrarre il paragone con Wallace ma perché in controluce dicono qualcosa di fondamentale riguardo a Sullivan come esponente eccezionalmente dotato della generazione di scrittori venuti dopo Wallace. Qualcosa che ha a che fare con un’altra cosa ancora, sempre di Sullivan e sempre dallo stesso saggio/recensione del Re Pallido.
«Immagina di entrare in un posto di lavoro, diciamo una copisteria in franchising all’interno di un centro commerciale. È mattina presto e sei il primo cliente. Ti fermi e lasci che le porte scorrevoli si chiudano alle tue spalle, osservi gli impiegati nelle loro divise blu, le bocche aperte, che si aggirano struscianti e assonnati. Li percepisci come un’immagine unica, con un’impenetrabile superfice di vagua noia e insoddisfazione a cui sei felice di essere estraneo, e quindi procedi a fare quello per cui sei venuto, fotocopie o quant’altro. Quello è esattamente il momento in cui Wallace schiaccia pausa, quella prima piccola svolta verso la distrazione, verso l’egocentrismo. Poi torna indietro e schiaccia di nuovo play. Ora è diverso. Sei in una stanza con un gruppo di esseri umani. Ognuno di loro, come te, è stato spezzato e si è medicato in qualche modo buffo. Ognuno di loro, anche il più banale, nasconde un romanzo dentro di sè. Ognuno è amato da Dio o merita di esserlo. Tutti loro hanno qualcosa a che fare con te. Quando lasci che la membrana della tua consapevolezza diventi porosa, quando permetti all’osmosi di avvenire, sai che è vero, abbiamo qualcosa a che fare l’uno con l’altro, siamo parte di una narrativa–già ma quale? Wallace aveva un estremo bisogno di saperlo. E sentiva che il mondo moderno ci stava bombardando di scenari, proprio come l’interno della copisteria, dove era comodo dimenticarsi completamente di questa domanda».
E credo sia per l’aver potuto ammirare, ponderare e soprattutto accettare quel fallimento, che la voce di Sullivan sgorga così contemporanea, una voce di “seconda generazione” rispetto a quella di Wallace.
Credo sia quel “già, ma quale?” l’impresa impossibile in cui Wallace ha meravigliosamente fallito. E credo sia per l’aver potuto ammirare, ponderare e soprattutto accettare quel fallimento, che la voce di Sullivan sgorga così contemporanea, una voce di “seconda generazione” rispetto a quella di Wallace. Ed è il fatto che, nonostante Sullivan sia consapevole della certezza del fallimento, provi comunque a trovare, seppure con strumenti diversi, una risposta a quella stessa domanda, ciò che lo rende così vivo, importante e capace di sintetizzare la sensibilità del tempo in cui viviamo e dirci qualcosa su essa.
Wallace cercava di mettere il mondo moderno tra due parentesi ironiche per grattarne via gli”scenari” che ci distolgono dalle connessioni essenziali e dalla possibile redenzione morale. Per Sullivan invece lo “scenario” è esattamente il punto, la patina di finzione e artificiosità che riveste le nostre vite è proprio il livello a cui le connessioni essenziali si svolgono e da cui devono essere fatte emergere e raccontate, anche se non è detto che conducano poi a una qualche sorta di redenzione morale. Per continuare con l’immagine della copisteria, JJS è il tipo che facendo “le fotocopie o quel che vi pare”, si metterebbe a origliare con vivace curiosità le conversazioni degli “impiegati in divisa blu” e che saprebbe fiutare una storia, una scintilla di umanità, all’interno del dettaglio apparentemente più sciatto e insignificante.
A quanto ha dichiarato qualche tempo fa, molti dei suoi pezzi nascono semplicemente dall’interesse per un luogo, dall’idea di un viaggio, mentre fa delle ricerche per altri pezzi, oppure da strane esperienze personali – come una gita a Disney World, con la sua famiglia e quella di un amico dipendente da cannabis – di cui poi decide di scrivere, riuscendo sempre a fare affiorare qualcosa di eloquente anche da materiali scarsissimi o a prima vista del tutto inutilizzabili. È uno scrittore che vive prima di scrivere, che si “compromette” con le cose che racconta ed espone se stesso, parti anche scabrose della propria esperienza personale, con una libertà che quasi nessuno nel panorama letterario americano si è permesso negli ultimi anni. E anche per questo tra le sue pagine non troverete mai del distacco analitico o morale, dell’ironia crudele o mistificante, dell’altezzosità intellettuale o la fredda “oggettività” del giornalismo alla New Yorker (sul cui conto Sullivan ha scritto: «Il pezzo da rivista ben temperata, per quanto estremamente piacevole, è una sorta di cuneo fascista che cerca di farti dimenticare i suoi problemi, le sue mezze verità, le sue decisioni arbitrarie, e farti così mandar giù il suo inesistente imprimatur»). Quello che troverete è il punto di vista del tutto soggettivo di un osservatore acuto e sensibile, capace di essere esilarante con la stessa facilità con cui può rivelarsi morboso, e che soprattuto non dimentica mai che se pure c’è scritto non-fiction, nel momento in cui ne scrivi stai comunque raccontando una storia.
In uno dei pezzi più belli della collezione sulla vita dei protagonisti del reality di MTV Real World dopo la fine della trasmissione, Sullivan non cede mai alla tentazione di fare dell’ironia o di esercitare il giudizio dell’intellettuale condiscendente su di loro. Tutt’altro: quello che fa è dichiararsi apertamente un fan duro e puro della trasmissione e iniziare, grazie al contatto privilegiato con i protagonisti, a soddisfare le sue curiosità in merito con domande interessanti – proprio perché provengono da una persona estremamente competente in materia – sul suo funzionamento e attraverso di esso dedurre qualcosa di più generale sul funzionamento della società che lo ha prodotto.
«My God, there have been more tears shed on reality TV than by all the war-widows of the world. Are we so raw? It must be so. There are simply too many of them—too many shows and too many people on the shows—for them not to be revealing something endemic. This is us, a people of savage sentimentality, weeping and lifting weights».
Quello che fa è scrivere una scena al cui centro si trova Miz, una specie di star del programma a metà tra un tronista e un wrestler, citando abbastanza palesemente il modo in cui Gay Talese cinquant’anni fa scrisse una scena al cui centro si trovava…Frank Sinatra nel più celebre pezzo della storia del new journalism. Sullivan non affetta nostalgie o pose da “un tempo sì che…”, sembra semmai voler suggerire una continuità al di là delle vistose differenze tra i due personaggi; l’idea che siano due espressioni dello stesso fenomeno, semplicemente aggiornato allo spirito e alle modalità dei tempi. Come ha scritto una rivista “ben temperata“: «his talent is beautifully for the real; or, rather, for the real fictions that people make of the real, and which they live by. (The really real.)»
Illustrazione di Jacopo Marcolini
Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.



