Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.
Buon compleanno, Kenshiro
A trent'anni dalla prima messa in onda in Giappone, un po' di storia e ricordi di uno dei cartoni animati più violenti, discussi ma anche amati degli anni '80.

L’esperienza infantile dei maschi italiani nati negli anni ’80 può essere ripartita in tre grandi insiemi: i bambini a cui era permesso guardare Ken Il Guerriero, quelli a cui era vietato dai genitori e quelli che trovavano comunque un modo per. Per quanto mi riguarda, li ho frequentati tutti e tre. Mia madre era infatti contraria all’idea di lasciarmi venti minuti davanti al menù a base di calotte craniche esplose, membra roteanti e corpi affettati spadellato quotidianamente dal cartone ma, dato che coglievo ogni occasione per eludere il veto – a casa di un amico con una famiglia un po’ distratta o di una nonna molto ipovedente – dopo un paio d’anni dovette cedere alla mia ostinazione da carbonaro.
Per chi è nato troppo lontano dal decennio in questione, Ken Il Guerriero (in giapponese Hokuto No Ken, ovvero Pugno della Stella del Nord) è un anime trasmesso per la prima volta in Giappone nell’ottobre 1984. Trent’anni fa. Ventisette per l’Italia, dove esordì nel 1987 perpetuandosi da lì in poi per un numero incalcolabile di repliche.
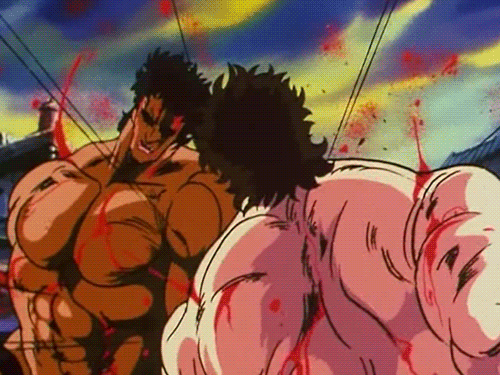
Come spiegava (e probabilmente spiega tutt’oggi su qualche oscura emittente locale) una voce narrante all’inizio di ogni episodio, Ken Il Guerriero è ambientato «alla fine del ventesimo secolo» in un mondo «sconvolto dalle esplosioni atomiche» e racconta le vicende di Kenshiro, un tipo estremamente muscoloso, nonché l’ultimo maestro di una potente arte marziale chiamata Hokuto, che vagabonda per questo medioevo post-apocalittico raddrizzando torti mentre cerca l’amata rapita da un rivale. Con questi presupposti Hokuto No Ken è quello che nella classificazione giapponese si direbbe uno shōnen: una tipologia di manga/anime che segue un canovaccio per cui l’eroe deve superare una serie di prove intermedie, propedeutiche allo scontro con la supernemesi finale.
Hokuto No Ken è quello che nella classificazione giapponese si direbbe uno shōnen: una tipologia di manga/anime che segue un canovaccio per cui l’eroe deve superare una serie di prove intermedie, propedeutiche allo scontro con la supernemesi finale.
Uno shōnen è destinato di solito a un pubblico di adolescenti. Tuttavia la proliferazione di reti private nei nostri anni ’80 e i costi modici dei diritti sui cartoni nipponici avevano determinato una diffusione degli anime in Italia molto più capillare che altrove; una messe in cui non si stava troppo a separare il grano dal loglio. Ed è così che, facendo zapping tra Scooby Doo e programmi per l’infanzia registrati in studi male illuminati, al bambino italiano in età pre-scolare o poco più poteva capitare di incontrare questo mondo ipertrofico, in cui il personaggio più positivo di tutti era comunque uno che, nella vita, faceva esplodere i nemici dall’interno “con la sola imposizione delle mani”. Un’abilità che, come si può immaginare, in nove pargoli su dieci ha l’effetto di un’iniezione di glucosio.
Prima dell’incarnazione animata, nel 1983 Hokuto No Ken era apparso in Giappone come manga a opera delle chine del disegnatore Tetsuo Hara e della penna dello sceneggiatore Sho Fumimura, in arte Buronson, omaggio a Charles Bronson. Il Giappone di inizio ’80 era una nazione in crescita economica costante, non ancora quella del boom di fine decennio ma decisamente un paese che si affacciava sempre di più alla finestra del mondo, uscendo dal relativo isolamento culturale delle prime decadi del dopoguerra. Tra gli effetti collaterali di questo processo ci fu anche il crescente assorbimento di feticci occidentali e in particolare hollywoodiani, giunti a soppiantare o integrare le spore culturali autoctone. Un fenomeno a cui, ovviamente, i manga e gli anime non erano estranei e che, anzi, tra gli altri, trovò proprio negli autori di Kenshiro un terreno fertile.
Da qualche tempo prima dell’uscita del fumetto di Hokuto No Ken, il ventiduenne Hara stava infatti mettendo a punto un nuovo personaggio, un maestro di arti marziali in grado di uccidere i nemici con l’agopressione di specifiche parti del corpo (Hara era a sua volta un esperto di agopuntura e simili), e in effetti aveva già fatto uscire due brevi storie, ambientate nel Giappone dell’epoca, con una bozza di questo protagonista. Le cose presero una piega definitiva quando l’editor di una rivista di manga a cui entrambi collaboravano mise Hara in contatto con Fumimura, il quale, da appassionato di cinema occidentale, suggerì di spostare l’ambientazione della storia in un futuro post-atomico alla Mad Max, film cult con Mel Gibson del 1979, al quale peraltro Hara si era già ispirato per una delle sue precedenti storie brevi, Mad Fighter. Da questo incontro tra un appassionato di agopuntura e uno di Charles Bronson nacque infine Kenshiro.
Le cose presero una piega definitiva quando l’editor di una rivista di manga a cui entrambi collaboravano mise Hara in contatto con Fumimura, che suggerì di spostare l’ambientazione della storia in un futuro post-atomico alla Mad Max.
Con una coppia di autori del genere non poteva che venire fuori un papocchio postmoderno, quale in effetti Ken Il Guerriero è. Se le dosi di splatter dispensate a piene mani dal cartone per tutte le 152 puntate lo resero all’istante materiale da MOIGE, le compenetrazioni di stili e i riferimenti a un universo pop vivacissimo ed estremamente eterogeneo erano ciò che lo faceva apprezzare da noi piccoli spettatori, peraltro inconsapevoli del bombardamento di topoi a cui eravamo sottoposti.
In Ken Il Guerriero l’ibridazione tra canone occidentale e orientale non riguardava solo l’ambientazione – in cui l’anti-western conviveva con il trauma atomico di Hiroshima e Nagasaki – era letteralmente ovunque. Proprio perché la struttura degli shōnen ricorda un po’ quella di un videogioco platform, e vuole che il protagonista affronti prima una nutrita selva di nemici comuni scarsamente connotati, poi una serie di boss intermedi sempre più attrezzati e infine il boss finale, Buronson e Hara si divertirono a infilare di tutto nella caratterizzazione dei personaggi incontrati da Kenshiro nei vari livelli (per continuare con un dizionario videoludico) della sua avventura.
Se nel personaggio di Kenshiro convivevano un po’ di Sylvester Stallone e un po’ di Bruce Lee, tra i suoi antagonisti e comprimari si trovava l’intero bestiario che la cultura pop nippo-americana anni ’80 aveva da offrire.
Se nel personaggio di Kenshiro convivevano un po’ di Sylvester Stallone e un po’ di Bruce Lee, tra i suoi antagonisti e comprimari si trovava l’intero bestiario che la cultura pop nippo-americana anni ’80 aveva da offrire. C’erano maestri di arti marziali à la Keisuke Myagi e orde di punk motociclisti, berretti verdi rinnegati à la Rambo e lotattori di sumo, delle specie di vampiri e delle specie di zombie, citazioni da altri anime così come da fumetti occidentali oltre, ovviamente, a un’infinità di personaggi il cui disegno era plasmato su celebrità dell’epoca. Da Schwarzenegger a Boy George, da Mr. T ad Hulk Hogan, da Mickey Rourke a Dolph Lundgren, da Freddie Mercury a Rutger Hauer risalire alle controparti reali dei personaggi di Ken Il Guerriero significa in pratica stilare un “chi era chi” degli anni ’80. Anche per questo seguirne gli sviluppi era un po’ come guardare un b-movie kung-fu, dentro un film d’azione, dentro un incontro di wrestling con dentro una telenovela – data la quantità di morti apparenti, colpi di scena e legami famigliari tra i personaggi di cui era infarcita la trama. Il tutto ambientato in un mondo nato da un brainstorming tra Sergio Leone e George Miller.
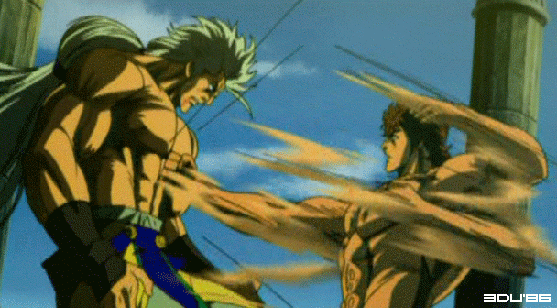
A dispetto della quantità di violenza che innaffiava tutte la serie e della barbarie della realtà che raccontava, visto col senno di poi l’universo etico di Kenshiro era però in fondo estremamente edulcorato e buonista, più adatto a un melodramma che all’epica a cui qualcuno l’ha accostato. Il male, o almeno quello che veniva discusso approfonditamente, quello compiuto dalle nemesi maggiori (e non da generici predoni e cattivi di serie Z) era soltanto frutto di un malinteso sulla strada del bene, i peccati e gli eccessi alla fine venivano sempre scontati, e all’ultimo secondo utile prime di morire anche il più malvagio dei malvagi (almeno tra gli antagonisti principali di Ken) aveva la sua occasione di redimersi.
Se c’era dell’epica in Kenshiro, più che nell’insieme dell’opera risiedeva nei dettagli che oliavano il complesso sistema di torti che legavano un personaggio della serie all’altro anche a decenni narrativi di distanza. Quei dettagli per cui – quando alla fine Kenshiro, con la sua anatomia improbabile e le gambe lunghe il triplo del busto, si allontana per sempre sul suo cavallo nero con un occhio solo e ricorda tutti gli avversari affrontati e gli amici perduti – lo spettatore, bambino o meno, si sentiva anche lui giunto alla fine di un’esperienza, in qualche modo toccante e complessa. Un’esperienza sicuramente anche eccessiva, ingenua e un po’ pasticciata, come il decennio che l’aveva partorita, ma che comunque era valsa la pena di fare. Perché al di là dello shock value e delle polemiche legate alla sua grande violenza e di noi che alle elementari provavamo a farci “esplodere” a vicenda ripetendo ata-ta-ta-ta con le nostre vocette stridule e i nostri pugnetti imbelli, se a sette anni mi sono appassionato alle storie ben raccontate, ho provato i miei primi brividi da emozione narrativa e la sensazione di stare guardando qualcosa che trascendeva lo spazio che occupava, non lo devo ai cartoni per bambini per bene che trasmettevano sulle reti nazionali ma a questa pulsar di iperboli che davano alle 17 su Italia 7 (non ancora Gold).
Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.



