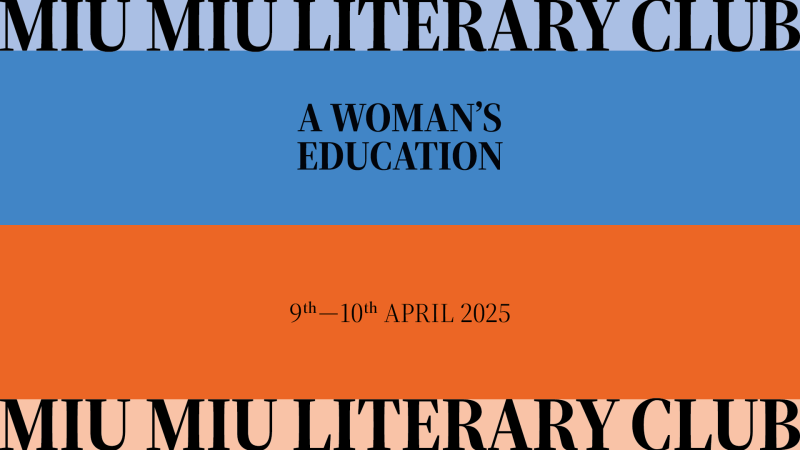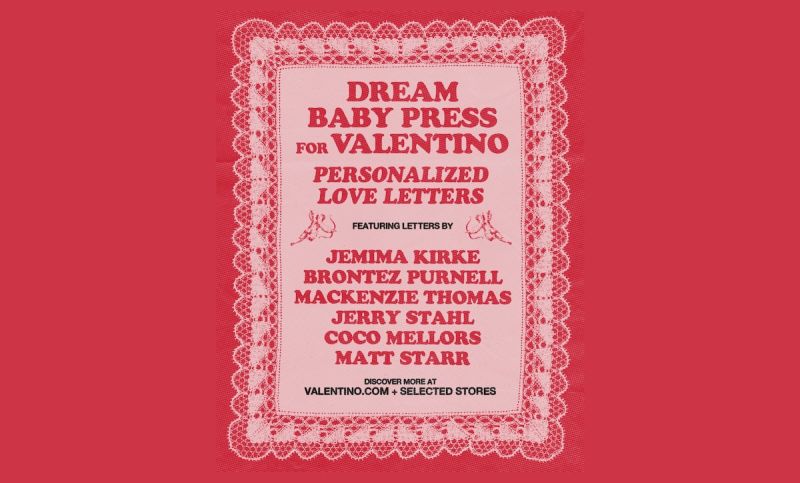Cosa succede con i prezzi della moda
Un bijoux ha riaperto la periodica polemica sui costi spropositati del lusso, ma quelli bassissimi portano conseguenze più gravi.

Se una collana in argento smaltato di Bottega Veneta è capace creare scalpore in una certa (larga) nicchia interessata alla moda e alle sue evoluzioni, la ragione sta nel fatto che non si tratta di un caso isolato, anzi. Potrebbe sembrare strano a i non addetti ai lavori, ma il settore del lusso ha aumentato i prezzi durante la pandemia. Proprio quando i negozi erano chiusi e le persone non avevano vere ragioni per comprare abiti e borse nuove, molti dei grandi nomi hanno alzato il cartellino di prodotti specifici, o di tutta l’offerta. Il primo è stato Louis Vuitton, con un rialzo del 3 per cento a marzo e uno del 5 per cento a maggio. Poi Chanel, Dior, Gucci, Prada (l’amministratore delegato Patrizio Bertelli l’ha motivato con «complessità logistiche e distributive»), Salvatore Ferragamo. Alcuni l’hanno fatto su tutti i mercati, altri solo in Cina, altri ancora solo in Europa. Sono strategie diverse, ma la più gettonata è quella legata al mercato cinese, dove la ripresa è cominciata molto presto rispetto al resto del mondo. E dove i consumatori si sono ritrovati impossibilitati a riprendere il turismo da shopping. Sarà da vedere se riprenderanno non appena sarà possibile – perché comprare una borsa a Milano, Firenze o Parigi, resta un’esperienza irripetibile – e se allora ci si troverà davanti a un nuovo rialzo in occidente, per diminuire il divario.
Non è un fenomeno nuovo: gli aumenti vertiginosi dei prezzi sono diventati sistematici negli ultimi due decenni. Per esempio, la décolleté-icona di Manolo Blahnik, resa celebre dal primo film Sex & The City in cui Mr. Big la usa al posto dell’anello per fare l’agognata proposta a Carrie: nel 2003 costava 484 dollari, nel 2013 era arriva a 755, ora è in vendita sul sito del brand a 935. Ma è difficile stabilire da cosa siano determinati questi aumenti, anche perché i marchi non rendono pubbliche le informazioni sui costi che affrontano. Ci sono alcune voci che hanno subìto un aumento, come le materie prime (per la loro scarsità), il costo del lavoro dei dipendenti e gli affitti degli immobili. Altre su cui il marchio ha più gioco, e cioè quelle della produzione e della realizzazione di cui si occupa la catena di fornitura, spesso ubicata in Paesi “in via di sviluppo”, il cui scarso potere di negoziazione quasi sempre si riflette su salari e condizioni dei lavoratori. In ultimo c’è la percezione desiderata: nel 2017 Burberry ha dichiarato di aver alzato i suoi prezzi per allontanarsi dall’idea di marchio di fascia media e posizionarsi tra i marchi storici del lusso. E non si parla solo di cappotti, scarpe o borse. Negli ultimi anni il rialzo più sorprendente è quello che ha riguardato gli “entry price”, ovvero i prodotti meno costosi di un brand. Per la primavera estate il cappellino da baseball con logo di Celine costa 290 euro, la cintura in pelle di Gucci 370 euro, gli occhiali da sole a cuore di Saint Laurent 345 euro, i gioielli demi-fine di Bottega Veneta… appunto. Una volta considerata categoria di secondo livello, oggi l’entry price ruba molte energie a un marchio, perché è quella a cui accede il consumatore più giovane che, si spera, si affezionerà e tornerà, anche quando avrà maggiore potere d’acquisto.
Dall’altra parte della barricata, a confondere le acque, ci sono invece le T-shirt a cinque euro. Proprio nei due decenni in cui il lusso saliva senza guardarsi indietro, i marchi del fast fashion hanno abituato il consumatore a comprare a poco, pochissimo. Marchi come Bohoo – su cui il Sunday Times ha pubblicato un’inchiesta la scorsa estate con accuse di sfruttamento e condizioni di lavoro pericolose e il Us Customs and Border Protection ha recentemente aperto un’investigazione, perché gli Stati Uniti vietano l’import di merce prodotta «in qualsiasi Paese straniero con lavoro forzato o servitù da debiti» – offrono un infinito scroll di abiti a 15 euro e stivaletti a 20. Ma il loro problema più grande oggi si chiama AliExpress, il mega e-commerce cinese di proprietà di Alibaba: su YouTube e Instagram esistono decine e decine di contenuti in cui gli utenti mostrano il loro “haul”, e cioè il bottino di prodotti fotocopia che sono riusciti a trovare sulla piattaforma a prezzi ancora inferiori. Come si torna indietro da un abito in cotone che costa 7,41? Se lo sta chiedendo un’altra fetta di fast fashion, quella che comprende H&M, Zara, Mango e simili, che da anni ormai sono impegnati in un riposizionamento che – nel caso del colosso svedese – la produzione di molte, piccole collezioni in collaborazione con piccole realtà dal percepito estremamente positivo (ultima in ordine cronologico, quella con il marchio di calzature sostenibili Good News). E, quasi per tutti, l’affiancamento di una o più linee premium che però ancora oggi non sostituisce la proposta di primo prezzo.
E allora in quella terra di mezzo spazio evidentemente ce n’è. Una parte se la sta prendendo il second hand, pur con tutte le sue contraddizioni (a funzionare di più sulle app di lusso sono i prodotti in voga in quel momento), diventati la nuova meta di tutti quelli che cercano la firma ma anche l’affare: spesso si tratta di appassionati, quelli che fanno volentieri ricerca e, anzi, danno la priorità all’unicità di un pezzo. E poi resta uno spazio ancora più difficile, perché è quello in cui sta chi riesce a convincere il consumatore a spendere 200 euro invece che 20 per un costume da bagno o un paio di orecchini a 150 invece che a 5. I brand di fascia media non possono più sperare di risultare vincenti solo offrendo un buon prodotto, slegato dalla stagionalità, e a un prezzo “via di mezzo”. Oggi il loro successo passa spesso proprio dalla rieducazione e dall’intercettazione di un consumatore che si è sentito tirato da una parte e dall’altra, ma che alla fine non è rimasto soddisfatto né dall’esclusività del lusso, né dalla facilità del fast fashion. È la storia, ad esempio, dello scontrino di MaisonCléo, ma anche della corsa alla blockchain, struttura di dati immutabile e condivisa a cui il consumatore può accedere direttamente dal prodotto (spesso tramite un Qr code, come quello comparso nel weekend scorso nel cielo di Shanghai: era una pubblicità, piuttosto distopica). Significa fare il doppio dei compiti degli altri, ma potrebbe restituire grandi soddisfazioni.