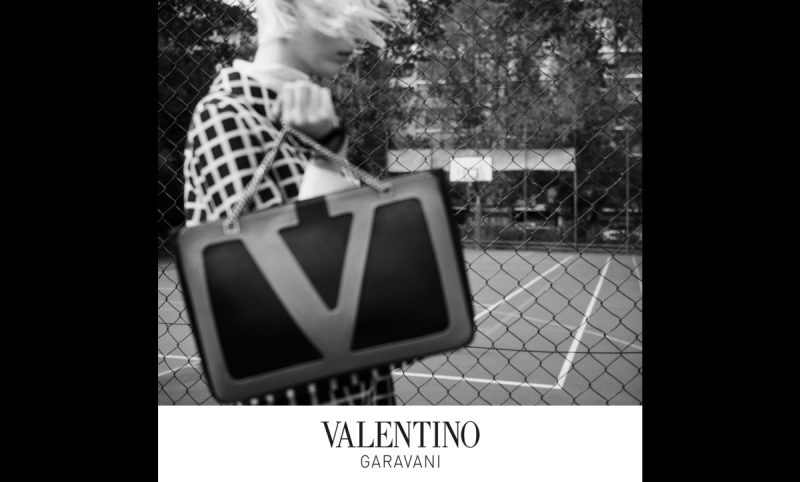L’ultima sfilata Couture di Balenciaga segna – questa volta in maniera definitiva – la fine dell’era Demna. Dieci anni in cui il Direttore creativo georgiano ha scritto la sua parte di storia della moda.
Alexander Wang e la fine del designer star
Le accuse di molestie, da lui categoricamente negate, minacciano la carriera del designer americano. E, ancora una volta, ridisegnano il ruolo del direttore creativo.

Quando l’account @ShitModelMgmt, oggi 235 mila follower su Instagram e quasi 10 mila su Twitter, ha ripostato i video di TikTok in cui il modello Owen Mooney denunciava Alexander Wang di molestie, in pochi sono rimasti veramente sorpresi. Non è infatti la prima volta che accuse di questo genere vengono mosse nei confronti del designer americano: sono venute fuori più volte negli ultimi anni, sempre sui social e sempre perlopiù in forma anonima, ma questa era evidentemente la volta giusta perché l’industria prestasse attenzione. Le accuse si sono poi impilate una sull’altra, grazie anche al coinvolgimento dell’immancabile duo di @DietPrada, Wang ha negato categoricamente, prima con un comunicato fatto uscire l’ultimo dell’anno poi sul suo profilo personale, nuove accuse si sono aggiunte, tra minacce legali e l’entrata in gioco di Lisa Bloom, celebre per aver difeso Harvey Weinstein e le donne della Fox che hanno accusato Bill O’Reilly, che si è offerta di rappresentare le vittime. Nel caos attuale, è lecito allora chiedersi cosa ne sarà del marchio che porta il suo nome, come ha provato a fare Lauren Sherman su Business of Fashion, e non è una domanda che ha facili risposte: ShitModelMgmt continua a ripostare Stories e foto di persone che fanno il dito medio di fronte alle boutique (perlopiù chiuse) di Wang in giro per il mondo, c’è chi cestina i suoi capi e chi, più prosaicamente, li rivede su Vestiaire Collective, ma in generale le voci dell’industria che si sono espresse sulla vicenda sono state poche. Celebrity, modelle, fotografi, editor e addetti ai lavori i cui profili Instagram sono pieni di selfie con Wang, conosciuto per essere un festaiolo, sono infatti rimasti silenti.
Ora, si potrebbero fare molti ragionamenti sull’ennesimo caso di molestie nato dai social, ribadire che non è quello il luogo dove si sporge denuncia (lo stesso Mooney aveva detto inizialmente di non voler procedere legalmente), sottolineare che siamo tutti innocenti finché un tribunale non stabilisce il contrario e così via, ma ciò non toglie questi meccanismi stanno ridefinendo il ruolo pubblico di chi occupa posizioni come quella di Wang. Sono finiti sotto scrutinio i suoi vecchi post (quelli in cui condivideva gambe piene di lividi con la didascalia «Quella che io definisco una serata divertente»; oppure quella in cui la strega dà la mela avvelenata a Biancaneve, allusione all’abitudine di aggiungere droghe nei drink, cosa di cui è stato accusato), che per molti sono diventati la prova schiacciante della sua colpevolezza, e sono ricomparsi video come quello in cui Florence Welch dice a Derek Blasberg che Wang le aveva dato della vodka al posto dell’acqua, nonostante lei gli avesse detto di essere già ubriaca. I due nel video ci ridono sopra, ricordano l’aneddoto come si fa quando si parla di una serata in cui si è esagerato un po’, eppure il clima di oggi (il video è del 2016 ma sembra un altro secolo) ha reso quegli eccessi condannabili, sospettosi, forieri di significati nascosti che vanno ben oltre il divertimento.
Fino a dieci anni fa, nessuno si sarebbe sognato di criticare un creativo per una cosa del genere, anzi comportamenti simili avrebbero contribuito a costruirne il mito, ma i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni hanno profondamente ridisegnato il profilo di chi oggi guida un marchio di moda. La comparsa del “direttore creativo”, o direttore artistico, ha segnato infatti la significativa rottura rispetto allo “stilista star” che aveva fino a quel momento caratterizzato l’industria. C’è stato il tempo degli stilisti volto dei marchi che avevano fondato e che spesso portavano il loro nome e cognome, dagli esordi dell’industria agli inizi del Novecento fino almeno agli anni Ottanta, e c’è stato il tempo del cambio della guardia, negli anni Novanta, quando personalità come John Galliano, Martin Margiela, Alexander McQueen e Tom Ford tra gli altri, hanno ridefinito cosa significa essere uno stilista. Nei decenni successivi, con l’ingrossarsi delle conglomerate nella moda e l’assottigliarsi dei marchi rimasti indipendenti, le dinamiche dell’ufficio stile sono mutate e con esse anche l’identikit di chi lo presiede, non più il genio ribelle incensato dai media, che ci è stato descritto come lunatico e cattivello ma comunque talentuoso abbastanza da farsi perdonare tutti i capricci, ma al contrario qualcuno in grado essere manager di sé stesso e che con i manager, quelli che l’azienda la comandano per davvero, riesce a capirsi. Quando Virgil Abloh è arrivato da Louis Vuitton, e più recentemente quando Matthew Williams è approdato da Givenchy, molto si è scritto su questi cambiamenti, sul nuovo significato del mestiere e sull’interpretazione da dare a certi vecchi titoli e cliché. Quel che è certo è il genio ribelle non funziona più e neanche lo stronzo di talento, i posteri ci diranno se siamo diventati tutti moralisti o se fino a qualche anno fa nessuno voleva chiamare le cose con il loro nome.

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.