Lo scrittore ha condiviso su X una breve clip in cui si vede il leggendario bar Chatsubo di Chiba City: «Neuromancer is in production», ha annunciato.
Aleksandar Hemon, l’infezione dei ricordi
Ne I miei genitori/Tutto questo non ti appartiene lo scrittore tratta la memoria come un virus raccontando la storia della sua famiglia.
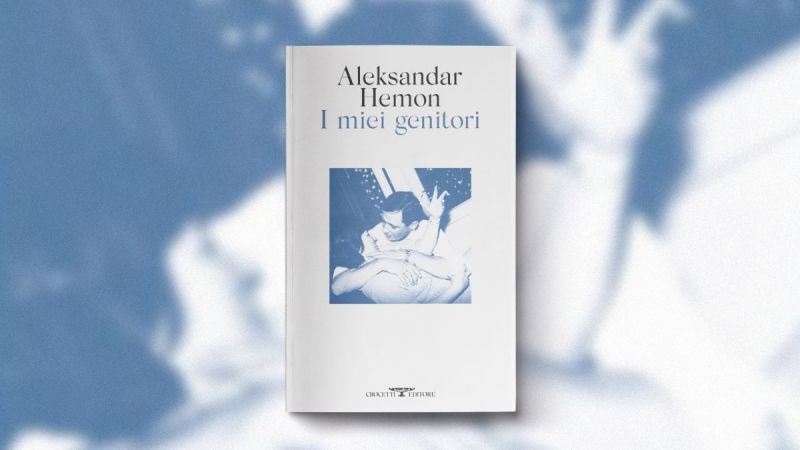
Nei memoir capiamo molto di più dell’autore quando parla degli altri rispetto a quando parla di sé stesso. I memoir diventano un’opera di documentazione collettiva quando dentro ci sono avvenimenti storici che modificano radicalmente la vita dei protagonisti e del narratore. Se con il romanzo Nowhere man Aleksandar Hemon ricostruiva la vita di un espatriato attraverso i racconti di chi lo conosceva, nel memoir I miei genitori – appena uscito in italiano per Crocetti, traduzione di G. Pannofino – l’autore parla della propria famiglia e dei dolori del loro dislocamento dalla Bosnia al Canada dopo lo scoppio delle guerre jugoslave. Con la maturità – non necessariamente anagrafica – il velo dell’opera di finzione cade e l’autore, sicuro di sé, parla con il proprio nome di ciò che ha già affrontato con la narrativa. Senza il fumo della fiction, il dolore di fondo non cambia, ma nell’ottica dell’attualità, acquisisce il valore dell’immanenza e dell’urgenza. Sia personale che collettiva. «Tra i tanti aspetti spaventosi della guerra, c’è anche quello di essere un campo narrativo vasto quanto un universo perché sfocia in modo ineluttabile e brutale nella migrazione», scrive Hemon.
Tutte le famiglie vittime del nomadismo forzato si somigliano, ed è per questo che ci piace leggere questi ricordi, per andare a individuare il massimo momento di tenerezza che sappiamo nascondersi sempre tra i viaggi di chi migra e chi fugge. In I miei genitori ce ne sono molti, così come ci sono molti modi per capire cosa vuol dire costruire qualcosa di nuovo. I migranti sono come dei pionieri, costruiscono una nuova casa dove ricominciare. «Una patria perfetta non è mai disponibile», scrive. «Una patria non può costruirsi senza nostalgia, senza fondare a posteriori una passata utopia». La testa dei migranti – almeno è il caso dei genitori di Hemon, arrivati a 56 e 57 anni in un Paese in cui non parlavano la lingua – rimane nelle terre in cui si è cresciuti, in cui ci si è innamorati, in cui si ha lavorato e in cui sono nati i propri figli. Il padre di Hemon, di famiglia ucraina oltre alla narrazione nostalgica bosniaca, ha quella ucraina delle sue radici. Quando qualche anno fa Hemon è andato in Ucraina a cercare le origini del padre racconta che entrando nella cucina di una casa ha sentito l’odore della cucina dei suoi nonni. La pigrizia dello stereotipo occidentale dipinge gli immigrati o come dei bambini, degli sprovveduti che parlano a fatica la lingua del luogo, o come delle sanguisughe, che rubano il lavoro. L’obiettivo statale è l’assimilazione, l’obiettivo del migrante è da una parte la sopravvivenza, dall’altra il mantenere un rapporto con la patria lontana in forma di ricordi, codici tramandati, canzoni, storie, cucina.
Il libro di Hemon è doppio, ribaltabile. Se si gira dall’altra parte abbiamo un’altra copertina e un altro titolo: Tutto questo non ti appartiene. Qui, sempre in forma di memoir, ma senza una vera struttura, con dei pezzetti in prosa di ricordi, Hamon passa in rassegna momenti anche minuscoli della propria infanzia e adolescenza bosniaca. Qui, parlando di sé e non dei propri genitori, la memoria diventa ancora più lancinante, perché non si parla più di altri che nel raccontarti hanno irrimediabilmente inserito dei filtri. Quando si parla di sé, del sé giovane, la memoria diventa simile a un virus. «La terribile infezione dei ricordi, che non se ne vanno», scrive, «che restano in circolazione nel sangue come batteri finché non riconoscono la presenza di loro simili da qualche parte nell’organismo, e a quel punto, all’improvviso, diventano tutti insieme virulenti, e si sta male». I due libri si incontrano al centro e si uniscono tramite una serie di fotografie dei genitori dell’autore. La fotografia è una forma di narrazione con un linguaggio meno modificabile.
Incontro Hemon, appena tornato dal festival di Mantova, in un ristorante bio-siciliano di Brera. Sul braccio ha un grosso tatuaggio con l’aquila rossa del Liverpool F.C. Si presenta come Sasha e ha addosso una t-shirt di Sense8, la serie tv delle sorelle Wachowski per cui ha scritto il finale di stagione con David Mitchell. Insieme hanno anche sceneggiato l’ultimo capitolo della saga di Matrix, The Matrix Resurrections, uscito nel 2021. «Sono entrato nel giro quando stavo a Chicago, scrivendo un articolo sul New Yorker sul film Cloud Atlas, tratto dal romanzo di Mitchell», racconta.
Quando è scoppiata la guerra nei Balcani, Hemon era negli Stati Uniti e ci è rimasto, aspettando che i suoi arrivassero, come rifugiati, in Ontario, perché conoscevano delle persone lì. Mentre mangia un calzone racconta che ha scelto di essere americano «ma senza entusiasmo. Non ho una connessione organica con l’America». Gli chiedo perché ha iniziato a scrivere in inglese. Nel 1992 faceva il giornalista e collaborava con una rivista bosniaca scrivendo di cinema. «Ma poi mi sono chiesto: a chi interessa dell’eccellente performance di Meg Ryan in una commedia romantica mentre intorno a te c’è la guerra?», e così ha smesso, dicendo di non riuscire più a scrivere in bosniaco. «Quell’estate mi sono ripromesso che in cinque anni avrei scritto un libro in inglese. Dopo tre anni ho pubblicato un mio racconto su una rivista». Da lì ha sempre scritto i suoi libri in una lingua che non era la sua, seguendo quella tradizione degli expat come Joseph Conrad, Nabokov o Kundera che abbandonano i codici con cui sono cresciuti. «Penso che gli scrittori cambino la lingua che usano», dice. «Possono inventarsi delle cose. Mi ricordo la mia prima moglie, una vera Wasp, che leggendo una mia cosa mi disse “Non si scrive così” e io gli ho risposto “Ora sì”».
Hemon davanti al caffè parla dei suoi genitori, che hanno superato da un po’ gli ottant’anni e stanno bene. Il padre si tiene impegnato con l’apicultura, e anche lui ha iniziato prendendo delle arnie con un amico che ha un terreno fuori New York. «Quando scrivo romanzi in un certo momento inizio ad affezionarmi ai personaggi, c’è un punto di svolta in cui capisco che mi importa di loro, come fossero amici. Per la non-fiction è diverso, ma fino a un certo punto. Mi piacciono i miei genitori, penso che siano interessanti». Gli chiedo come hanno reagito quando hanno letto il libro, che parla in modo così intimo di loro. «Mia madre ha alzato il dito, come fa per prendere la parola a tavola quando deve dare qualche notizia, e ha detto: “Ci hai costruito un monumento”».

Il regista inglese torna alla saga che lo ha reso famoso e decide di stravolgerla: il risultato è un film d'autore, horror ma anche politico e sentimentale, che disattende tutte le aspettative e che ha diviso i fan.





