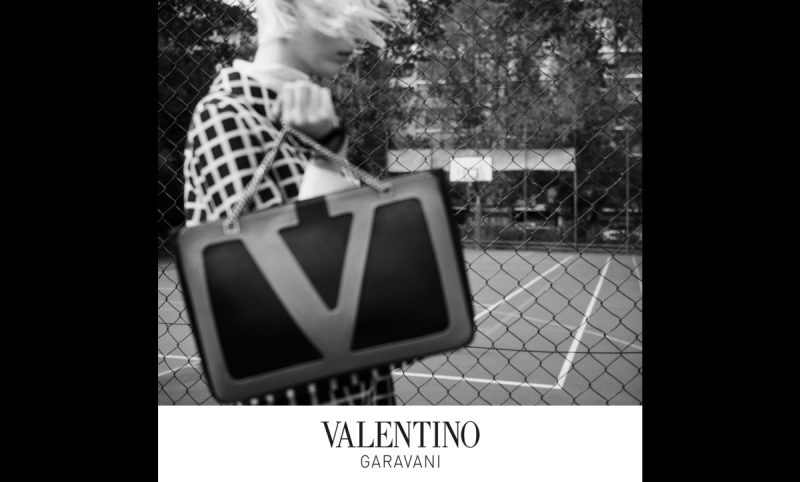L’ultima sfilata Couture di Balenciaga segna – questa volta in maniera definitiva – la fine dell’era Demna. Dieci anni in cui il Direttore creativo georgiano ha scritto la sua parte di storia della moda.
È difficile scegliere un solo fermo immagine che rappresenti bene cos’è successo quest’anno nella moda. La collezione per l’Autunno Inverno 2018-19 di Gucci (quella delle teste mozzate, per intenderci) è stata probabilmente la sfilata che più ha fatto discutere addetti ai lavori e non, vuoi per i tanti significati che Alessandro Michele è riuscito a stratificare nel suo show, vuoi per l’impatto immediato che quelle immagini hanno provocato sui social, dove è raro che le cose della moda sforino il pur largo perimetro degli appassionati. Per i nostalgici che ancora guardano alle passerelle come al barometro unico di ciò che succede nell’industria, ci sono state anche altre sfilate di cui si è parlato molto, complice i debutti e gli eterni ritorni delle direzioni creative: Virgil Abloh da Louis Vuitton, Riccardo Tisci da Burberry, Hedi Slimane da Celine. È su Instagram e piattaforme affini, poi, che è successo tutto il resto: dagli incidenti come quello di Dolce & Gabbana in Cina all’affermarsi dei marchi di nuova generazione a uso e consumo delle influencer (big o nano che siano) e dei loro followers. Secondo l’annuale report di Lyst, l’e-commerce sbarcato quest’anno anche in Italia, nella top tre delle influencer Kylie Jenner è prima, seguita dalla sorella Kim Kardashian e da Meghan Markle, i primi tre Instagram brand sono Veja, Reformation e Attico, i loghi più ricercati quelli di Supreme, Champion e Fila mentre gli oggetti più desiderati sono la cintura con il logo di Gucci, quella di Off White e i collant di Fendi. Al di qua degli algoritmi, d’altronde, ci sono i macro trend che stanno ridefinendo l’industria, sempre più difficili da analizzare: ecco quali sono stati per il 2018, e perché sono importanti.
L’illusione del lusso “mediocre”
Ne ha scritto recentemente Eugene Rabkin su Business of Fashion, in un editoriale piuttosto disilluso, riprendendo il termine “premium mediocre”, coniato da Venkatesh Rao, per indicare tutti quei prodotti (come la pizza gourmet, la birra artigianale o gli hamburger gastronomici) che danno l’impressione di offrire un’esperienza “di lusso”, quando il più delle volte si tratta di marketing. È un trucco che nella moda si è sempre praticato, basti pensare alle seconde linee o alle estensioni nel beauty e nella profumeria, ma quello che è interessante oggi è il modo in cui questa categoria di prodotto (lo zaino di Prada in nylon, il portacarte di Celine, le Louis Vuitton in tela plastificata) si sposa con la mentalità corrente e i nuovi bisogni fabbricati dai social media. C’entrano il mantra del prendersi cura di se stessi e l’ossessione per il logo che Instagram ha rinfocolato: il lusso mediocre non sarà mai vero lusso, ma è consolatorio abbastanza da sembrarlo, almeno in foto.
Il fenomeno Fashion Nova
Giusto per ribadire quanto appena detto: il marchio più cercato su Google quest’anno non è uno di quelli che sfilano in passerella, ma Fashion Nova. Non sapete cos’è Fashion Nova? Tutto nella norma, perché il fenomeno assomiglia molto a tutte quelle cose (come i profili Finstagram, Twitch e l’intero gaming online) che sfuggono di default a chi è nato prima del 1994. Con la differenza che, almeno a giudicare dai numeri, Fashion Nova veste chiunque. Nato nel 2006 nei dintorni di Los Angeles come marchio di “clubwear” con una particolare attenzione al pubblico curvy, Fashion Nova oggi genera ricavi per 500 milioni di dollari e lo fa senza campagne pubblicitarie d’autore e senza l’endorsement della stampa specializzata. A trainare il marchio è la sua strategia social (tra le #NovaBabes ci sono Kylie Jenner e Cardi B, che ha anche disegnato una collezione immediatamente sold-out) e la velocità con cui ricopia gli abiti delle influencer. Talmente veloce da diventare un meme, ma come ha scritto Rachel Seville Tashjian di Garage Magazine su Twitter «è incredibile come Fashion Nova sia il marchio di moda più googlato dell’anno (l’anno scorso era quarto) e solo pochissimi fra i giornali di settore se ne sono occupati seriamente».
- Dior Men Pre-Fall 2019 Collection
- 30 novembre 2018, Tokyo
La nostalgia come trend
Se il primato di Fashion Nova potrà aver sorpreso i meno accorti, la classifica di Google non dice nulla che non ci aspettassimo a proposito dei trend più cercati. Nelle prime quattro posizioni si piazzano infatti “1980 fashion”, “Grunge style”, “1990s fashion” e “2000s fashion”, a dimostrazione di come nella moda tutto ritorna, è vero, ma anche che negli ultimi anni si è un tantino esagerato con i revival. Questo particolare tipo di nostalgia culturale è legata alla progressiva digitalizzazione del nostro tempo libero e riguarda ormai buona parte delle industrie creative. Alyssa Vyngan Klein l’ha analizzata su Fashionista, elencando tutti i marchi che sulla nostalgia hanno lavorato. Ma questo sentimento è anche un’arma a doppio taglio: se da una parte, infatti, è qualcosa di facile “da consumare”, dall’altra porta alla luce le contraddizioni che attraversano oggi la moda. È emblematico il caso di Marc Jacobs, che dopo la collezione ispirata ai grandi degli anni Ottanta, ha anche ricreato la collezione grunge che nel 1993 gli costò il licenziamento da Perry Ellis: sono entrambe bellissime, ma secondo Vanessa Friedman si tratta, brutalmente, del canto del cigno.
La ridefinizione del sexy
Un altro degli argomenti di cui si è molto discusso quest’anno, soprattutto a ridosso delle sfilate tra febbraio e marzo, è stata poi la cosiddetta “scomparsa” del sexy. Di fronte a collezioni vittoriane, colli alti e layering (vestirsi a strati) pesante, in molti hanno scritto che era l’effetto del #MeToo: niente di più falso, a guardare bene, perché le donne oggi si mostrano eccome, vedi il successo degli abiti succinti di Fashion Nova e dei tanga al neon su Instagram, appunto. Semmai la sensualità sta diventando altra cosa da come l’abbiamo immaginata (e comprata) fino ai tempi recenti. C’entrano anche i movimenti femministi, certo, ma non il maccartismo di ritorno tanto sbandierato nei mesi scorsi. C’entrano piuttosto le teste mozzate di Gucci ispirate a Donna Haraway e le nuove identità sessuali che noi, schiacciati gioco-forza negli anni del cambiamento coatto, comprendiamo solo a metà, come i Twitch e i Finstagram. La rabbia femminile c’entra eccome, vedi le creature con le torce immaginate da Rick Owens, nessuno lo nega, anzi è sempre preferibile all’empowerment e alla leadership formato pacchetto, concetti fumosi che iniziano – finalmente – a creparsi dall’interno. Poi c’è la questione, spinosissima, della creazione dell’immagine artistica e degli squilibri di potere, come dimostra il caso di Bruce Weber, maestro di erotismo accusato di molestie. Una questione che, questo è sicuro, non abbiamo risolto.
Direttori creativi allo sbaraglio
Tramontata l’epoca dello stilista-star degli anni Novanta, accantonati i John Galliano e i Tom Ford agli account retrò su Instagram, il 2018 è stato l’anno della definitiva consacrazione del direttore creativo o del designer-manager che dir si voglia. Una definizione curiosamente non troppo dissimile da quella (italianissima) di “stilista”, ovvero colui che fa «da mediatore tra le pratiche dell’industria, le esigenze dei buyer e i bisogni del pubblico, con anche una piena consapevolezza dell’importanza della stampa», come ha scritto Sonnet Stanfill nell’introduzione di The Glamour of Italian Fashion Since 1945, il catalogo che ha accompagnato nel 2014 l’omonima mostra del Victoria & Albert Museum di Londra. Il direttore creativo, nel 2018, può dirigere un marchio di moda senza necessariamente saper disegnare, nel senso letterale, dei vestiti: è il caso di Virgil Abloh, la cui nomina a capo del menswear di Louis Vuitton ha provocato non poche reazioni accese tra gli addetti ai lavori. Di contro, può disegnare molto bene e comunque non funzionare quanto gli è richiesto di fare (perché le aspettative dei marchi sono francamente assurde) com’è successo a Raf Simons da Calvin Klein. È solo hype? E se sì, quanto durerà? Il design di moda è morto? E chi può stabilirlo, oggi che gli analisti economici non vanno oltre i sei mesi? Tutte domande difficili, che rimandiamo al 2019. E per quelli che non riescono a farsi una ragione della giustezza storica di Abloh, ci sono sempre i Pierpaolo Piccioli e i Kim Jones, che fanno bei vestiti e sono pure simpatici su Instagram.

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.