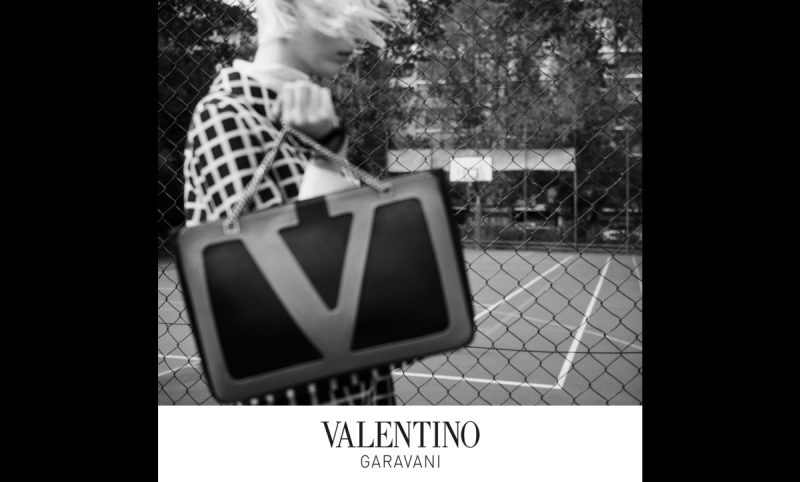L’ultima sfilata Couture di Balenciaga segna – questa volta in maniera definitiva – la fine dell’era Demna. Dieci anni in cui il Direttore creativo georgiano ha scritto la sua parte di storia della moda.
A partire dagli anni Novanta, periodo in cui le conglomerate e i grandi imperi della moda hanno iniziato a prendere forma, il modo migliore per raccontare un marchio è stato appellarsi, laddove possibile ma a volte anche quando non ce n’erano le basi, alle origini, al Dna, alla storia. Si trattava di un’operazione legittima, perché da una parte serviva a “educare” quel nuovo cliente del lusso che non sapeva nulla dei marchi europei e dell’immaginario che si portavano dietro, mentre dall’altra ne accresceva il valore percepito per chi quelle storie già le conosceva, e poteva così riconoscersi come parte di un club esclusivo. Oggi quello schema di pensiero si è rotto, anche a causa (sebbene non esclusivamente) dei cambiamenti nelle abitudini di consumo di Millennials e Generazione Z, i quali hanno dimostrato il loro approccio per certi versi antitetico rispetto a chi li ha preceduti.

Una modella durante la sfilata di Burberry per la Primavera Estate 2019 (Foto di Niklas Halle’n/AFP/Getty Images)
Come ha spiegato Lauren Sherman su Business of Fashion, in questo momento storico è la rilevanza culturale che fa il successo di un marchio più che il suo “heritage”. Usando definizioni del passato, potremmo dire che a muovere la domanda di beni di lusso sono oggi quei consumatori che hanno sviluppato un gusto più maturo (che per anni si è definito piuttosto frettolosamente come “europeo”), ai quali lo storytelling che punta tutto sul Dna interessa sì, ma solo fino a un certo punto. È molto probabile, infatti, che quella storia l’abbiano già letta da qualche parte, magari perché hanno assistito alla confusa digitalizzazione dell’industria che, non a caso, nei suoi primi anni ha privilegiato la forma divulgativa (basti pensare al proliferare delle enciclopedie della moda in chiave Seo al tempo in cui le influencer erano ancora blogger). Ed è anche probabile che poi quelle informazioni le abbiano dimenticate, con grande oltraggio di chi alla comparsa della T-Shirt “We should all be feminists” di Dior ha voluto sommessamente ricordare che, beh, le femministe Christian Dior lo hanno sempre contestato.
Prima di addossare la colpa all’approssimazione culturale da Wikipedia, però, è giusto riconoscere come quella t-Shirt abbia suo malgrado contribuito ad alimentare una discussione e, nel frattempo, raccontato qualcosa che stava succedendo, che poi è quello che la moda fa, sebbene con diversi gradi di complessità. Così non sorprende che ci fossero utenti su Instagram che, durante l’ultima settimana della moda, accusavano il nuovo Celine di Hedi Slimane di assomigliare troppo a Saint Laurent di Anthony Vaccarello, ignorando la correlazione fra i due, mentre altrettanti erano indispettiti dalle ovvie citazioni a se stesso del designer francese. Al di là delle incongruenze storiche, però, quello che è interessante di questi movimenti del gusto sono le forme che la “rilevanza culturale” assume nel momento in cui ai marchi si richiede di esporsi, prendere posizione sull’attualità, uscire da se stessi e dimostrare di conoscere il linguaggio del presente.
Sherman nel suo articolo parla della differenza tra “codici del brand” e “stile del brand”: i primi è meglio che restino sempre uguali a se stessi, magari nella forma di mocassini e/o giacche Bar, mentre il secondo può (anzi deve) cambiare. L’ideale sarebbe raggiungere una sintesi tra passato e presente, come ha fatto Alessandro Michele da Gucci e come sta provando a fare Riccardo Tisci da Burberry, ma è un’operazione tutt’altro che facile, tanto più in un momento in cui le stesse categorie con cui per lungo tempo si è analizzata l’andamento del consumo del lusso si confondono e si intersecano fra di loro. Questo non significa, comunque, che le storie più o meno “antiche” scompariranno definitivamente dal panorama dell’industria. Come ha spiegato Claudia D’Arpizio di Bain & Company alla presentazione dell’Osservatorio Altagamma 2018, infatti, i marchi specializzati (come quelli del formale maschile) continueranno con successo a fare appello alla tradizione e all’eccellenza del loro heritage, ma per tutti quelli che nutrono una vocazione “antologica” (si legga: i mega-brand) sarà fondamentale esprimere delle opinioni e farsene portavoci attivi. Come ha fatto Nike quando ha scelto Colin Kaepernick, un caso piuttosto emblematico, e sappiamo bene quanto diventa difficile la partita nel momento i cui i marchi di moda si mettono a gareggiare a colpi di sneakers.
Di moda, media e beni di lusso si parlerà anche a Studio in Triennale 2018: Carlo Rivetti (Stone Island), Nicola Maccanico (Sky) e Mario Peserico (Eberhard) racconteranno cosa vuol dire, in piena rivoluzione globale e tecnologica, continuare a investire nel “fatto bene”.

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.