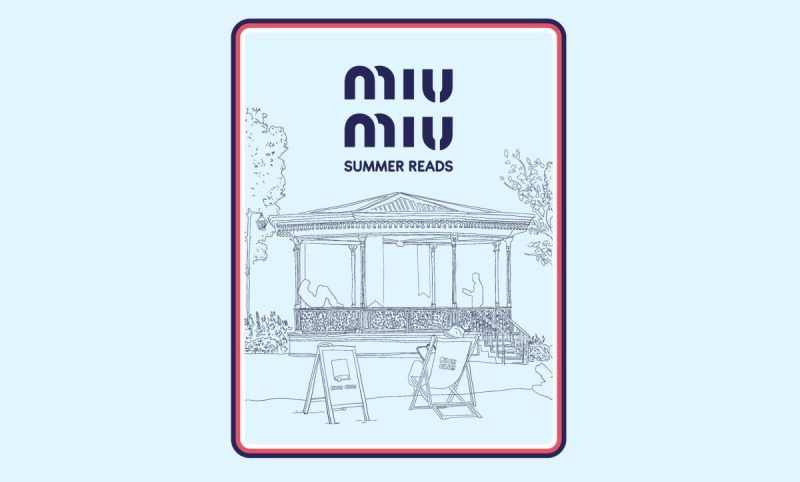Dopo le riuscite campagne di marketing dell’ultimo settimana, lo stilista nordirlandese ha fatto il suo debutto da Direttore creativo con una collezione che setta l’inizio del nuovo corso alla sua maniera.
Dopo due anni e otto mesi prima della scadenza ufficiale del suo contratto, il designer belga Raf Simons lascia la direzione creativa di Calvin Klein. Così come il suo arrivo nell’agosto 2016 (quasi un anno dopo aver lasciato Dior), anche l’addio è stato annunciato a un passo dalle vacanze: la notizia era però già nell’aria da tempo. Almeno dalla fine del mese di novembre, quando Emanuel Chirico, il presidente e amministratore delegato di Pvh, il gruppo americano che controlla il marchio, aveva sottolineato la performance deludente di alcune linee Calvin Klein. «Mentre molte categorie di prodotti hanno ottenuto buoni risultati, siamo delusi dalla mancanza di ritorno dei nostri investimenti in Calvin Klein 205W39NYC e crediamo che alcuni dei prodotti rilanciati da Calvin Klein Jeans fossero troppo alti e non abbiano riscosso il successo che avevamo previsto», ha dichiarato Chirico. Il marchio chiude infatti il terzo trimestre dell’anno con un rallentamento della crescita, attestatasi intorno al 7% per 2,52 miliardi di dollari (circa 2,21 miliardi di euro). Una visione e dei costi di realizzazione, insomma, troppo onerosi da sostenere a fronte del riscontro di pubblico ottenuto.

La campagna pubblicitaria per l’Autunno Inverno 2017-2018, scattata da Willy Vanderperre
Oggi il designer e il marchio si separano “amichevolmente”, come si legge da comunicato ufficiale, dopo che «Calvin Klein ha deciso di perseguire una nuova strada che è differente dalla visione creativa di Raf Simons». Nelle quattro collezioni da lui disegnate, lo stilista si era concentrato su una personale rielaborazione dell’estetica Americana, mescolando fra loro riferimenti cinematografici e inaugurando collaborazioni artistiche com’è sua abitudine. Sulla carta, i (pochi) punti in cui l’universo di Simons e quello di Calvin Klein si incrociavano, dalla predilezione per uno stile minimale all’ossessione per la giovinezza, facevano ben sperare per la riuscita di quello che Vanessa Friedman chiama sul New York Times «il più grande esperimento di re-branding nella moda americana del 21esimo secolo». E per “re-branding” si intende una riscrittura dell’identità del marchio, un’operazione in cui oggi si imbarcano tutti i grandi del lusso e che è particolarmente delicata, considerata la volatilità del mercato e la difficoltà di rimaneggiare quel bagaglio culturale (la storia, il logo, il consumatore-tipo) che i marchi si portano dietro. Eppure l’azzardo in questo caso non è riuscito, almeno non del tutto, anche perché come spiega Chantal Fernandez su Business of Fashion «fin dall’inizio, c’era uno scollegamento tra l’estetica personale di Simons e le esigenze di un marchio multi-miliardario, multi-livello [come Calvin Klein], che non è spinto dal design elevato ma dal marketing di massa, un campo in cui Simons non ha mai fatto esperienza». I suoi show, comunque, hanno ricevuto critiche perlopiù positive.

Kendall Jenner e Khloé Kardashian nella campagna pubblicitaria mondiale multimediale delle linee Calvin Klein Underwear e Calvin Klein Jens
Per rendersi conto del cortocircuito, basta dare uno sguardo alle campagne pubblicitarie, tasto dolente per Simons già da Dior e acceso terreno di scontro tra gli interessi dei direttori creativi e quelli dei Ceo. Si pensi alla prima campagna immaginata dal designer per l’Autunno Inverno 2017-2018 e scattata dal suo collaboratore di lungo corso, il fotografo Willy Vanderperre. Era bellissima, naturalmente, ma anche molto lontana dalle adv sexy cui Calvin Klein aveva abituato il suo pubblico. Nell’agosto del 2018, poi, è arrivata quella con le sorelle Kardashian, un chiaro tentativo di venire incontro alle necessità del marchio. L’esperimento Simons-Calvin Klein, allora, ci dice molto dello stato dell’industria: intanto sulla figura del direttore creativo, al quale si richiede con sempre maggiore insistenza di produrre una visione unica per tutte le categorie di prodotto, una visione che sia allo stesso tempo sofisticata ma comprensibile a una tanto larga quanto indefinita fetta di pubblico, quindi sull’inefficacia di molte strategie di rilancio, che si piegano oggi a una voracità del mercato difficile da sostenere con l’approccio strutturato tipico dei grandi brand. Nella conferenza di novembre, d’altronde, Chirico aveva espresso soddisfazione per i risultati di Tommy Hilfiger, altro marchio controllato dal gruppo, che nei tre mesi presi in esame «ha riportato un incremento delle vendite dell’11% a 1,1 miliardi di dollari (oltre 960 milioni di euro)». L’errore di fondo, forse, sul quale dovremmo riflettere in vista di un mercato che va sempre più uniformandosi, sta probabilmente proprio lì: aver pensato che Calvin Klein, Raf Simons e Tommy Hilfiger fossero la stessa cosa.

Il weekend lungo dedicato alle collezioni maschili, sempre più ristretto e sempre meno affollato, racconta bene la bizzarra situazione della moda oggi, che sembra non voler più lanciare grandi messaggi ma nascondersi nei vestiti che produce. Segno di tempi complicati o irrilevanza?

I Guest Designer di questa edizione – Homme Plissé Issey Miyake, Niccolò Pasqualetti e Post Archive Faction – sono tre diversi esempi di come oggi i marchi, sia quelli con un heritage alle spalle che quelli di nuova generazione, provano a raccontarsi in un panorama sempre più difficile.