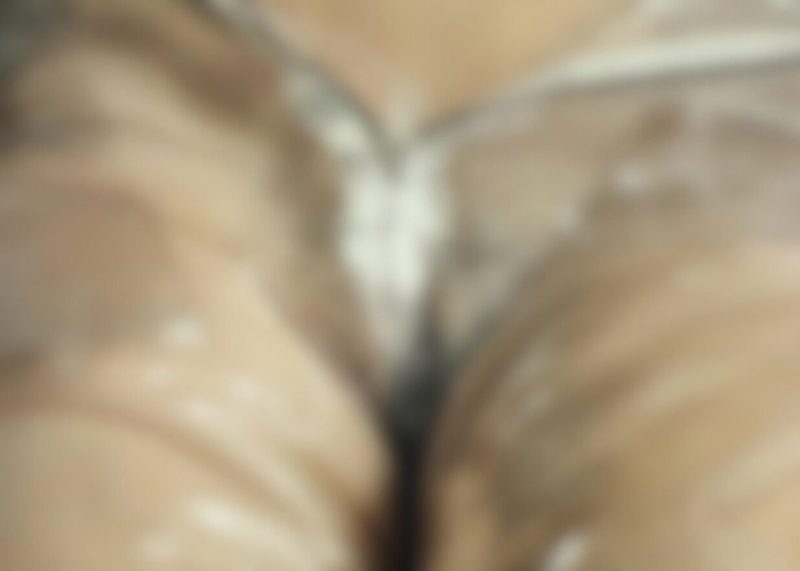Almeno, secondo le più accreditate teorie elaborate sui social sarebbe il suo e la fotografia l'avrebbe scattata Talia Chetrit.
The Wire: la televisione, la letteratura/2
Seconda parte dell’articolo di Tim Small su The Wire e i nuovi paradigmi narrativi. Questa la prima parte.
La crime fiction come letteratura realista / sociale
Per descrivere le opere di cui tratto, utilizzerò sempre la definizione “crime fiction” e non la definizione “giallo”. Questo perché il “giallo”, per come è spesso inteso nella nostra cultura, sarebbe, in inglese, un “whodunnit”. Un “chil’hafatto”, letteralmente. I romanzi di crime fiction di cui parlo non trattano di “mistero”, non catturano il lettore col trucco del “vediamo se scopri chi è l’assassino prima del detective”. La crime fiction, non fa niente di tutto questo, e andrebbe piuttosto definita come “narrativa realista incentrata attorno a un crimine”—ma è una definizione un pelo macchinosa. E la crime fiction non usa il crimine—generalmente, un omicidio—per creare suspense o mistero o per spingere il lettore a prendere il libro come un puzzle da risolvere. Nella crime fiction, come dice Richard Price, (e sto parafrasando), il crimine non è altro che una scusa, un espediente per esplorare un mondo popolato da tanti personaggi diversi che, se non fosse per lo scontro dell’omicidio e la sua onda d’urto, per le indagini e le ripercussioni ad esse collegate, non si sarebbero mai incontrati. Proprio come Philip Marlowe che, per Chandler, era poco più che un trucchetto narrativo per poter creare una successione credibile di dialoghi, storie e caratterizzazioni che partono dal senzatetto e arrivano al sindaco, passando per un banchiere, una ricca ereditiera, un mafioso, un bambino, un immigrato, chiunque. Il protagonista-detective permetteva a Chandler di dipingere, nell’arco del libro, un ritratto dell’intera gamma di persone che popolavano la sua gotica Los Angeles—la vera storia che voleva raccontare. Allo stesso modo, il crimine nella crime fiction di Price, Pelecanos, Lehane, Willeford e Leonard non è altro che un modo di infilare, con un senso logico e con coesione, svariati personaggi di estrazioni sociali, razza, sesso e credo diversi in qualche centinaia di pagine, per parlare, infine, della realtà della vita nelle città americane. Nel caso della maggior parte di questi autori, quest’approccio è legato all’impulso tradizionale del romanzo realista-sociale: quello di raccontare la realtà, di “svegliare” il lettore alle scomode verità del mondo. Ancora più specificamente, Price, Lehane, Simon e Pelecanos sono tutti, a modo loro, interessati al disfacimento e al degrado del tessuto urbano condiviso sia dai loro personaggi che dagli abitanti in carne ed ossa delle loro città natali. Di autore in autore, oltre a qualche notevole variazione stilistica, alla fine dei conti cambia solo la città d’ambientazione. L’equazione autore/città è la seguente: se Chandler/Los Angeles, allora Price/New York-New Jersey, Pelecanos/Washington, Lehane/Boston, Willeford/Miami, Leonard/Detroit. E The Wire/Baltimora.
Lo schermo è un po’ meno piccolo
Prima della premiazioni degli ultimi Academy Awards, chi avrebbe mai detto che sarebbe finito tutto come una celebrazione di Kathryn Bigelow e delle adrenaliche, proto-fasciste immagini di The Hurt Locker? Io no. Ma, dato che un osservatore attento alle dinamiche di Hollywood non guarda cosa succede durante ma cosa succede subito dopo gli Oscar, la domanda è: cosa fa Kathryn Bigelow nel momento in cui viene nominata a un numero spropositato di Oscar? La risposta è: inizia a sviluppare un progetto con HBO. Lo stesso canale responsabile della nascita—con Oz prima, con I Soprano, Six Feet Under, Deadwood e, soprattutto, con The Wire poi—del concetto stesso di “grandi serie televisive americane”. La Bigelow sceglie di spendere il suo gettone del “ora faccio quello che voglio”, per una “semplice” serie televisiva. E subito dopo, fresca di una scorpacciata di premi inaspettati, e della libertà di potere, per un solo, splendente momento della sua vita creativa, fare assolutamente qualsiasi cosa le passi per la testa e trovare dei soldi per farlo, la Bigelow si rende protagonista di qualcosa di incredibile fino a pochi anni fa: inizia a programmare il cast e a pianificare le prime riprese della sua nuova serie televisiva.
The Washington Wizard
Sebbene sia responsabile di uno dei corpus narrativi più impressionanti usciti negli ultimi anni, George Pelecanos è considerato un autore “di culto”. Non è detto che questo non cambi entro breve, non se tutto andrà come sospetto, ma ora come ora, non è considerato oltre i confini del suo “genere”. Nato a Washington, D.C., nel 1957, Pelecanos ha scritto 17 romanzi, quasi tutti ambientati nella sua città natale, e tutti in epoche diverse, dal dopoguerra ad oggi. In questi 17 romanzi, Pelecanos ha sviluppato un’analisi di D.C. che, in termini di perspicacia, intelligenza e acume sociale—in termini di puro valore—non mi vergogno nel definire un documento di riferimento definitivo per chi fosse interessato alle dinamiche del disagio urbano nell’america contemporanea. Preso nella sua interezza, il lavoro di Pelecanos lascia col fiato sospeso. I suoi romanzi sono talmente accurati e credibili, talmente ricercati ed evocativi, che lasciano al lettore la sensazione quasi fisica di aver vissuto la maggior parte della propria vita nei quartieri della capitale americana. E l’autore fa tutto questo senza dimenticare di divertire il lettore con la (gasp!) trama avvincente, con personaggi autentici ed entusiasmanti, con dialoghi plasmati da un orecchio attentissimo a come si parla inglese per le strade americane. Il suo capolavoro è indubbiamente il “Quartetto di D.C.”: una “serie” di romanzi legati tra di loro quasi esclusivamente dalla città nella quale sono ambientati. Il Quartetto traccia in maniera indelebile l’evoluzione (o l’involuzione) della capitale americana. Il primo volume, The Big Blowdown, ambientato nel 1946, parla principalmente delle tensioni tra immigrati greci, irlandesi e italiani con l’aggiunto valore di godere di un’atmosfera estremamente immersiva, mentre King Suckerman, ambientato nel 1973, dipinge un ritratto dell’inizio delle tensioni razziali tra bianchi e neri, e dell’inizio del traffico di droga su larga scala agli angoli di strada della capitale. Il mio preferito dei quattro, The Sweet Forever, ambientato nel 1986, racconta l’ormai avvenuto disfacimento del tessuto urbano americano da parte del narcotraffico, poco prima dell’esplosione del crack nelle strade americane. L’ultimo libro della quadrilogia, Shame the Devil, avvicina il tutto ai giorni nostri, essendo ambientato in un 1995 in cui i problemi discussi nei precedenti romanzi non solo non sono stati risolti, ma si sono cementati, sono diventati dei dati di fatto. Oltre alla città, l’altro filo conduttore della tetralogia è il cast. Ma non stiamo parlando del tipico, solitario investigatore che affronta diverse avventure in ogni capitolo della saga—anche perché in una trilogia precedente, Pelecanos aveva già creato il “suo” Philip Marlowe: il detective/barista Nick Stefanos. Piuttosto, con il Quartetto, l’autore ha avuto l’ambizione (o l’arroganza) di creare una famiglia di personaggi intrecciati, chi dal sangue, chi dal matrimonio, chi dall’amicizia, di diverso tipo ed etnia—poliziotti, tossicodipendenti, dj, gestori di tavole calde, di negozi di dischi, di palestre. Personaggi che si ripresentano di libro in libro, in diversi momenti della loro vita, facendo diversi lavori, affrontando diversi problemi. Il risultato finale è mostruoso: alla fine dei quattro libri, si ha davvero l’impressione di non aver conosciuto solo dei personaggi, ma di aver conosciuto tutta una città, e di averla vista crescere, cambiare—anche morire, attraverso le tante storie dei suoi abitanti. Le stesse storie che cumulandosi creano l’esperienza condivisa che altro non è, poi, che il carattere, l’anima della città stessa. Che è poi lo stesso approccio condiviso da The Wire.