Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.
Usiamo troppe parole inglesi?
Sull'uso e abuso degli anglicismi in italiano, a partire dal nuovo Devoto-Oli: un elogio del capitalismo lessicale.

Considerate, per un minuto, la parola “ragazza”. Le altre lingue latine utilizzano termini di origine, guarda un po’, latina: in francese “fille”, da filia; in spagnolo “chica”, da ciccum, “nulla” e, per estensione, “cosa di poco valore” (un “nigutin”, si direbbe in milanese); in romeno “fată”, da fetus, prole. L’italiano, invece, no. Noi siamo andati a cercarci una parola di origine araba: “ragazza”, che secondo l’enciclopedia Treccani deriva da raqqāṣ, «fattorino, corriere», e che io invece credevo venisse da raqisa, ballerina. Cambia poco, il dato è che, a un certo punto, abbiamo deciso di prendere in prestito un vocabolo di una lingua assai diversa per indicare qualcosa che aveva già un nome. È facile capire perché l’italiano abbia attinto dall’arabo parole come “algebra” o “algoritmo”: era roba loro. Ma perché “ragazza”? Di certo non mancavano i vocaboli nativi – meglio: autoctoni – per descrivere una giovane donna.
Quando ho letto che la nuova edizione del Devoto-Oli, il più prestigioso dizionario italiano, curata da Luca Serianni e Maurizio Trifone, ha introdotto una serie di schede volte a incentivare l’utilizzo di parole italiane al posto di alcuni anglicismi, il mio primo pensiero è che fosse un’operazione antistorica, oltre che fallimentare in partenza. Qui, ho pensato, si calpesta la naturale evoluzione delle lingue, che da sempre incorporano, adattano e rielaborano i vocaboli altrui. Il principio guida della nuova sezione del dizionario, intitolata “per dirlo in italiano”, è che ricorrere a una parola straniera è inelegante, se non propriamente sbagliato, quando esiste un termine italiano equivalente; al contrario, i prestiti linguistici meritano di essere valorizzati quando servono a dare un nome a qualcosa che altrimenti non ne avrebbe uno. È una politica in cui si riconosceranno forse alcuni editor, anzi “redattori editoriali”, e che potrebbe essere riassunta così: da evitare “badge” (meglio “cartellino” o “distintivo”), “selfie” (perché non “autoscatto”?) e “brand” (“marchio”); in compenso vanno benissimo “Brexit”, “post” e “muffin”.

A onore del Devoto-Oli, va detto che la sua lotta contro gli anglicismi non è quello che rischia di sembrare e non è, a conti fatti, una lotta: tra i neologismi inseriti nella nuova edizione figurano “spoilerare”, “trollare” e “friendzonare”, nonché il contestatissimo “briffare”. «Non vogliamo condurre una battaglia purista», racconta Trifone, uno degli autori del dizionario, docente di linguistica a Cagliari, in una chiacchierata con Studio. «Abbiamo ben chiaro che le lingue sono continuamente in evoluzione e che le contaminazioni e gli scambi fanno parte di questa evoluzione. Dunque non combattiamo gli anglismi… ma soltanto gli anglismi inutili e ridicoli. Perché ricorrere a una parola inglese quando c’è una parola italiana di più trasparente e di più facile comprensione?»
Però, ecco, non è bastato a liberarmi della diffidenza iniziale, di quell’insofferenza che ho provato quando ho letto la notizia del vademecum per evitare gli anglicismi inutili, di cui hanno parlato un po’ tutti, dal Corriere della Sera a mia zia su Facebook. Non c’è bisogno di essere dei fini linguisti per rendersi conto che questo diktat del non usare una parola straniera quando ce n’è una nativa non è applicabile e che, soprattutto, se fosse mai stato applicato, oggi non parleremmo italiano. Non esisterebbero parole come “ragazza” o come “guardare”, un prestito dalla lingua franca, nel senso degli antichi francesi che in pratica parlavano tedesco. Senza contare che il nostro linguaggio quotidiano è fatto di sfumature, giochi, rimandi e sottintesi: diciamo “diktat” anziché “imposizione” perché evoca una serie di stereotipi sui tedeschi, gli stessi che spingono certi anglofoni colti a dire “Verboten” quando potrebbero benissimo dire “forbidden”, e che in tempi di rigorismi fiscali recuperano anche di attualità.
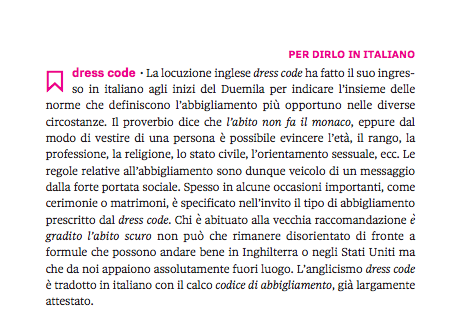
Dunque, mi dicevo, evviva la lingua che cambia per il solo gusto di cambiare, e non per necessità, abbasso i grammar nazi. Poi però ho avuto la malaugurata idea di cambiare shampoo (dall’hindi champò, massaggiare, anche se tutti quelli che hanno visto Ranma ½ credono sia di derivazione cinese) e ho visto che sulla nuova boccetta c’è scritto: «Distribuire in modo omogeneo, risciacquare e procedere con il brushing». Procedere con il brushing. Evidentemente, un problema c’è: nella mia furia anti-grammar nazi, che in fondo poi è un’altra forma di nazismo grammaticale, mi ero persa qualcosa.
Nicoletta Vallorani, docente di cultura inglese e anglo-americana alla Statale di Milano, lo definisce un «impoverimento linguistico influenzato in parte all’esposizione all’inglese». Vallorani non è il genere di persona facilmente accusabile di anglofobia. Ama l’inglese e sa bene che «non si può, e nemmeno si deve, fare nulla contro la trasformazione della lingua e l’arricchimento del lessico tramite termini stranieri». Però, mi dice facendo due chiacchiere al telefono, ci sono due sotto-specie di cambiamenti che forse andrebbero arginati. «Quando l’utilizzo di termini stranieri diventa una cosa deliberata, fatta per moda, come avviene spesso in certi ambienti lavorativi, allora è un altro discorso. La prima parola che mi viene in mente è ‘storytelling’, che è ovunque e sinceramente non se ne può più». Abbiamo tutti in mente quel gergo, molto milanese o corrispondente a un certo stereotipo di Milano, fatto di anglicismi strategici, buzzword un po’ fine a sé stesse, che in molti trovano irritante: “storytelling”, appunto, ma anche “location”, “mood” o “cheap”. Poi, aggiunge, ci sono gli anglicismi che sono il risultato della semplice pigrizia: siamo talmente esposti ai media angloamericani, che a volte fatichiamo a trovare le parole in italiano (infatti in questo articolo ho scritto più volte la parola “nativo” e ci ho messo un po’ a ricordarmi che esisteva anche la parola “autoctono”).
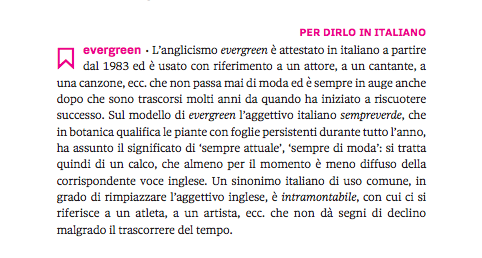
Certi anglicismi trasmettono, inutile negarlo, una sciatteria deprimente. Resta da chiedersi che cosa separa un prestito linguistico prezioso da uno sciatto. Perché “location” fa subito manager truzzo e “Weltanschauung” no? Trifone parlava di «anglicismi inutili», insomma la famosa regola dell’evitare i termini stranieri quando c’è un equivalente italiano, ma è un terreno scivoloso. Primo perché le parole inutili sono spesso le più belle: io amo molto lo Yiddish “Gevald!”, anche se esiste una perfetta traduzione in italiano, “catastrofe”. E, secondo, perché di prestiti “inutili”, insomma di parole straniere che col tempo hanno soppiantato una radice nativa, la lingua italiana è piena zeppa, vedi i vocaboli “ragazza”, “guardare”, e pure “Weltanschauung”. Trifone però mi ha fatto notare anche un secondo elemento di distinzione, che ho trovato molto più convincente: la mancanza di trasparenza. Alcuni termini stranieri, spiega lo studioso, sono utilizzati, in modo più o meno deliberato, «con fini eufemistici», insomma per infiocchettare un concetto o, peggio ancora, per confondere le acque. “Jobs on call” suona molto meglio di “lavoro a chiamata”, ma è la stessa cosa. Chi dice “location” vorrebbe fare figo, ed è proprio questo, il volere fare figo, che è una cosa tristissima e da vorrei ma non posso, che ci dà l’orticaria.
Resta un’ultima domanda, però. Se è vero che esistono degli anglicismi sciatti, allora ha senso tentare di arginarli? In fondo, l’evoluzione della lingua, sciatta o preziosa che sia, è un processo naturale, e chi cerca di fermarlo rischia di trovarsi dalla parte sbagliata della storia. Una risposta interessante a questo quesito me l’aveva fornito, qualche tempo fa, un lettore di Studio, che aveva criticato un mio vecchio articolo contro i “grammar nazi”: «Resistere ai cambiamenti linguistici serve a creare l’ostacolo evolutivo contro il quale i cambiamenti della lingua devono prevalere per affermarsi, evitando così che ogni settimana il nostro lessico debba incorporare l’allocuzione du jour». Protestare davanti ai vari “briffare” e “storytelling”, allora, non è solamente un’attitudine estetica, ma ha anche una sua funzione darwiniana, perché crea un clima competitivo, adatto a una selezione della specie. Passano i vocaboli che superano l’ostacolo dei grammar-nazi, e dei Devoto-Oli, e delle professoresse d’inglese. Chiamatelo, se volete, capitalismo lessicale.
Dizionario inglese illustrato, circa 1860 (Hulton Archive/Getty Images); alcuni lemmi della sezione “Per dirlo in italiano” del Devoto-Oli, 2017.
Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.



