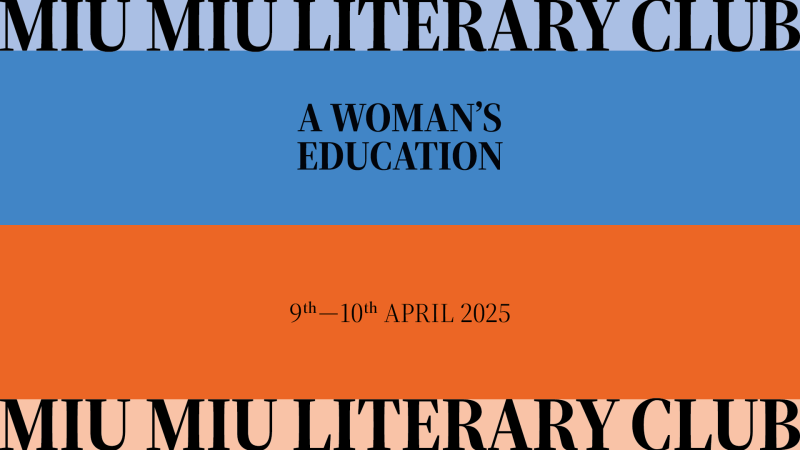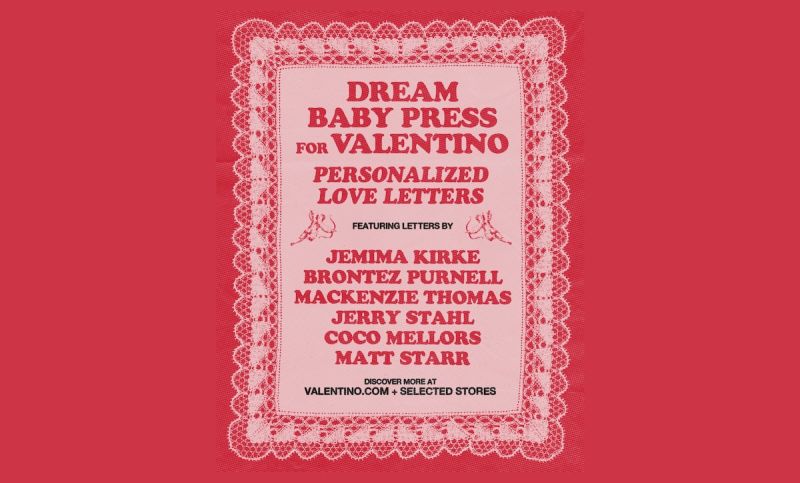Marchi in cerca di identità
Le diverse strade che oggi percorrono i brand per attirare nuovi clienti e creare o mantenere il loro status, a cominciare da Tiffany.

L’acquisizione di Tiffany&Co. da parte di Lvmh è stata una delle più complicate degli ultimi mesi, complice anche la pandemia, ma alla fine si è conclusa, consolidando e rafforzando lo strapotere del gruppo del lusso francese. A distanza di qualche mese sono arrivate anche le prime avvisaglie di un “rebranding”, ovvero del riposizionamento del marchio: a New York e Los Angeles, oltre che sugli account social del marchio di gioielli, si sono visti infatti nuovi cartelloni pubblicitari, il cui claim principale è “Not your mother’s Tiffany”, letteralmente “non il Tiffany di tua madre”. Addio, almeno per ora, anche al Blu Tiffany, quel colore Pantone che l’azienda ha registrato negli Stati Uniti e che da solo incapsula lo status di un gioiello Tiffany, spesso il primo regalo importante per una giovane donna, ma anche economico – ecco perché la scelta dell’argento 925 – già dal 1851. Addio, dunque, American Classics. E benvenuta Gen Z: nelle nuove immagini le modelle abbinano l’eterna collana a catena a una canottiera a costine e un makeup-no-makeup in stile Glossier. Stessa operazione per il Bone Cuff, il bracciale disegnato da Elsa Peretti nel 1974, e per altri pezzi continuativi e famosissimi.
Tra i commenti social si sono piazzati già gli schieramenti di tifosi, emoji entusiaste versus commenti di disappunto che vanno dal “Sono una mamma… Dunque io non vado abbastanza bene? I miei valori e pensieri sono troppo sciocchi?” fino al “Il punto di un marchio iconico è proprio di essere il brand della mamma, della nonna. E proprio per questo è anche quello della figlia”. Accoglienza diversa per l’annuncio dei nuovi testimonial, Beyoncé e Jay Z, con le prime immagini svelate a fine agosto. In “About Love” i rimandi alla tradizione ci sono, dal Blu Tiffany nell’opera di Basquiat che fa da sfondo all’abito Givenchy (come quello di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany), il diamante giallo indossato solo tre volte prima, ma la chiave d’interpretazione è certamente un’altra. Diamante che ha anche suscitato non poche polemiche, così come molto è stato scritto sull’utilizzo dell’opera di Basquiat a fini commerciali e sull’attivismo delle celebrity, anche quando sembrano intoccabili come Beyoncé. A prescindere dalle prime impressioni, per il nuovo proprietario di Tiffany, Bernard Arnault, la ricerca di un nuovo target è l’imperativo: lo ha già fatto con Rimowa, il marchio di valigeria guidato dal figlio Alexandre che è stato rivoluzionato per diventare desiderabile agli occhi dei Millennial con alto potere d’acquisto, e con Dior, per cui Maria Grazia Chiuri e il suo femminismo formato T-shirt. La strategia da quelle parti è guardare al nuovo consumatore, e pazienza se quello vecchio farà fatica ad adattarsi.
Storia simile è quella recente di Victoria’s Secret, ma con un processo più evidente reso necessario da una lunga serie di critiche e accuse. Era il 2019 quando l’ex capo del marketing Ed Razek dichiarava in un’intervista che non ci sarebbero state modelle plus-size né transessuali sulla passerella dell’annuale sfilata trasmessa in tv. Insomma, Victoria’s Secret non aveva alcuna intenzione di passare dai corpi perfetti, statuari e provocanti di Gisele Bündchen, Adriana Lima e Irina Shayk a quelli imperfetti, quindi normali, che stavano invadendo la comunicazione di una nuova generazione di marchi del settore. Due anni dopo è arrivato l’annuncio di un ritorno al fashion show (le ultime due edizioni erano state cancellate) ma con l’intenzione di essere «culturalmente rilevanti», secondo le parole del Ceo Martin Waters. Angeli in pensione, dunque, e una lista di nomi delle nuove testimonial che più culturalmente rilevanti non si può: la calciatrice Megan Rapinoe, l’attrice Priyanka Chopra Jonas, la sciatrice freestyle Eileen Gu, la modella curvy Paloma Elsesser, la modella ex rifugiata del Sudan Adut Akech, la fotografa Amanda de Cadenet e l’attivista Lgbtq e modella transgender Valentina Sampaio. Quello di Victoria’s Secret è l’esempio più estremo tra i rebranding degli ultimi anni, esplicativo di quanto le aziende siano diventate politiche, almeno nella comunicazione, all’inseguimento di un target iper sensibile ai valori e ai cambiamenti sociali in atto. Non è detto ovviamente che una certa operazione di marketing sia il riflesso di un reale cambiamento, però, e in un’epoca di call-out quotidiani (e in questo caso di indagini che parlano di bullismo e molestie), Victoria’s Secret sta agendo di conseguenza. Poche settimane fa, infatti, ha annunciato un investimento di 90 milioni di dollari per rafforzare i processi interni di indagine e segnalazione sui casi di molestie sessuali e per migliorare le condizioni aziendali di inclusività e diversità.
La contrapposizione crescente tra identità e nuove sensibilità riguarda anche la moda intesa come microuniverso in cui ogni collezione, sfilata o campagna pubblicitaria diventa osservazione dei cambiamenti sociologici in atto, e di come questi si riflettono negli abiti. I marchi rimasti fedeli al loro status rafforzano le proprie idee attraverso immagini ma anche dichiarazioni aziendali, come Chanel che annuncia la prossima sfilata Cruise a Dubai, spazzando via qualsiasi possibilità di non tornare ai meccanismi della moda pre-pandemia. Quelli diventati contenitori sono più fluidi e malleabili che mai, come Bottega Veneta che non ci pensa due volte e cancella gli account social. Ma si rincorrono anche gli uni con gli altri. Da una parte la riorganizzazione di Missoni non prevede l’arrivo di un designer star per non dare discontinuità con la storia del brand, ma la collaborazione con realtà e community molto lontane dal target tradizionale, come quelle già annunciate con l’azienda italiana di sneakers sostenibili ACBC e con il brand streetwear Palm Angels. Dall’altra Gucci riorganizza e apre il suo archivio a Firenze e rilancia modelli di borse nati decenni fa, ultima in ordine cronologico la Diana.
Tutto è polarizzato e niente è davvero lineare, sarà a causa delle tempistiche stringenti che dovevano polverizzarsi con la presa di coscienza data dalla pandemia e che ora invece fanno correre la produzione alla ricerca di una risalita delle vendite. E così il manifesto più esplicativo di un brand non è più la sfilata prêt-à-porter: il calendario della Milano Fashion Week di settembre è già fittissimo, con 42 sfilate in presenza, varianti permettendo. Non lo è nemmeno più la campagna pubblicitaria, ora frammentata in infiniti contenuti social destinati a durare nell’immaginario quanto la viralità di un post su Instagram. Ma è l’Haute Couture – si veda il ritorno, 53 anni dopo, di Balenciaga – ultimo stendardo fuori dalla pressione del sistema, diventa l’occasione per schierarsi, dichiarare la propria identità, fedele allo status oppure no, che sia.