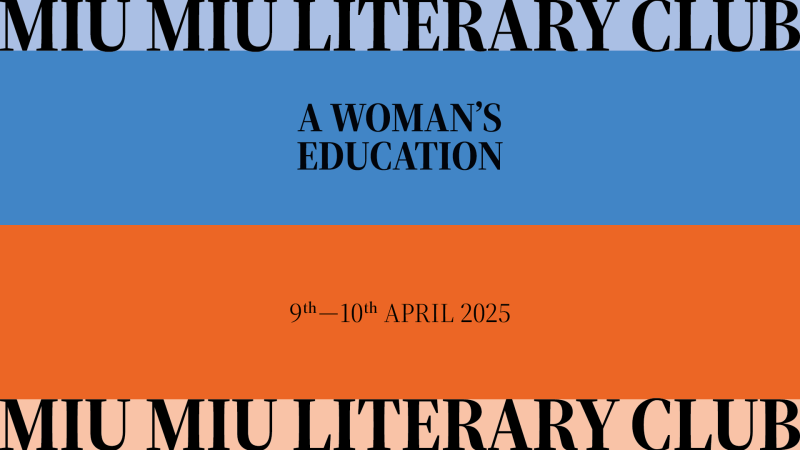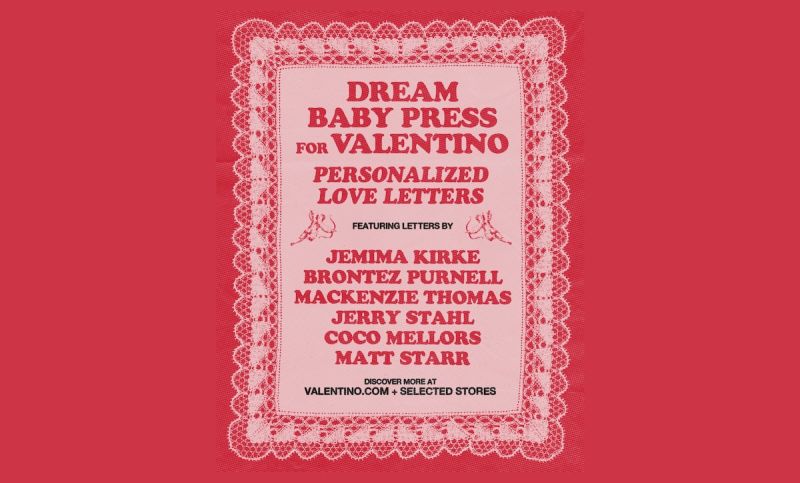Il “September Issue” e la politica nei giornali di moda
Il numero più importante delle riviste femminili si è trasformato in manifesto, in un tentativo estremo di ridisegnarne la rilevanza.

Una cifra, 840, sfoggiata con orgoglio in copertina: si riferisce alle pagine del numero di settembre 2007 di Vogue Us, il più alto mai raggiunto fino a quel momento da una rivista patinata (che sarà superato dalla stessa edizione diverse volte negli anni a venire). D’altronde, «settembre è il gennaio della moda», lo sanno tutti, come dichiarava l’ex fashion editor Candy Pratts Price nel documentario del 2009 The September Issue, che aprì per la prima volta le porte della redazione di Anna Wintour. Non solo per Vogue, settembre è stato a lungo il numero più importante dell’anno, sia perché dettava le tendenze della nuova stagione, sia perché, appunto, raccontava lo stato di salute dei giornali, facilmente misurabile in base alla quantità di pagine pubblicitarie presenti. Oggi le prime sono immediatamente fruibili online e sui social, talmente veloci da mangiarsi l’un l’altra e in questo momento minacciate dalla pandemia, mentre il conteggio non viene più dichiarato dagli editori. Lo ritengono inadatto perché non comprensivo delle inserzioni online e dei contenuti native, anche se gli introiti delle due voci non hanno mai raggiunto quelli relativi alle edizioni cartacee.
Gran parte del successo intorno al concetto di “September Issue” lo si deve attribuire ovviamente sempre ad Anna Wintour, Gran maestro a Condé Nast dal 1988, quando Alexander Liberman la scelse per ringiovanire la testata americana. «Il mio piano era quello di assumere donne più giovani, usare modelle più dinamiche e cercare qualche nuovo fotografo per studiare un approccio diverso. Mi basavo più sull’istinto che sulla ricerca, fidandomi delle mie idee e osservando come le donne si vestivano in quegli anni», ha raccontato la direttrice tempo dopo. Così, la copertina con il top ricamato di Christian Lacroix da diecimila dollari abbinato a un paio di jeans, le supermodelle trasformate da ragazze della porta accanto a sogno americano, le celebrity in copertina, compresa Hillary Clinton nel 1998, in pieno scandalo Lewinsky, e il numerone di settembre, considerato la Bibbia di stagione. A guardare la copertina di settembre 2020 di Vogue Us si direbbe che parliamo di tutt’altra rivista. Due immagini, non fotografate ma dipinte, da Kerry James Marshall e Jordan Casteel, che raffigurano due donne nere. Una è immaginaria, l’altra è la stilista Aurora James, che lo scorso giugno ha lanciato la campagna “15 Percent Pledge” a supporto delle aziende di proprietà di afroamericani. Vogue ha dichiarato di aver dato completa libertà ai due artisti, con la sola richiesta che scegliessero un abito di uno dei quattro designer selezionati dalla redazione da far indossare al loro soggetto. Eppure, le loro scelte non potrebbero essere più esplicative del tentativo della rivista di rendersi politica, «in un anno in cui il mondo è capovolto dalle piaghe di Covid-19 e dall’incompetenza presidenziale», come ha scritto Dodie Kazanjian nell’editoriale di presentazione del numero.
E non solo. Se la pandemia ha colpito duramente il modello di business dell’editoria, ancora in gran parte legata alla forza degli inserzionisti piuttosto che a quella dei lettori, se il lockdown ha costretto le riviste a ripensare a tutte le pagine creative, da mesi riempite di fotografie e atmosfere fai-da-te, su Condé Nast e sulla stessa Wintour, che da un anno ricopre anche il ruolo di Global Content Advisor di tutte le testate, si sono anche scatenate diverse accuse di razzismo e di poca inclusività, come raccontavamo qui. Oltre alla vicenda Bon Appétit, che ha portato alle dimissioni del direttore Adam Rapoport e alla recente nomina di Dawn Davis, è finito sotto i riflettori anche l’amministratore delegato Roger Lynch, colpevole di aver detto in una riunione che le situazioni di disparità avrebbero potute essere risolte se i dipendenti ne avessero parlato prima. E alla Wintour, che si è scusata con il suo staff per aver pubblicato materiale offensivo e intollerante e per non aver fatto abbastanza per promuovere e dare spazio a giornalisti, scrittori, fotografi, designer e creativi neri (solo l’anno scorso un fotografo afroamericano, Tyler Mitchell, ha firmato per la prima volta una copertina di Vogue).
Politica è anche l’iniziativa di scegliere un tema, quello della speranza, per tutte le ventuno edizioni di Vogue. Spiccano quella inglese, sulla cui copertina si legge “Activism Now”, guidata da Edward Enninful, ex fashion editor alla corte di Anna che grida «I wanna kill myself» nel documentario a causa di un servizio che non incontra l’approvazione di lei, oggi decisamente più tagliato per il ruolo di traghettatore della rivista nel mondo contemporaneo. Infatti mette in copertina «una serie di voci, vecchie e giovani, che hanno dedicato la loro vita a lottare», dopo aver già pubblicato i lavoratori dei servizi essenziali nel numero di luglio, e le quattordici versioni di altrettanti artisti del concetto di “reset” su quello di agosto. Apparentemente, tutto senza sforzo. Diversa la scelta di Vogue Italia. Dopo la copertina completamente bianca di aprile, già oggetto di culto tra i collezionisti, e scelta perché «il silenzio ci sembrava il giusto messaggio di rispetto e di riserva», ora il tema della speranza coincide con quello del tentativo di ripartenza, con «una sfida ai canoni di quantità con cui la moda si è sempre misurata»: 100 copertine, tutte scattate a New York dal fotografo Mark Borthwick, a 100 persone con storie interessanti, a cui è stato chiesto di raccontarle in un minuto.
E politici sono anche molti altri numeri di settembre di questo 2020. Sempre in casa Condé Nast, Vanity Fair ha affidato il numero allo scrittore Ta-Nehisi Coates e ha messo in copertina Breonna Taylor, la 26enne di Louisville uccisa lo scorso marzo da alcuni agenti che avevano fatto irruzione nel suo appartamento, raccontata attraverso le parole di sua madre. Alla guida della rivista c’è dal 2017 Radhika Jones, che ha sostituito lo storico direttore Graydon Carter. Per la sua prima copertina aveva scelto l’attrice Lena Whaite, lontana dal mondo patinato che è sempre stato oggetto della attenzioni del mondo Vanity ed espressione invece di una nuova generazione di creativi. Sul nuovo Harper’s Bazaar di Samira Nasr c’è invece Rihanna (anche su tutte le altre edizioni internazionali di Bazaar). Il debutto di Nasr, ex Vanity Fair e oggi prima direttrice non bianca della rivista, somiglia più che mai a un manifesto: ««Da figlia orgogliosa di padre libanese e di madre trinidiana, la mia visione del mondo è sempre stata inclusiva ed è ancorata alla convinzione che la rappresentazione sia importante», aveva infatti detto al momento dell’annuncio del nuovo incarico, «Il mio obiettivo per natura è “colorato” e quindi è importante per me iniziare un nuovo capitolo nella storia di Bazaar facendo luce su tutti gli individui che credo siano le voci ispiratrici del nostro tempo. Lavorerò per dare a tutte le voci un piattaforma per raccontare storie che non sarebbero mai state raccontate».