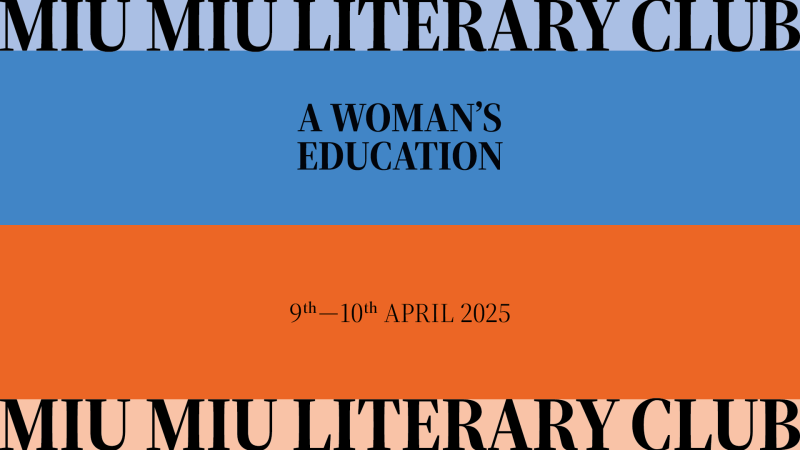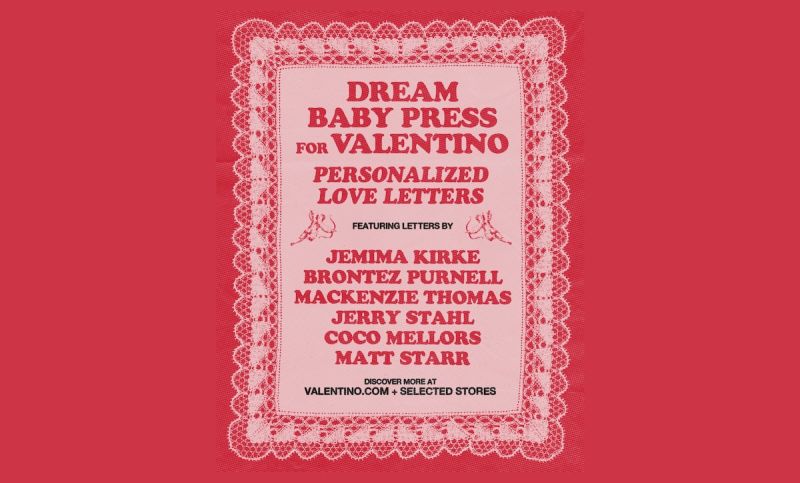I resi sono diventati un problema
Siamo abituati a considerarli complementari all’esperienza di shopping online, ma sono insostenibili, sia per l’ambiente che per gli stessi marchi.

È indubbiamente una delle comodità di fare shopping online: ordinare un prodotto, provarlo a casa e, se non va bene, restituirlo senza pagare nulla, proprio come se fossimo in un negozio e lo lasciassimo in cassa al commesso. Durante lo scorso Black Friday, in Italia sono stati fatti 37 ordini al secondo su Amazon: fare compere in rete è ormai parte della nostra routine. Ma che i resi gratuiti fossero un problema lo abbiamo capito piuttosto in fretta. Secondo i dati riportati da Vogue Business ed elaborati da Optoro, azienda che lavora per ridurre e riutilizzare gli scarti di produzione, nei soli Stati Uniti i resi creano 5 miliardi di sterline l’anno in rifiuti che finiscono nelle discariche e più di 15 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio, «in pratica l’equivalente dei rifiuti prodotti annualmente da 5 milioni di persone». Nell’Unione europea, invece, nel 2016 i rifiuti da imballaggio hanno raggiunto la cifra record di 187 tonnellate l’anno, circa 170 kg a persona: questo perché, per spedire i propri prodotti, la maggior parte dei marchi fa affidamento su materiali plastici monouso, che sono poi i più difficili, se non impossibili, da riciclare. A questi numeri si aggiungano le condizioni lavorative spesso problematiche nei centri di smistamento per avere il quadro generale del problema.
I resi gratuiti, quelli di cui approfittiamo più volentieri e che anzi costituiscono, assieme alle spedizioni gratuite, una delle determinanti che ci spinge a comprare online, sono un bel problema anche per gli stessi marchi che, come più volte rilevato, soffrono l’adeguamento forzato all’esperienza di shopping fornita da Amazon e altri grandi rivenditori. Amanda Mull sull’Atlantic ha recentemente raccontato il caso di Etsy, la piattaforma e-commerce nata nel 2005 con l’intenzione di promuovere i piccoli marchi che vendono prodotti artigianali e vintage e che oggi, a discapito degli stessi, ha recentemente introdotto un algoritmo che favorisce chi spedisce gratis. È facile immaginare che, per i piccoli imprenditori che usano Etsy, la spedizione gratuita sia un costo spesso insostenibile, che va a impattare fortemente sui loro guadagni e, più in generale, sembra scontrarsi con la filosofia di partenza del canale che li ospita, nato appunto per dare risalto ai business di medio-piccole dimensioni. Ma l’algoritmo è modulato sui comportamenti dei consumatori, che oggi considerano una spedizione di due giorni e gratuita lo standard dell’acquisto online. Secondo una ricerca condotta nel 2018 da Internet Retailer, le ragioni più comuni per cui un acquirente abbandona il suo carrello virtuale senza comprare nulla sono in primo luogo le spese di spedizione, quindi l’impossibilità di comprare senza creare un account e la poca chiarezza sulle politiche di reso. Addirittura, «molti si risentono del pagamento per la spedizione così tanto che comprano articoli più costosi o aggiungono piccole cose aggiuntive – una mascherare il viso monouso, un paio di calze – solo per raggiungere l’importo minimo per la consegna gratuita».
C’è dunque una nuova psicologia dei consumi di cui stiamo iniziando a comprendere gli effetti, ma con la crisi dei negozi fisici, la sfida che attende molti marchi è quella di trovare la quadra nell’offrire un’esperienza di acquisto e un servizio sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale. Resi e spedizioni gratis, infatti, non danneggiano solo i piccoli rivenditori di Etsy, ma anche tutti quegli e-commerce (tra cui Net-a-Porter, Revolve, Nordstrom) che non hanno la struttura e la capacità distributiva del colosso di Jeff Bezos, che ha avuto, in tempi non sospetti, l’intuizione di staccare il costo delle spedizioni da quello del singolo acquisto con l’abbonamento annuale a Prime. Per aggirare il problema si stanno provando diverse soluzioni: i grandi magazzini come Nordstrom permettono di restituire la merce in negozio, ad esempio, mentre si moltiplicano le collaborazioni con aziende specializzate in riciclo e riuso, come Happy Returns. Piattaforme come Zalando e Asos stanno poi investendo nell’analisi dei dati sui loro utenti: una profilazione sempre più accurata, infatti, sembra oggi l’unico strumento in grado di ribaltare la catena di produzione ed eliminare gli sprechi. È una sfida aperta, tanto più in un momento in cui parliamo moltissimo di diritti sui nostri dati e di “consumerismo responsabile”: le contraddizioni di questo modello sono già visibili, ora ci tocca risolverle.