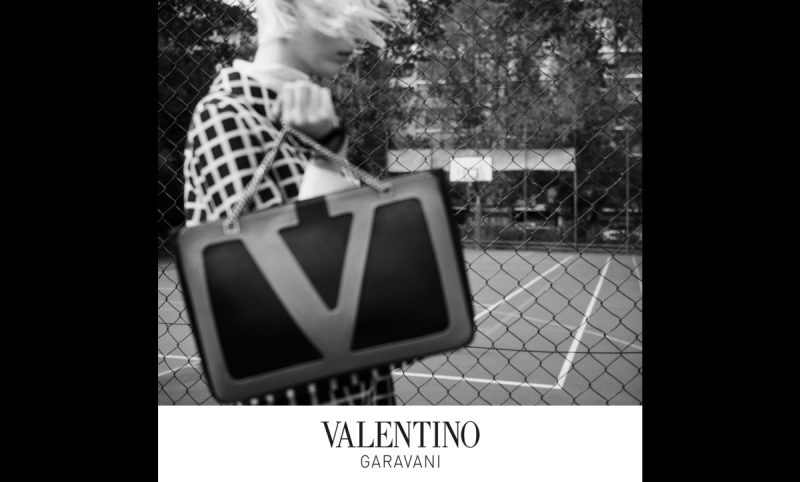L’ultima sfilata Couture di Balenciaga segna – questa volta in maniera definitiva – la fine dell’era Demna. Dieci anni in cui il Direttore creativo georgiano ha scritto la sua parte di storia della moda.
La fashion week di Milano è diventata noiosa?
Dopo l’esplosione della narrazione intorno alle sfilate, la moda oggi sembra essersi assestata su una prudenza che non è banalità, ma che di certo racconta di un momento difficile.

È passato un mese da quando ha sfilato, durante la settimana dell’alta moda a Parigi, la collezione Artisanal 2024 di Maison Margiela, uno show che è stato commentato con particolare entusiasmo sia dagli addetti ai lavori sia da chi segue la moda sui social. Potremmo considerarlo il momento in cui una nuova generazione di appassionati ha scoperto per davvero John Galliano, non nella forma di post nostalgici su Tumblr ma in quella più reale e diorissima (Galliano è stato direttore creativo di Dior dal 1997 al 2011). Lo stilista non ha fatto una delle sue uscite finali, quelle che sono ormai parte della storia della moda, ma in fin dei conti era pur sempre una sfilata di Margiela. Se all’accostamento dei due nomi avete ancora un po’ di vertigini, siete vecchi o probabilmente un po’ pignoli, e immaginare Galliano e Margiela insieme non può che farvi riflettere sul cortocircuito che è la moda di questi tempi. Nondimeno la teatralità, il cast, la coreografia, il lavoro artigianale e soprattutto il tempo (più di sei mesi) dedicato alla costruzione della collezione Artisanal sono dei veri e propri lussi, che nell’industria di oggi può permettersi solo la couture. Sono le reazioni però la parte più interessante, un’accoglienza piena di stupore e sincera ammirazione che comunica una sempre più crescente fame di immaginari e bellezza, di mondi alternativi anche inaccessibili, che vivono perlopiù sui red carpet (le prime a indossare i look dello show sono state Hunter Schafer e Anya Taylor-Joy), ma di cui si può gioire gratis nelle nostre vite cronicamente online. Uno stupore che le sfilate di questi giorni a Milano non sono sembrate capaci di riprodurre, perché nel grande marasma che oggi forma le nostre opinioni tutto vive sul medesimo piano, o feed, e la couture sta insieme al prêt-à-porter, la moda italiana con quella francese, il guardaroba quotidiano con il tappeto rosso, le immagini con gli oggetti. Il problema di Milano è un altro, ma ci torneremo più avanti.

Prada Autunno Inverno 2024. Photo courtesy of Prada
Come qualche settimana fa per le collezioni maschili, Milano ha infatti espresso un’idea di moda molto concreta, ripetitiva, dove sembra non esserci spazio per altri mondi se non per l’inquietudine del presente, che ha fatto la sua incursione più prepotente da Prada. Ovviamente Miuccia Prada ha detto in backstage che non voleva lanciare nessun messaggio, ma anche che disegnare vestiti sta diventando sempre più difficile. La collezione era perciò un lavoro di sublime stratificazione che aveva come fulcro la storia, le sue ripetizioni e i suoi cliché: come si legge nella nota ufficiale «elementi tratti dalla storia influenzano capi stereotipati di oggi, come il chiodo, il bomber e la maglieria, cambiandone linee e particolari». Una storia frammentata, come frammentati erano gli abiti e i cappotti che sul retro si “spogliano” per esporre gli strati interni, aprendosi a una vulnerabilità che si rispecchiava anche nella musica, dove ad alcune bellissime canzoni d’amore, da “My Funny Valentine” nella versione di Nico a “Anyone Who Knows What Love Is” di Irma Thomas fino a “Nights In White Satin” dei Moody Blues nel finale, si intervallavano spezzoni della colonna sonora del film di Jonathan Glazer recentemente uscito nelle sale, La zona d’interesse. La sensazione era straniante: i cappelli che ricordavano quelli della cavalleria leggera degli Ulani stanno insieme ai fiocchi, ossessione di TikTok e della sua idea di “girlhood”, le borse si appendono ai ganci, il lino e la seta si accostano ai materiali più resistenti, la lingerie spunta dall’uniforme quotidiana. Tutto è complesso, ma anche disarmante nella sua chiarezza di pensiero.

Bottega Veneta Autunno Inverno 2024. Photo courtesy of Bottega Veneta
Anche Matthieu Blazy da Bottega Veneta ha ammesso che disegnare vestiti in questo periodo storico, dove le notizie sono dominate dalle guerre e dagli effetti del cambiamento climatico, è sempre più un’operazione complicata. La sua personale risposta è stata concentrarsi sul gesto di vestirsi ogni giorno, un gesto che ci accomuna tutti: rispetto alla demi-couture presentata a settembre, questa collezione è un esercizio di «intenzionale semplicità» che si rifà agli inizi del marchio (fondato nel 1966 a Vicenza da Michele Taddei e Renzo Zeggiaro) prima che l’intrecciato diventasse il suo motivo più riconoscibile. Blazy ha però una sua idea di semplicità, che questa volta è partita dalla materia senza stravolgerla (il cotone è cotone, la seta è seta, la pelle è pelle) e dal mescolamento di silhouette che, anche qui, si rifanno a epoche diverse: il risultato è un guardaroba tattile dove sono i dettagli e le pratiche a fare la differenza e il decoro è integrato nei tessuti, che da umili e resistenti diventano «fiammeggianti». Racconta di un esercizio di sintesi tutt’altro che scontato.
Come ha spiegato ai giornalisti prima della sfilata, anche Sabato De Sarno si è posto le stesse domande, scegliendo di continuare a costruire la sua visione per Gucci. Insistere sui capisaldi – «Il cappotto è qualcosa che mi fa sentire al sicuro e mi piacerebbe che le persone scegliessero Gucci perché vogliono viverci, in quei vestiti» – è un modo di mettere insieme tutte le sue idee sulla moda, con metodo. «Più che a raccontare una storia ora sono interessato al gesto di costituire una collezione», un gesto «sovversivo» che utilizza il panno del capospalla anche per gli abiti ma lo ammorbidisce sul corpo, ritaglia e ricompone ricami, pizzi e velluti, aggiunge strati alle sottovesti combinando diverse lavorazioni. «In questa collezione ho cercato di giocare con le cose che mi piacevano meno, come alcuni colori, per creare alla fine qualcosa che mi piacesse. Voglio essere considerato come qualcuno che ama la moda e non come qualcuno che ama l’idea di lavorare nella moda», ha aggiunto. De Sarno maneggia l’archivio con oculatezza, come nel caso della collana dal motivo borchiato, disegnata da Frida Giannini, il cui fiocco si abbina al capo più vicino al collo che ricorda la collana-sciarpa dell’uomo, gli stivali da cavallerizza (rimando all’heritage equestre) che diventano cuissardes e la nuova borsa a forma di mezzaluna reinterpretata in chiave modernista. Esuberante e genuino di persona, De Sarno è poi un designer dal segno estremamente razionale, e dalla mano italianissima: costruire Gucci è un’impresa titanica.

Gucci Autunno Inverno 2024. Photo courtesy of Gucci
Questi sono stati poi i giorni dei debutti: Matteo Tamburini da Tod’s, che ha presentato una collezione in linea con le aspettative, Walter Chiapponi da Blumarine e Adrian Appiolaza da Moschino. Chiapponi ha scelto di riportare Blumarine alle sue origini staccandosi dall’estetica Y2K che aveva dominato il marchio negli ultimi anni, mentre Appiolaza, che è succeduto alla direzione creativa di Moschino dopo la prematura scomparsa di Davide Renne lo scorso autunno, ha voluto anche lui ripartire dal linguaggio del marchio ma con un approccio comprensibilmente cauto: attendiamo le evoluzioni in tutti e tre i casi. Da MSGM Massimo Giorgetti si è ispirato alle eroine tragiche di Truman Capote, che sfidavano le convenzioni, per raccontare le donne di oggi, mentre Maximilian Davis da Ferragamo ha guardato agli anni Venti per una collezione che aveva al centro l’idea di protezione: divise e indumenti utilitaristici da pescatori, come gli stivali alla coscia, si contrappongono ad abiti fluidi e drappeggiati, con un’enfasi, anche qui, sul desiderio di comfort e sicurezza.
Da Emporio Armani la donna «tipicamente armaniana» rimane ancorata al suo guardaroba di fiducia, porta l’abito a mo’ di camicia sopra ai pantaloni vaporosi – comprensibile che al signor Armani non piaccia chi va in giro in mutande, anche se Bianca Censori ci è molto simpatica – mentre da Giorgio Armani ad aprire la sfilata c’è un’altra musa, Gina De Bernardo, volto di storiche campagne degli anni Ottanta e Novanta e anche lei donna armaniana per antonomasia: Armani rimane fedele a sé stesso. E proprio Bianca Censori, con il marito Kanye West, era ospite da Marni: Francesco Risso è tornato a Milano con una collezione intitolata “Bring No Clothes” che non era tanto un invito letterale a presentarsi senza vestiti quanto un’incitazione a liberarsi delle restrizioni degli abiti, a gettare la maschera come nelle intenzioni di Virginia Woolf, alla quale appartiene la citazione: Risso è uno dei pochi che non trova rifugio nel guardaroba, al contrario lo scardina e lo riassembla in capi-archivio che hanno sfilato in «una caverna di carta» ricavata all’interno dei tunnel della stazione Centrale. Ha voluto fare una collezione sunto dei suo primi anni Marco Rambaldi, uno dei pochi marchi indipendenti che ha voluto sfilare (all’appello mancano Cormio, Act N°1 e Andrea Adamo, che hanno scelto la formula della presentazione) e che dimostra, passo per passo, quanto è difficile diventare grandi in quest’industria. Luca Lin di Act N°1 ha presentato invece una collezione concisa e priva di sbavature, una raccolta di personaggi cinematografici che in questo caso beneficiavano del set intimo. Particolarmente riuscita, poi, la seconda prova di Simone Bellotti da Bally, che si è ispirato al folklore svizzero, e in particolare ai racconti di sirene e uomini che popolano le sponde dei laghi dell’Engandina, per costruire una collezione solida e fresca.
Milano ha voluto essere concreta, dicevamo, come d’altra parte è sempre stata (così si è costruita il suo posto nella moda) ma se oggi quell’approccio ci sembra ridondante, poco ispirato o sempre meno rilevante, probabilmente è per molti altri motivi, che non hanno solo a che fare con la sovrabbondanza di bellissimi cappotti, completi finemente cuciti e splendide borse. Probabilmente troviamo tutto così uguale perché il gusto si è globalizzato, perché ci sentiamo viziati e costretti dagli algoritmi e perché la nostalgia, come quella esplosa dopo lo show di Margiela, è una pur sempre una via di fuga, e alla moda chiediamo che ci porti da qualche altra parte.
La moda vive questa contraddizione e mentre i prezzi continuano a salire, gli immaginari diminuiscono: abbiamo già visto tutto oppure non abbiamo più la capacità di apprezzare i dettagli? È vero che la moda dovrebbe anticipare e indirizzare il discorso sullo stile, ma se ci restituisce solidità, sicurezza, comfort, non saremo noi a chiederle tutte queste cose? Non sarà che, più che gli oggetti in sé, in realtà, parliamo solo delle immagini di quegli oggetti e che la moda che vediamo sulle passerelle è diventata un affare che si possono permettere in pochi? Nei tre miseri giorni che è diventata la settimana della moda di Milano, non dovrebbe esserci più spazio per i marchi di nuova generazione, che in sempre maggior numero scelgono di non sfilare e starne fuori? Non potrebbero essere loro a offrire una contro-narrazione che bilancerebbe i grandi marchi e le loro logiche, che sono di tutta l’industria e non solo di chi sfila a Milano? Per valorizzare la grande filiera italiana, e il carattere diffuso della nostra moda che non è mai stata centralizzata come a Parigi, non sarebbe il caso di ripensare certe istituzioni e altrettanti rituali che hanno fatto il loro tempo? Me ne rendo conto, sono grandi domande, ma se non possiamo sfuggire alla realtà guardando le sfilate, almeno cerchiamo di affrontarla.

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.