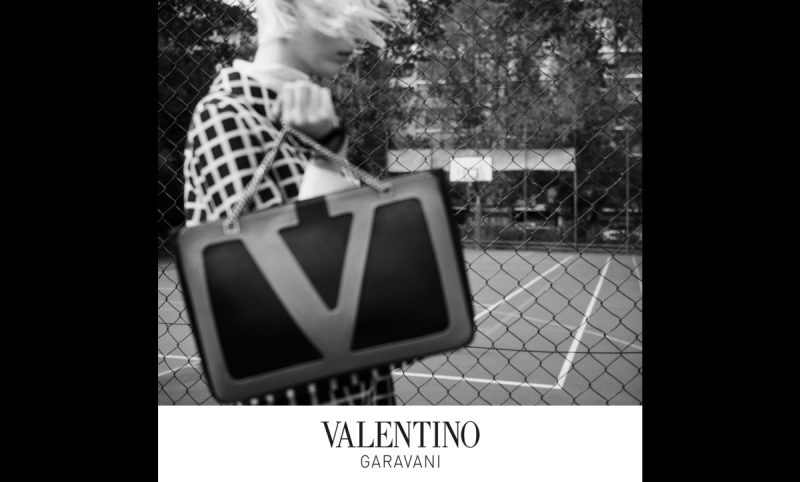L’ultima sfilata Couture di Balenciaga segna – questa volta in maniera definitiva – la fine dell’era Demna. Dieci anni in cui il Direttore creativo georgiano ha scritto la sua parte di storia della moda.
Che senso ha oggi la moda a Milano?
Compressa eppure sempre più invasiva per la città, tra debutti attesissimi e pochi show davvero significativi, questa settimana della moda ha aperto interrogativi fondamentali per la sua sopravvivenza.

Nel backstage dopo la sfilata, Miuccia Prada è tornata a dire una cosa che le abbiamo sentito ripetere spesso nelle interviste degli ultimi anni, una cosa che in realtà è sempre stata centrale nel suo lavoro, e cioè che dovremmo tornare a «parlare di vestiti». La collezione andata in scena, in continuità con quella presentata a giugno (c’era ancora lo slime, questa volta di un tenue rosa come il set), è stata la più convincente da quando Prada ha iniziato la sua «collaborazione senza fine» con Raf Simons nel febbraio del 2020, resa ancora più intensa dal saluto finale a Fabio Zambernardi, Head of Design e intelligentissimo uomo dietro le quinte che lascia il marchio dopo quasi quarant’anni. Quattro decadi, o giù di lì, in cui Zambernardi ha contribuito a rendere Prada quello che è oggi. Ovvero un universo culturale ed estetico dove coesistono la Fondazione Prada, di cui la signora è diventata ufficialmente Direttrice lo scorso 18 settembre, Kylie Jenner e Rosalía in prima fila e la folla per il gruppo coreano Enhypen fuori dalla stessa Fondazione, i mocassini e le borse con il logo triangolare di cui ragazze e ragazzi riempiono le loro whishlist su TikTok ma anche la borsa creata da Mario Prada intorno al 1913, rivisitata eccezionalmente per la Primavera Estate 2024 in pelle e re-nylon.

Prada Primavera Estate 2024. Foto courtesy of Prada
È «una borsa da sera con chiusura a telaio, caratterizzata da un elemento intagliato a mano che ritrae una figura mitologica», spiega la nota stampa che si concentra proprio, e solamente, su quell’oggetto – uno degli «oggetti di lusso» che caratterizzano Prada – ed è accompagnata da una lista che descrive la collezione. I leggerissimi abiti “Haze”, circolati moltissimo sui social in slow motion, realizzati in organza superfine e gazar; le giacche chiuse dal bottone di una camicia (com’era per la collezione maschile, che dalla camicia partiva); i frammenti di abiti in georgette giustapposti ai completi e agli abiti ispirati agli anni Quaranta, decade da sempre cara a Prada, così come si rifanno agli anni Quaranta i tessuti, quelli classici della sartoria inglese ma ri-editati; i dettagli delle borchie, che potrebbero essere anche occhielli passascotte come quelli delle vele; le scarpe in raso di seta e dalla punta quadrata, in colori acidi come il verde e il fucsia: Prada è tutta lì.
Un amico, profondo conoscitore di moda, mi ha scritto su Instagram che ricordava di aver visto la borsa con la testa di satiro nello splendido volume curato da Michael Rock, Pradasphere (Abram Books, 2015), e che mai avrebbe immaginato che sarebbe potuta tornare in passerella. E invece Prada lo ha fatto: Pradashpere era d’altra parte una raccolta di oggetti d’archivio che servivano a entrare nell’eclettico mondo del marchio. Riprendere una borsa dei primi del Novecento è un atto culturale forte, perché riesce nell’impresa di colpire sia gli appassionati che di Prada sanno tutto («Vorrei regalare quella borsa a mia madre», ha scritto il mio amico) sia l’attenzione dei social media che vivono di brevi momenti di viralità. È la dimostrazione, spogliata da qualsivoglia appiccicoso storytelling, di una consapevolezza del proprio archivio che oggi tutti i marchi aspirano ad avere.
Gli oggetti di lusso, e più in generale il significato stesso di lusso, sono stati d’altra parte il fulcro delle collezioni viste in questi giorni: insieme al tanto raccontato ritorno del sesso in passerella, direzione prevedibile nel post Covid, i grandi brand cercano oggi sempre più di ancorarsi agli essenziali della loro storia per affrontare mercati difficili e scenari incerti. Negli ultimi due anni quel concetto è stato riassunto dall’assurdo trend del “quiet luxury” su TikTok (ovvero del lusso non gridato, senza troppi loghi, fatto di capi chiave), spinto nelle sue tante declinazioni dai racconti sulla ricchezza che hanno attraversato la cultura pop, da Succession a White Lotus, da The Triangle of Sadness a Parasite. «Forse le persone diranno che questo tipo di moda è noiosa, ma non per me. Forse non riescono ad apprezzare i dettagli in passerella. Onestamente, non mi interessa molto», ha detto Sabato De Sarno in un’intervista a Cathy Horyn su The Cut, parlando di Gucci e non del quiet luxury, «Non voglio impressionare, voglio fare quello che mi piace». Quello di De Sarno, alla sua prima volta da Direttore creativo, era lo show più atteso di questa stagione. Arrivare dopo Alessandro Michele, che nei suoi sette anni ha rimesso Gucci al centro del desiderio collettivo, era già difficile di per sé, e farlo nelle condizioni dell’industria di oggi ha complicato ulteriormente le cose.

Gucci Primavera Estate 2024. Foto courtesy of Gucci
Quella “brand fatigue” che Gucci ha accusato negli ultimi anni dopo gli inizi brillantissimi è infatti un affare che non può risolversi in una collezione di debutto. Ci si è messa anche la pioggia, per cui uno show pensato per svolgersi in via Brera alla fine si è tenuto in un cubo nero all’interno dell’hub del marchio in via Mecenate. “Gucci Ancora”, si intitolava la collezione, una parola su cui critici e commentatori social si sono parecchio accapigliati in questi giorni e che è comparsa anche in giganteschi manifesti nelle più grandi città del mondo prima dello show. Era un riferimento all’«ancora, ancora, ancora» di Mina e a quell’italianità del vestire bene, del glamour pragmatico che storicamente ha caratterizzato la nostra moda e il nostro lifestyle. Un concetto che De Sarno ha voluto rendere con una collezione ripulita da tutti gli eccessi, dove il decorativismo esplodeva misurato negli accessori, la Jackie in primis, e nei dettagli di abiti, top e cappotti: era un guardaroba contemporaneo che parlava alle ragazze di oggi, le stesse che appunto compilano le wishlist su TikTok. De Sarno, che ha passato gli ultimi quattordici anni da Valentino e di certo sa come si costruisce una collezione, ha messo le basi del nuovo corso del brand e, probabilmente, le critiche di questi giorni si possono spiegare di fronte allo scollamento tra il racconto e la collezione stessa, che non sono sembrati coerenti. Nel 2023, Gucci non è il luogo dove accadono le rivoluzioni ma quello in cui si devono affrontare le grandi contraddizioni della moda di oggi: l’invito a far parte di una nuova famiglia, come si legge nella nota stampa voluta da De Sarno, le celebrity che si mescolano agli addetti ai lavori al party dopo la sfilata perché il marchio non ha voluto privé, la capacità di fare cultura di quel marchio, la genuinità festosa di un appena quarantenne italiano all’occasione della vita e la solidità commerciale di una collezione che deve arrivare a tutti, ma allo stesso tempo innalzare il marchio dai trend del momento e posizionarlo altrove.
Una soluzione sembra averla trovata, in questo preciso momento, Matthieu Blazy da Bottega Veneta, che dopo il viaggio in Italia delle prime tre collezioni, ha scelto ora di spostare lo sguardo sul mondo con la sua collezione migliore da quando è arrivato alla direzione creativa. Il punto di vista privilegiato di Bottega Veneta, che sembra avere la strada spianata verso quello status da “unicorno” della moda pur rispondendo alle logiche del grande gruppo in cui si trova, è oggi un miraggio. La «visione globale dell’artigianalità» per la Primavera Estate 2024 si dipana allora come uno studio che va dall’estremamente portabile, ed estremamente prezioso, all’estremamente ricercato, in un crescendo in cui la creatività si intreccia, letteralmente, alla migliore fra le manifatture artigianali. «This is a house, not a brand», ha detto Blazy a Vanessa Friedman in una bella intervista uscita sul New York Times qualche giorno prima della sfilata, ed è un’affermazione non da poco. La complessità degli ultimi look che hanno sfilato sabato sera aveva quasi il sapore di una couture quotidiana, quella che immaginiamo addosso agli ultraricchi dei quali negli ultimi anni consumiamo con inedito interesse i racconti sul grande e piccolo schermo e nei libri, un guardaroba ideale che racchiude ed evolve l’idea di lusso contemporaneo. Blazy sembra ora completamente a suo agio nel mondo di Bottega Veneta e il percorso iniziato con saggia prudenza poco più di un anno fa è più solido che mai in tutte le sue diramazioni, che abbracciano natura ed esseri umani, luoghi lontani fra loro e materialità diverse, finendo poi per confluire in quello di cui parlavamo all’inizio di questo lungo pezzo: i vestiti.

Bottega Veneta Primavera Estate 2024. Foto courtesy of Bottega Veneta
In questa settimana della moda, c’è stato però molto altro oltre ai tre casi qui analizzati, a cominciare dal complicato rapporto con la città. In un calendario sempre più compresso (solo tre giorni con slot assassini che non permettono agli addetti ai lavori di assistere a tutti gli eventi per ragioni meramente logistiche), Milano sembra oggi incapace di allargare la sua “fashion week” a visioni alternative, spingendo i nuovi marchi o a ritirarsi e scegliere altre piattaforme (come ha fatto Vitelli) o a sfilare schiacciati dall’imminenza dei grossi brand (com’è successo ad Act N1), né sembra in grado di strutturare un’offerta culturale che la moda la completi e la valorizzi e, non da ultimo, di coinvolgere i cittadini che allo spettacolo della moda, o presupposto tale, assistono da fuori. Tra le iniziative pop-up (come quella di Prada, che regalava i semi dei fiori della campagna per l’Autunno Inverno 2023, e quella di Emporio Armani, che invece regalava una tote-bag in collaborazione con Forestami), due mostre (Wes Anderson in Fondazione Prada e Luigi & Iango a Palazzo Reale) che nessuno ha avuto il tempo di visitare a dovere, l’unico evento culturale di rilievo è stata Fashion Issues, la rassegna curata dalla giornalista del New York Magazine Cathy Horyn in Triennale, anche questa fuori dal calendario ufficiale.
Alla fine del primo giorno, Diesel ha sfilato sotto il diluvio in uno stadio ricostruito presso lo Scalo Farini, evento aperto al pubblico a cui hanno partecipato migliaia di persone che si erano registrate sul sito: Glenn Martens ha scelto, consapevolmente, di portare il suo marchio direttamente tra i suoi potenziali clienti, fregandosene della stampa e del rito della sfilata in sé. Anche Sunnei continua a prendersi gioco di quel rito con lucida ironia, questa volta facendo votare il pubblico, tramite apposite – visibilissime – palette bianche, i trenta look della collezione. «Non pensare, segui il tuo istinto» diceva una voce maschile registrata agli ospiti, facendo appello a quella parte di noi che sempre più spesso trova sfogo sui social e vive della gratificazione immediata dei like e di un immaginario consenso, che non è reale. La collezione era un compendio Sunnei e funzionava benissimo, tanto più con lo sfottò confezionato ad arte da Simone Rizzo e Loris Messina. Dagli ottimi debutti, come quello di Simone Bellotti da Bally, alle piacevoli riconferme, come Maximilian Davis da Ferragamo e Lucie e Luke Meier da Jil Sander, fino ai bellissimi addii, come quello di Walter Chiapponi da Tod’s, questi pochi giorni di moda a Milano sono però sembrati convulsi, insufficienti, fuori fuoco. Siamo diventati davvero troppo vecchi, come ha scritto il Wall Street Journal? Forse, o magari non abbiamo ancora capito che anche per parlare di vestiti serve tempo.

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.