Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.
I conti che non abbiamo fatto con la violenza coloniale italiana
Esce una nuova edizione di Tempo di uccidere di Ennio Flaiano: può essere l'occasione per ripensare al nostro passato razzista?

Il primo confronto che ebbi con un cittadino etiope a proposito del colonialismo italiano in Africa orientale, nel dicembre del 2017, mi lasciò sorpreso e interdetto. Mi trovavo ad Addis Abeba, nel quartiere di Piazza, la vecchia zona italiana un tempo dedicata soltanto ai colonizzatori, e oggi invece molto poco frequentata da turisti e visitatori, in generale, non etiopi. Non c’è niente di particolarmente interessante, in effetti: è un quartiere residenziale, con molti bar piccoli e senza fronzoli, alcuni ristoranti, uffici, e un’ottima pasticceria, forse la migliore della città, fondata negli anni dell’occupazione e per cui molti cittadini di Addis Abeba fin dalla mattina si mettono in coda sul marciapiede: Enrico’s Pastry. L’uomo, che mostrava di saper maneggiare alcune parole di italiano, aveva detto qualcosa a proposito dell’amicizia tra italiani ed etiopi. Per mostrarmi retto, davanti all’uomo e alla mia coscienza, risposi che il colonialismo italiano era stato, come tutti i colonialismi, in primis violazione di diritti umani, sterminî, crudeltà diffuse e razzismo. Stavo, mi resi conto soltanto dopo, spiegando il colonialismo a chi, un tempo, l’aveva subito, ma mi sembrava che la mia coscienza potesse così rimanere relativamente pulita. Il senso di colpa, e via dicendo. L’uomo, ridendo, sdrammatizzò la mia liturgia senza ascoltarmi: ma non ci avete mai conquistato, disse più o meno, vi abbiamo cacciato subito via!
La battuta dell’uomo indicava alcune cose a proposito del rapporto tra Italia ed Etiopia. Lungi dallo sminuire i crimini coloniali, sottolineava l’orgoglio di una nazione che mai si piegò interamente al giogo coloniale, e fu un impero – il più longevo del continente, e non soltanto – dal 1137 fino al 1974. L’annessione all’Africa Orientale Italiana durata cinque anni – tra il 1936 e il 1941 – fu, in quest’ottica, poco più di una mosca, in termini di proporzioni, sul manto del leone imperiale etiope. Eppure, nonostante questo orgoglio, la presenza italiana non fu senza conseguenze. Anzi, proprio per il fatto di trovarsi davanti un esercito preparato e perfettamente in grado di respingere quello italiano, la strategia fascista (al comando di Badoglio) impiegò già nel 1935 diverse tonnellate di bombe caricate a gas. L’Etiopia, poi, non fu mai del tutto pacificata – e quindi, in un certo senso, conquistata: la resistenza contro l’invasore italiano non venne mai domata, e continuò a combattere, spesso con successo, una guerriglia sfiancante. Il proclama di Mussolini di Palazzo Venezia («Il popolo italiano ha creato col suo sangue l’impero, lo feconderà col suo lavoro e lo difenderà con le sue armi»), dopo tutto, conteneva tre bugie su tre affermazioni: l’Italia creò un impero violando le convenzioni di Ginevra del 1925, non lo fecondò con il suo lavoro ma, al contrario, creò un rigido sistema di apartheid razziale che non ebbe altro risultato che quello di inimicare completamente la popolazione locale, e non riuscì mai neppure a difenderlo, venendo sconfitta già nel 1941.
Tutto questo, fin dal primissimo Dopoguerra, venne rimosso dalla memoria italiana: l’occupazione dell’Africa orientale, così come l’invasione greca e quella albanese, vennero derubricate ad azioni di una nazione gentile, non spietata come gli altri Paesi europei che avrebbero, di lì a pochi anni, avuto a che fare con il violento processo di decolonizzazione. Gli italiani erano brava gente e, considerato che la ricerca di “un posto al sole” risaliva a un fascismo all’epoca condiviso anche da diversi antifascisti di dopo, venne insabbiato senza troppi problemi. Il primo libro a vincere il Premio Strega, nel 1947, fu tuttavia, curiosamente, un romanzo ambientato proprio all’epoca dell’invasione d’Etiopia, nel 1936. Tempo di uccidere fu l’unico romanzo di Ennio Flaiano, uscito all’epoca per Longanesi e ripubblicato, a ottobre 2020, da Adelphi.
Non fu, in realtà, così grande e condivisa la fortuna iniziale del libro: vinse sì il primo Strega, ma non venne, per lungo tempo, considerato un vero romanzo “coloniale”. Eppure, nella trama, un ufficiale italiano, al primo anno di guerra o meglio invasione, incontra una donna etiope in un luogo appartato, la violenta e, forse casualmente, la uccide. Inizia, così, la sua fuga dal senso di colpa e da se stesso, dall’autorità italiana – il soldato, in preda al panico e al delirio, si convincerà di essersi ammalato di lebbra, infettato dalla donna stessa, diserterà, e tenterà altri omicidi e rapine anche ai danni dei suoi connazionali – fino a un finale di guarigione simbolica. Negli anni del neorealismo, Flaiano scrisse un delirio onirico e ossessivo, talvolta accostato al Cuore di tenebra di Conrad, ma alcuni critici dell’epoca interpretarono lo sfondo coloniale come uno dei molti palcoscenici possibili per un dramma, in realtà, soltanto esistenzialista.
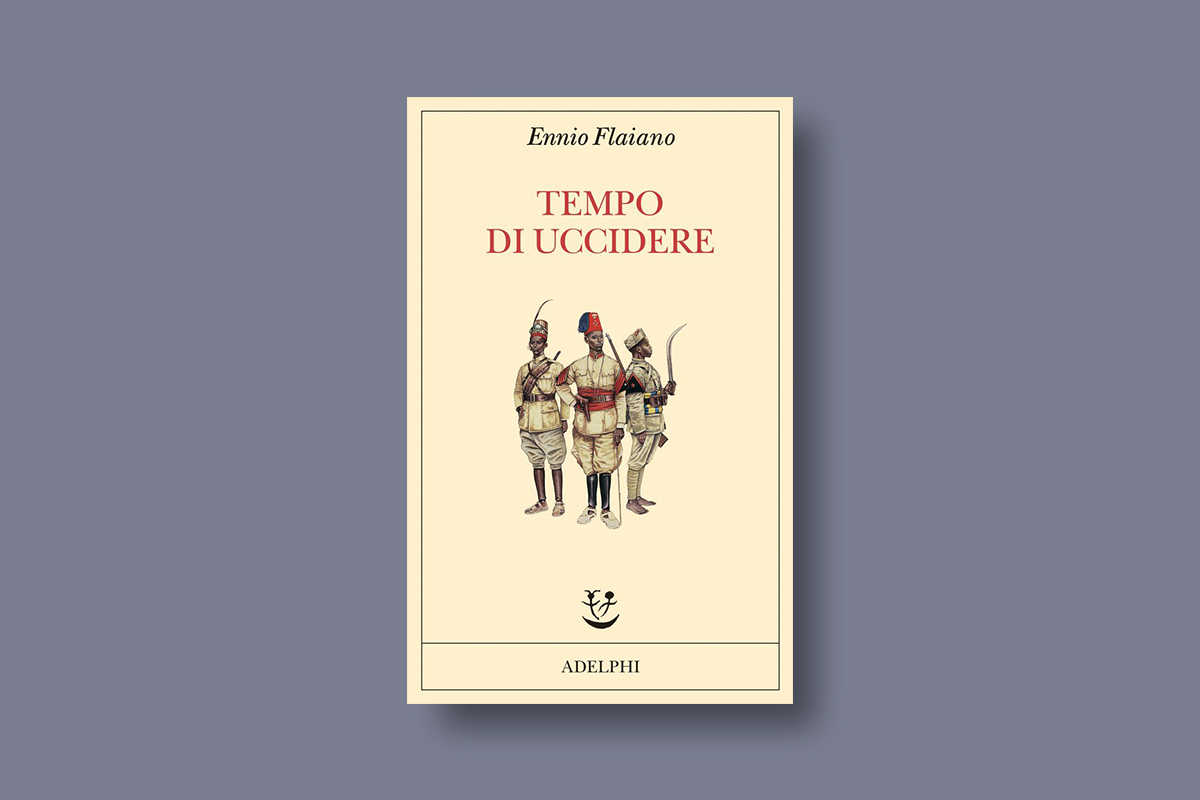
Flaiano, è vero, mantiene delle ambiguità: lo stupro iniziale, da diversi lettori, è stato percepito come un rapporto consenziente, o quasi, e la poca considerazione per i personaggi abissini è lampante. Ma questo accade soltanto quando si compie l’errore di sovrapporre l’autore con il narratore. Per questo, anche, l’edizione Adelphi appena uscita è corredata da un taccuino tenuto da Flaiano stesso, una specie di raccoglitore di appunti per il romanzo futuro, osservazioni da soldato coloniale, prima che la letteratura ci mettesse il suo zampino. È evidente come Ennio Flaiano, giovanissimo (24 anni!) e gettato dal regime in una guerra che, secondo le sue parole, lo portò a «desiderare che la cosa finisse, brutalmente, nella sconfitta», non condividesse affatto la voce del protagonista di Tempo di uccidere. È vero: la sua prosa non è mai quella della denuncia aperta, ma negli appunti, poi raccolti e chiamati appunto Aethiopia. Appunti per una canzonetta, lo scrittore mette in scena, in modo elegante e crudo, le stragi e le violenze a cui è costretto ad assistere: sono descritti freddamente, come sapendo che l’interpretazione che se ne può, e soprattutto potrà, dare, è una sola, sgomenta: «Una donna, la più avvenente, viene posseduta in circolo e poi nel suo sesso è introdotto un tizzone», scrive in una parte di racconto, a titolo di esempio, del 7 marzo 1936. Poco più avanti, si procede a bruciare la massa di cadaveri degli etiopi trucidati (in una chiesa), e una donna che si è nascosta in una cassa di legno, «una povera malata», viene gettata nelle fiamme. Un soldato, in un barlume di pietà, urla: «Ma è viva!», ma l’altro – e qui si riconosce il Flaiano più famoso, degli scritti brevi – risponde: «No, signor capitano, è quasi morta».
Scene come questa, nel libro vero e proprio, non si trovano, e ci mettiamo infatti del tempo ad accorgerci che – e a volta ce ne dimentichiamo – nelle avventure di Tempo di uccidere gli italiani stanno combattendo una guerra d’invasione, e che la terra che stanno calpestando, in cui costruiscono ponti e accampamenti, non è la loro. La insultano, la disprezzano come se fosse una cosa scontata, anzi, come fanno i padroni con le cose che ritengono loro. Fa invece emergere, Flaiano, un suo sguardo ironico in cui l’oggetto dell’ironia non è l’Etiopia, ma “l’impresa” coloniale italiana e il suo modo di guardare all’Africa. In frasi come: «Di autocarri che si ribaltano è piena l’Africa», in luoghi comuni reiterati come quando descrive un camaleonte «onestamente spaventato da quell’Africa piena di insidie», o le mappe dell’altopiano messe a disposizione dei soldati, in cui «tutto era estremamente sommario» e il cartografo, «incapace di licenziare una tavola con tanti vuoti, vi aveva aggiunto a capriccio brevi frasi: Residenza eventuale di pastori, oppure: Qui si incontrano molti struzzi».

Rodolfo Graziani, al centro osserva Adolf Hitler ed Emilio De Bono, il generale che precedette Badoglio nell’invasione etiope, a Roma nel 1938 (Hulton Archive/Getty Images)
Dopo il libro di Flaiano, per anni, anzi, per decenni, il colonialismo italiano in Africa (sia quella orientale sia quella settentrionale, vale a dire la Libia) fu chiuso in una scatola e accuratamente nascosto in un armadio. Rodolfo Graziani, che fu viceré d’Etiopia e responsabile, tra i diversi crimini, del Massacro di Addis Abeba in cui furono ammazzati, secondo diverse fonti, tra i 10mila e i 30mila etiopi, fu dopotutto nominato presidente onorario del Movimento Sociale Italiano già nel 1953, e ancora nel 2012 ad Affile, comune laziale in cui visse alcuni anni, fu realizzato su iniziativa del sindaco un sacrario in onore del criminale di guerra e firmatario del Manifesto della razza.
La letteratura, negli ultimi anni, si è mossa: sono stati pubblicati romanzi di autori e autrici italiani e afroitaliani che esplorano con diversi punti di vista l’occupazione: come Regina di fiori e di perle, di Gabriella Gheramandi (Donzelli), Timira di Wu Ming 2 e Antar Mohamed (Einaudi Stile Libero), I fantasmi dell’Impero di Marco Cosentino, Domenico Dodaro e Luigi Panella (Sellerio), Narciso nelle colonie di Vincenzo Latronico (Humboldt), e diversi titoli di Igiaba Scego, come Roma Negata e Adua. Si è mosso qualcosa anche nel cinema, anche se le produzioni sono sempre rimaste piccole, se guardiamo l’esempio del bellissimo documentario Asmarina, di Alan Maglio e Medhin Paolos, che racconta la comunità eritrea Habesha di Milano. Ma, nel vastissimo resto, la situazione dei conti italiani con il suo passato coloniale, e con il razzismo che ne era alla base, è drammatico.
Pensiamo, in Italia, di poter essere sullo stesso piano di nazioni e opinioni pubbliche (estere) che mettono in discussione la figura di Cristoforo Colombo e il conseguente Columbus Day, che finalmente rimuovono statue equestri e celebrative di militari che combattevano per la schiavitù come diritto fondamentale dell’uomo bianco, che parlano apertamente, anche tramite i più influenti tra i loro politici, del razzismo sistemico delle forze di polizia. Pensiamo di far parte dello stesso campionato, ma non è così.

I cadaveri di due uomini etiopi ad Addis Abeba durante l’occupazione italiana. Le caviglie legate a una corda indicano che siano stati trascinati lungo le strade (Keystone/Getty Images)
Siamo, invece, la nazione in cui giornalisti che si riterrebbero anche progressisti si indignano se un ex fascista, poi diventato giornalista e fondatore di un quotidiano, viene descritto come (anche) un razzista stupratore dei suoi tempi, nonostante questo giornalista avesse effettivamente acquistato una ragazzina 14enne africana, rivendicando più volte la compravendita e l’unione con quell’«animalino docile», come la descrisse anni dopo. Siamo anche la nazione in cui un senatore della Repubblica, vicepresidente del Senato, paragona a un orango un ministro del Governo, senza che immediatamente perda la faccia, ancora prima che il posto. Siamo poi la nazione in cui proprio un ministro, in questo caso quello degli Esteri, pubblica sui suoi canali social diverse battute sulla sua abbronzatura e fotografie in cui compare il blackface, senza che né lui, né diversi commentatori, lo trovino un problema. Sono soltanto tre casi di cui si è discusso un po’ di più, negli ultimi anni, ma, a modo loro, si sono risolti tutti in grandi buchi nell’acqua, dal punto di vista delle opportunità: Indro Montanelli continua a essere celebrato come decano dei giornalisti italiani, come se questo talento professionale non lo rendesse capace di atti riconducibili al razzismo fascista; il partito in cui milita Roberto Calderoli si è, se possibile, spostato ancora più a destra, abbracciando posizioni spesso apertamente razziste; il ministro Di Maio è ancora ministro, e il Partito Democratico, un tempo il più grande partito di centrosinistra in Europa, sostiene il governo di cui fa parte. I programmi delle scuole superiori, d’altra parte, non parlano mai di colonialismo italiano: l’Italia è esplicitamente citata nello studio dei movimenti del 1848, nella nascita dello Stato, nella formazione della Repubblica, ma non compare mai con un proprio focus nello studio generale di tutti i “colonialismi”. È difficile creare una coscienza storica, se le scuole stesse si disinteressano dell’argomento.
Ad Addis Abeba il culto di Hailé Selassié è ancora forte. Il suo palazzo sorge in quella che è, oggi, l’università cittadina, e che negli anni dell’occupazione fu trasformata nel governo militare italiano. È qui che ebbe luogo l’attentato a Graziani per cui l’ex presidente onorario del Msi fece uccidere decine di migliaia di etiopi in rappresaglia. È qui che sorge ancora un curioso monumento voluto dal governo fascista: una scala a chiocciola di cemento che si arrota su se stessa, in cui ogni gradino sta a indicare un anno passato dalla creazione dell’Era Fascista, nel 1922. Sull’ultimo gradino gli etiopi, una volta cacciati gli italiani, hanno posto la statua di un leone, simbolo dell’Impero etiope, come per sorvegliare sulla fine della scalata coloniale. In Italia, spesso, sembra che nessun leone abbia mai posto fine alla crescita di quella scala: che un libro del 1947 sia ancora una delle voci anticoloniali più forti ne è un segno evidente.
Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.



