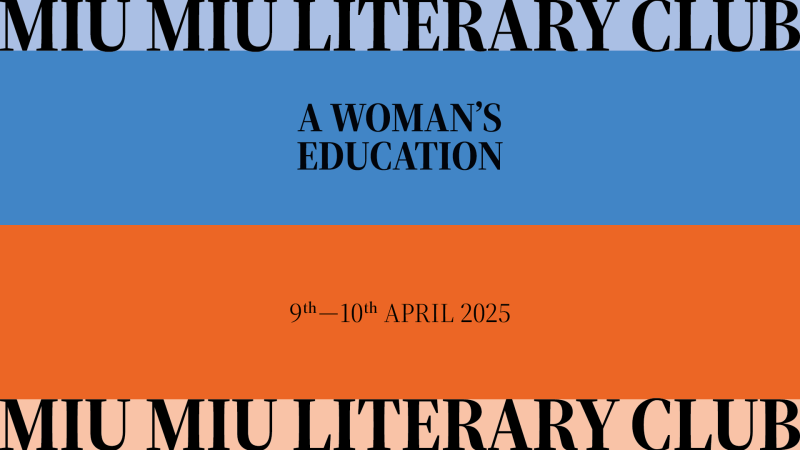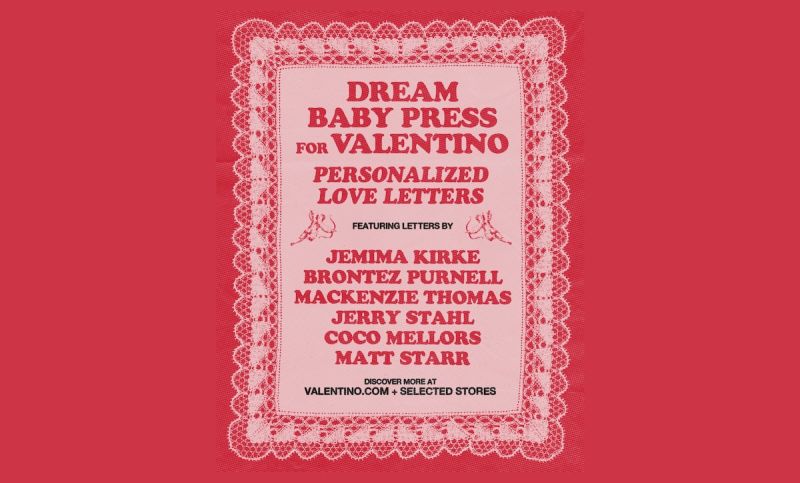Il fast fashion durante l’emergenza Coronavirus
L’impatto della crisi colpisce duramente i Paesi produttori come il Bangladesh, la Cambogia e il Vietnam, ma anche l’Italia.

Mentre le quarantene si allungano e il dibattito tra i comitati scientifici, le associazioni di categoria e i governi alle prese con l’emergenza Coronavirus si focalizza sui temi della riapertura – quando avverrà, come avverrà – diventano sempre più evidenti gli effetti della crisi su molti settori. In Italia ci preoccupiamo della filiera produttiva del lusso e delle soluzioni per tutelarla, ma intanto diventano sempre più evidenti i problemi del fast fashion. Che il modello stia attraversando una fase di profondo ripensamento è chiaro da anni – soprattutto a causa di un cambiamento sensibile nelle abitudini di consumo e all’imporsi del problema etico e ambientale legato alla produzione dei vestiti a basso costo –, ma a preoccupare oggi sono soprattuto gli effetti economici e sociali dello stop delle attività in alcune parti del mondo, ma anche in Italia.
Basta pensare al caso del Bangladesh che, come riporta il New York Times, «è stato il luogo dove è avvenuta una delle campagne più efficaci dell’era globalizzata per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori dell’abbigliamento, e che ha visto oltre 2,8 miliardi di dollari di ordini annullati o rinviati dall’inizio della crisi del Coronavirus. I capi confezionati rappresentano circa l’84 per cento delle esportazioni totali del Paese, per un valore di 40,5 miliardi di dollari nel 2019, secondo i dati pubblicati sul sito web della Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), che rappresenta i produttori tessili». Questa perdita mette perciò a rischio l’occupazione di circa due milioni di lavoratori impiegati nel settore, che sono, lì come in Cambogia e Vietnam, perlopiù donne. I problemi sono iniziati a febbraio, quando è diventato difficile reperire i materiali grezzi dalla Cina, che è il più grande esportatore di tessuti al mondo, a causa della chiusura delle fabbriche. Quando le fabbriche cinesi hanno iniziato a riaprire, il virus era già arrivato dall’altra parte dell’emisfero e a quel punto i produttori tessili hanno dovuto fronteggiare il crollo della domanda da parte dei marchi occidentali, via via che i negozi venivano chiusi per il contenimento dei contagi. «La nostra situazione è apocalittica», ha detto senza giri di parole la presidentessa della BGMEA Rubana Huq al Nyt.
Questo perché, segnala anche un approfondimento della Bbc, la produzione di abbigliamento è un settore cruciale per molte delle economie in via di sviluppo dell’Asia e, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale del commercio, il Bangladesh (con il 6,7 per cento) e il Vietnam (5,7 per cento) sono tra i quattro maggiori esportatori mondiali di abiti. Il governo del Bangladesh ha già messo in campo un generoso pacchetto di incentivi per cercare di non intaccare i salari e proteggere il settore, ma è la risposta dei marchi a preoccupare: in molti hanno richiesto un dilazionamento dei pagamenti su ordini già confezionati o in fase di lavorazione oppure ancora stanno cercando di contrattare sul prezzo, ovviamente al ribasso. Lo scorso 30 marzo, H&M – che ha già registrato un calo del 46 per cento nei ricavi – ha annunciato che avrebbe ritirato e pagato come da dovuto le merci già fabbricate e quelle attualmente in produzione, aggiungendo che non avrebbe rinegoziato i prezzi degli ordini già effettuati. Allo stesso tempo, però, il colosso svedese ha già messo in conto un taglio ai posti di lavoro, considerando che i due terzi dei suoi 5000 negozi nel mondo sono attualmente chiusi, minacciando anche un’interruzione prematura dei contratti di locazione qualora le vendite non si riprendessero. Gli stessi impegni sono stati presi dal gruppo Inditex (Zara), PVC (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) e Marks & Spencer, ma c’è anche chi, come Primark, con i negozi chiusi e un e-commerce ancora debole, ha già stoppato tutti i futuri ordini.
Il Sole 24 Ore, intanto, segnala la pesante situazione che affronta il Centergross di Bologna, il più importante polo italiano del fast fashion che rappresenta oltre 400 aziende (tra cui Teddy, Imperial, Kaos e i marchi Kontatto e Susy Mix), dove «dopo due settimane di chiusura forzata e le due precedenti al ralenti per le saracinesche abbassate nei negozi, la cittadella emiliana rischia il tracollo e con lei la gran parte dei brand che danno lavoro a seimila lavoratori diretti, senza contare le filiere». Il Centergross è il più grande distretto europeo della moda ed in attività da oltre quarant’anni, si compone principalmente di aziende medie e piccole strettamente legate fra loro che «assieme fatturano ogni anno 5 miliardi di euro, ma singolarmente hanno le spalle piccole e rischiano di non uscire vive da questo stop produttivo se sarà prolungato con il prossimo decreto. E con loro rischiano di chiudere definitivamente anche gli artigiani a monte e i commercianti a valle», come spiega il presidente di Centergross Piero Scandellari.
Dana Thomas, autrice di Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes, in un’intervista a Gq Us ha paragonato il settore a «un castello di carte che sta collassando violentemente», all’interno del quale non si è mai pensato che potesse arrivare qualcosa, come l’11 settembre o l’epidemia di Sars che pure sono crisi recentissime, che ci avrebbe impedito o fatto smettere di comprare. La preoccupazione dell’esperta si estende anche al dopo, quando la produzione ripartirà: dopo gli ordini cancellati e lo smaltimento del magazzino, i marchi torneranno a chiedere nuovi abiti, e in fretta, e a quel punto i lavoratori di molte parti del mondo, che spesso non dispongono di assicurazione sanitaria, congedo di maternità o ferie, torneranno ugualmente nelle factory. «Il problema fondamentale è il modello», ha detto a Business of Fashion Scott Nova, direttore esecutivo del Worker Rights Consortium (WRC), un’organizzazione indipendente di monitoraggio dei diritti dei lavoratori che conduce indagini sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche di tutto il mondo. Il WRC, per ora, ha invitato i marchi a recedere dai contratti in modo responsabile e a garantire che i fornitori paghino i benefici cui sono legalmente obbligati ai lavoratori sospesi o licenziati, mentre si cerca di mettere in atto sistemi di protezione sociale per il futuro. La strada verso il cambiamento, però, è ancora lunga.