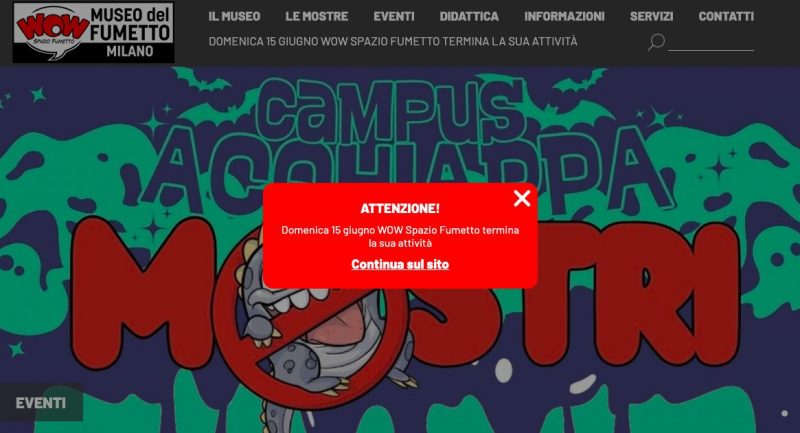La città "provinciale" che si legge negli strilli dei quotidiani locali e quella internazionale e kitsch raffigurata nei souvenir turistici. Per capire davvero Venezia bisogna fermarsi davanti alle sue edicole.
L’estate in città per guardare i palazzi vuoti
Una passeggiata in quel che resta della Milano del Novecento, quando la città era ancora un grande paese di campagna, con le sue zone popolari e i suoi recinti borghesi.

«D’estate, come i cinema, io chiudo». Inizia così una delle mie poesie preferite, di Valerio Magrelli. I cinema, in realtà, è da un po’ che non chiudono d’estate, perché i centri delle città si svuotano sempre meno, rispetto agli anni Ottanta e Novanta. Si può dire che chiudano però le città, nei giorni centrali di agosto, nei fine settimana di luglio: smettono di fare tutto quello che fanno durante l’anno, il lavoro, la frenesia, il divertimento, la vita serale e notturna. Si fossilizzano in un letargo caldissimo per cui, nei quartieri più residenziali e meno turistici, si può sperimentale un’immobilità e un silenzio di campagna. Non parlo di tutte le città, e non parlo di tutti i quartieri: ma della città che conosco meglio, Milano, e di quei quartieri in cui l’architettura e l’urbanistica sono ancora legate ai primi del Novecento, quando questa metropoli contemporanea era più che altro un grande paese di campagna, con le sue zone popolari e i suoi recinti borghesi.
Milano è cambiata drasticamente negli ultimi quindici anni, e l’ha fatto con una velocità e un impatto che, azzarderei, non si erano mai visti prima. C’entra la facilità con cui si possono costruire questi palazzi che diventano quartieri e si alzano nell’orizzonte un tempo vuoto: vetro e acciaio, un poco di cemento. I grattacieli che chiamiamo non con il nome dell’architetto ma con quello del committente che ha pagato i lavori o la sponsorizzazione: Unicredit, Generali, Unipol, Intesa Sanpaolo. Trovo che l’identità architettonica di Milano, quella che definisce però il suo carattere, stia in altre costruzioni, di dimensioni ben più modeste, non per forza più dimesse, sicuramente più nascoste, discrete, eleganti. D’estate, quando Milano “chiude”, mi piace passeggiare, a piedi o in bicicletta, tra questi vecchi palazzi e palazzini. Mi sembra che siano addormentati, e io mi avvicino al guanciale e li guardo, affascinato.
Milano non è una città di bellezza immediata, come si è detto e scritto: non ha grandi chiese e rovine come Roma, né vicoli romantici come quelle portuali, e nemmeno possiede l’aiuto della meraviglia naturale di Venezia o Amsterdam. È una città residenziale. È una città di facciate (è vero che anche Roma lo è, ma Roma sa essere praticamente tutto, in un certo suo modo), la sua bellezza è nei palazzi, nelle finestre, nelle architravi, nei portoni e nei cancelli.
Nei giorni caldi e solitari di agosto, allora, ma anche nei fine settimana di giugno e luglio, quando mezza città ripara ai laghi, al mare o in montagna, io mi addentro nelle vie più silenziose e nascoste, quelle esclusivamente residenziali, a cercare case e facciate. Non sono itinerari di zone soltanto aristocratiche, anche se quasi sempre si respira un’aria da borghesia antica, una certa cura per la qualità, per le maniere, per oggetti e tessuti. «Anche quando vado nelle altre città l’unica cosa che mi piace fare è guardare le case», dice Nanni Moretti in quella famosa scena di Caro Diario dedicata ai quartieri di Roma, mentre gira in Vespa con “Didi” di Khaled in sottofondo. Anche a me.
La parte meno moderna di queste passeggiate passa dalle vie di zona Conciliazione. In questi quartieri la foodification non è arrivata, e i locali commerciali sono veramente parte del quartiere: colorifici, lavanderie, piccole officine meccaniche, un’erboristeria, quei vecchi ristorante che si ostinano a usare le tovaglie bianche. C’è la casa che comprò Silvio Berlusconi negli anni Settanta, stanno facendoci dei lavori in corso da diversi anni. Le siepi nascondono a volte ricchi giardini, a volte piani terra in cui immagino stanze ombrose e fresche, pavimenti di graniglia. Spesso sui muri si arrampicano viti canadesi. Via Pietro Tamburini è la mia preferita: una palazzina è interamente decorata di un mosaico azzurro e oro, si chiama Villino Maria Luisa, è del 1906. Poi Villa Falck, disegnata da Mino Fiocchi nel 1938, tutta grigia ed elegante come se fosse vestita di un tailleur di pietra. Un agosto, qualche anno fa, sono passato in vai Tamburini e l’ho trovata stranamente affollata: in mezzo alla strada c’erano decine di lavoratori di quelle case, giardinieri o cuochi o altro personale “di servizio”, che chiacchieravano all’ombra, finalmente senza i proprietari lontani in vacanza, con i piccoli cani tutti insieme al guinzaglio.
Più a nord scelgo certi quartieri di palazzine non firmate: dalle parti di piazzale Indipendenza pedalo tra i marmi delle portinerie di via Vivaio, le tende che si muovono dalle portefinestre aperte su via Archimede. Non c’è una bellezza immediata in queste strade, ma balconi ricchi di gelsomini e glicine, talvolta edifici popolari che si alternano ai palazzi borghesi. Nelle piccole vie intorno a Villa Necchi Campiglio i palazzi si fanno più barocchi, i loro caratteri più decisi. Questa è invece una Milano fortemente aristocratica, in via Serbelloni un palazzo degli anni Venti di Aldo Andreani ha una complessa forma poligonale, e accanto al portone si trova un grosso orecchio incastonato nel muro per “ascoltare la città”. Villa Zanoletti, all’angolo con via Mozart, è interamente ricoperta, d’estate, di vite canadese, come una piramide Maya su cui si sono accumulati i secoli.
Mentre cammino con la testa all’insù faccio giochi di immaginazione e mi creo delle piccole scene di interni. Prendo le eco dei dialoghi dei romanzi di Bassani, Cassola, Ginzburg e Montefoschi e le ambiento in questi interni che a loro volta mi immagino. Non penso a quanto possano essere stronzi i proprietari attuali con i loro Suv, i loro arredi moderni che hanno sostituito le vecchie librerie su misura, i loro specchi Ultrafragola comprati perché vanno di moda. Idealizzo, invece, e cerco un’armonia tra l’architettura e le vite che vorrei l’abitassero. Vorrei poterci entrare a passeggiare, in quei saloni con tre accessi al balcone: una mia amica anni fa prenotava delle visite a queste case cercando quelle in lista solo per poterle vedere, io non riesco perché non so mentire e penso che si vedrebbe troppo che sono lì solo per abbeverarmi di spazi enormi, disimpegni, bagni di marmo, armadi seicenteschi, ritratti di antenati. Mi immagino che sarebbe meglio se gli inquilini se li scegliessero i palazzi stessi improvvisamente coscienti, dopo aver aperto un bando basato esclusivamente sulla sensibilità e non sul conto in banca. Allora sì, penso, che potrei abitare i quattrocento metri quadrati di via Lanzone.
Via Gino Bramieri è una piccola strada resistente dietro al caos e all’arroganza di Porta Nuova, qui c’è un palazzo progettato negli anni Ottanta e realizzato negli anni Novanta da Maurizio Calzavara e Silvano Tintori. Su uno dei timpani che coprono le logge è incisa la citazione di un libro di Alberto Savinio del 1944: «Ascolto il tuo cuore, città». È quello che faccio, ho pensato quando l’ho letta la prima volta, in queste passeggiate.

I movimenti che vogliono rovinare il matrimonio di mr. Amazon non ce l'hanno solo, né tanto, con lui: il problema è ciò che Bezos rappresenta e il fatto che abbia deciso di venire a rappresentarlo proprio a Venezia.