Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.
Vengono qui e ci rubano il lavoro
Le macchine ci renderanno tutti disoccupati? Molti dicono di sì ma c'è chi ha un'opinione più ottimista e ci invita a prepararci a un mondo in cui macchine e computer saranno i nostri colleghi.
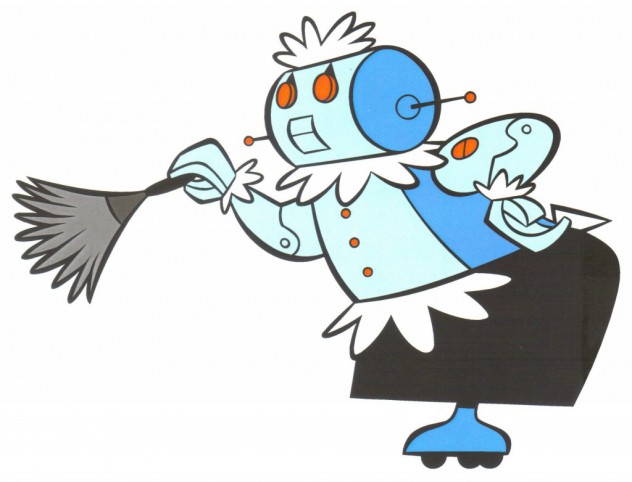
Questa è una storia sulle macchine che in un futuro nemmeno troppo lontano finiranno per togliere molti posti di lavoro a noi umani. È il topos dell’ardito inventore che viene annichilito (in questo caso reso disoccupato) dalla sua creazione: Frankenstein, certo, ma con più transistor. È un affresco di un momento storico in cui computer e algoritmi ci conoscono, ci studiano, ci imitano e imparano a sostituirci con la nostra stessa autorizzazione.
Questa storia non comincia in un garage della Silicon Valley come vuole la narrativa corrente ma nella campagna inglese dello Nottinghamshire, in Inghilterra. È il 1589 e il ventiseienne William Lee presentò alla regina Elisabetta I la prima macchina industriale della storia, un aggeggio che produce lana grezza. Al tempo era il sovrano stesso a rilasciare i brevetti perciò Lee si produsse in una sontuosa presentazione della sua invenzione, senza successo. Si rimise quindi al lavoro, convinto che la macchina non fosse abbastanza valida per impressionare la regina; ne costruì un’altra in grado di cucire trame più fitte e tornò a palazzo reale chiedendo di nuovo udienza. La regina rifiutò ancora: «È volato troppo alto, signor Lee,» disse Elisabetta I a William Lee, «immagini cosa potrebbe fare la vostra creazione ai miei poveri sudditi. Li trascinerebbe di sicuro in miseria privandoli del lavoro, costringendoli a diventare mendicanti». Confusa da quell’innovazione e troppo attenta a preservare lo status quo, la corona tentò quindi di soffocare l’aggeggio infernale nella culla per il bene del suo popolo, quei lavoratori che da secoli cucivano a mano le proprie calze e quelle altrui, guadagnandosi così il pane. Bob Dylan sarebbe nato solo secoli dopo, Elisabetta I non poteva sapere che i tempi stavano cambiando. Il mondo pre-industriale, con tutti i suoi difetti, la fame e la povertà, andava a pennello a qualsiasi sovrano. Immutabile e sicuro: perché cambiarlo?
E a proposito di status quo sempre più stretti, sempre da qualche parte in Inghilterra, un misterioso operaio chiamato Ned Ludd, attorno al 1768, distrusse un telaio meccanico in un impeto d’avversione alle macchine. L’atto ispirò il movimento luddista che nella seconda decade dell’Ottocento condusse una serie di battaglie contro la meccanizzazione delle fabbriche. A poco meno di un secolo dal rifiuto di Lee i tempi erano già cambiati: non solo questi arnesi si erano diffusi capillarmente in molti settori ma dopo l’assalto di Ludd, nel 1769, venne introdotto il “reato di distruzione di macchine”, punito con la morte. Appena due secoli dopo, nel 1775, James Watt costruì il primo motore a vapore: la rivoluzione industriale inglese aveva trovato il suo simbolo. Era ovviamente una macchina.
L’ignara Elisabetta I morì invece nel 1603, quasi convinta di aver conservato il mondo antico.
***
Ma… macchine a vapore? Non sono certo degli sbuffi biancastri a minacciare l’occupazione nel XXI secolo! Rimaniamo quindi nel passato ma corriamo veloci fino al 1965, quando Gordon Moore, co-fondatore di Intel, pubblicò sulla rivista Electronics “Cramming More Components onto Integrated Circuits” (pdf), un articolo che nonostante il titolo piuttosto noioso segnò una nuova fase nel rapporto tra uomo e macchina. In questo, Moore presentò al mondo le meraviglie dei circuiti integrati – all’epoca una novità – spiegando come tra il 1958 e il 1965 le prestazioni dei processori, e il numero di transistor ad essi relativo, fossero raddoppiate di anno in anno (dieci anni dopo corresse il tiro della “legge di Moore” variando il tempo di raddoppio a 18 mesi).
È anche grazie a questo passo felpato che la tecnologia è oggi pronta a cambiare il mercato del lavoro. È questa sua velocità che, come insegna Elisabetta I, continuiamo a temere e proviamo a combatterla. Lo ha dimostrato anche Beppe Grillo, esperto nello sfruttamento delle paure a uso elettorale, durante la campagna elettorale per le scorse europee: in molti suoi comizi ha raccontato spaventato l’innovazione delle stampanti 3D, che potrebbero cambiare per sempre il mercato della produzione industriale e il rapporto tra produttore e consumatore. I toni apocalittici di Grillo sono in parte comprensibili – la stampa 3D è destinata a cambiare il mondo – e ricorrenti nei periodi di transizione (pensiamo al citato luddismo, per esempio). La tentazione è sempre quella di bloccare l’innovazione, aggrappandosi al confortevole status quo anche se la storia ci ha più volte dimostrato che ogni resistenza è inutile: le cose cambiano, sempre.
All’improvviso erano proprio quest’ultimi i più richiesti per lavorare con le macchine. Dati per perdenti nei secoli precedenti, gli unskilled divennero così i «protagonisti della rivoluzione industriale».
E cambiarono anche nell’Inghilterra della rivoluzione industriale, quando, nell’Ottocento, classe dirigente e popolo giunsero a una sorta d’“accettazione” delle macchine. Secondo lo studio “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation” (2013, pdf) di Carl Benedikt Frey e Michael A. Osborne, la pace tra uomini e ferraglia ebbe due cause culturali e politiche: prima il Parlamento inglese cominciò a rappresentare maggiormente il ceto industriale ai danni di quello artigianale; in secondo luogo i consumatori e i lavoratori non specializzati cominciarono a trarre beneficio dalla meccanizzazione della produzione. All’improvviso erano proprio quest’ultimi i più richiesti per lavorare con le macchine. Dati per perdenti nei secoli precedenti, gli unskilled divennero così i «protagonisti della rivoluzione industriale».
***
Per capire appieno la trasformazione in corso – e il nostro futuro – introduciamo due concetti chiave: spread e bounty. Secondo Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, autori di The Second Machine Age (2014), rappresentano le due grandi leve su cui si basa il nostro rapporto con il sistema economico. Da una parte lo spread, qui non inteso come l’uccellaccio del malaugurio che ha congelato l’Italia negli ultimi anni ma come il divario tra ricchi e poveri; dall’altra parte il bounty, la ricompensa (il riscatto, potremmo dire) che i secondi traggono dall’opulenza dei primi. Per spiegarli, i due autori paragonano il mondo della fotografia analogica, dominato da Kodak, a quella digitale odierna, rappresentata da Instagram. “Ai bei tempi” Kodak impiegava 145.300 persone e il suo proprietario George Eastman era ricco sfondato; nel 2012, 132 anni dopo la fondazione dell’azienda, Instagram è stata acquisita da Facebook per un miliardo di dollari proprio mentre Kodak portava i libri in tribunale. Nel frattempo la fotografia è diventata davvero un mezzo universale, le macchine fotografiche sono in qualunque taschino e ogni scatto (gratuito) può essere subito caricato online e apprezzato da tutti. Proprio questa «evoluzione della fotografia» scrivono Brynjolfsson e McAfee «illustra il bounty della seconda era delle macchine, la prima grandiosa conseguenza del progresso esponenziale, digitale e combinatorio in corso oggi». Lo spread lo si scorge invece nella crisi di Kodak seguita dall’ascesa dei nuovi giganti della Silicon Valley, che «impiegano una piccola frazione delle persone di cui necessitava Kodak». Senza dimenticare che «Facebook ha un giro d’affari molto più grande di quello che aveva Kodak e ha reso miliardarie almeno sette persone, ognuna delle quali ha un reddito dieci volte superiore a quello di Eastman».
Rullini, macchine e fotografiche e sviluppo delle pellicole richiedevano lavoro umano. Oggi quei mestieri non esistono quasi più o sono svolti da macchine e algoritmi, mentre noi tutti beneficiamo di servizi che rendono ricchissime un ristrettissimo manipolo di persone. In soldoni, abbiamo possibilità illimitate ma presto ci mancherà un lavoro. Benvenuti nella Seconda Era delle Macchine.
***
Quello che è già successo con le macchine e robot industriali, capaci di svolgere azioni ripetitive o ardue per gli umani, rischia di ripetersi anche al di fuori delle fabbriche, intaccando il terziario e i lavori creativi. Le macchine senza pilota di Google funzionano bene e sono sicure (fanno solo difficoltà a relazionarsi con i veri guidatori, distratti, arrabbiati, malcuranti, ubriachi: imperfetti); algoritmi sempre più raffinati sono in grado di “capire” le esigenze dei clienti e agire di conseguenza, vendendo proprio il prodotto che essi cercano; alcuni software sono in grado di compilare dichiarazione dei redditi assorbendo i dati dei loro clienti e togliendo lavoro ai commercialisti. E così via. Che ne sarà di noi? Secondo Brynjolfsson e MacAfee anche questa volta l’umanità può farcela: molte cose dovranno cambiare ma no, la venuta dei robot non sarà l’Apocalisse. Per capire il loro ragionamento, torniamo per un attimo alla storia recente.
Con l’avvento dei robot industriali il numero di persone necessarie a certi compiti è diminuito, certo, ma non si è azzerrato. L’elettrificazione delle nostre città e industrie, alla fine dell’Ottocento, permise l’utilizzo di macchine più moderne, abbattendo la quota di lavoratori non specializzati, portati in gloria nella prima rivoluzione industriale, in favore di quelli specializzati. I primi colletti bianchi fecero così il loro ingresso nelle fabbriche, umani privilegiati perché in grado di comunicare con la volgare ferraglia che Ludd voleva distruggere. Per farlo, però, dovevano essere formati ed educati. Naquero così scuole e corsi di formazione per sfornare personale lontano dal grigio abitante alienato delle slum inglesi. «Sin dall’elettrificazione», notano Frey e Osborne nel loro studio, «la storia del XX secolo è coincisa con la corsa tra educazione e tecnologia». L’innesto di macchinari industriali non riduce necessariamente il personale umano, pur generando scossoni culturali e politici (le scuole, la formazione) e sociali (i colletti bianchi).
Tra i mestieri che difficilmente saranno affidati a una macchina ci sono quelli che si basano sui sentimenti: solo un essere umano può accudire un suo simile senza terrorizzarlo con la sua faccia robotica.
Quando negli anni Sessanta del Novecento sbocciò la rivoluzione dei computer, tutto cambiò di nuovo: fu il boom del terziario, un periodo in cui gli stipendi del personale specializzato nell’utilizzo dei calcolatori crebbero del 10-15%, e la fine di molti lavori manuali di routine, ora svolti dai computer. Per quando possa sembrare strano, oggi non viviamo nell’era dei computer, che si è conclusa negli anni Novanta. Il nostro tempo è dominato da internet, che in pochi anni ha stravolto cultura, economia e politica. La rete non è però sola: esistono nuove tecnologie rivoluzionarie come il big data, ovvero lo sfruttamento e l’analisi di enormi quantità di informazioni ad opera di algoritmi sofisticatissimi in grado di umiliare in pochi secondi il sudore di centinaia di Ph.D; il machine learning, la capacità che i computer stanno acquisendo di “imparare” e “dedurre” nuove capacità; la stampa a 3D di cui abbiamo già discusso; e i droni, che come insegna Amazon, sono destinati a cambiare, oltre che la guerra, anche il commercio e la sicurezza. Il mercato del lavoro non umano non è mai stato così vivace.
***
Tra i mestieri che difficilmente saranno affidati a una macchina ci sono quelli che si basano sui sentimenti: ospedali, case di cura, servizi di sostegno per anziani e bisognosi. Il motivo è chiaro: solo un essere umano sa capire le esigenze di una persona in difficoltà, solo un umano può accudire un suo simile senza terrorizzarlo con la sua faccia robotica (uncanny valley). Anche i lavori basati sul movimento e la coordinazione potrebbe essere al sicuro: in robotica, infatti, esiste il «paradosso di Moravec» per il quale è relativamente facile creare computer dotati di capacità intellettive degne di un adulto ma incredibilmente complicato – se non impossibile – dotarli delle capacità motorie di un bambino di un anno. Cuochi, giardinieri, carpentieri e dentisti possono dormire sonni tranquilli.
La lezione generale del libro The Second Machine Age è che in un mercato del lavoro digitalizzato, dovremo puntare tutto sulla nostra capacità d’influenzare gli altri: parliamo di status sociale, credibilità e reputazione – tutte capacità umane alla base del rapporto interpersonale. Chi ce la farà, potrà davvero trionfare perché la sua idea potrà avvalersi di informazioni e beni digitalizzati, trasporti e telecomunicazioni sempre più veloci e network sempre più potenti. È un fenome economico che prende il nome da una hit degli Abba (“The Winner Take It All”), secondo cui, dati una serie di competitor più o meno allo stesso livello, basta una piccola modifica del panorama per farne trionfare uno su tutti. Si tratta di una rivoluzione della vecchia idea di libera concorrenza, retto dalla formula “lavora tanto se vuoi successo”. Secondo Brynjolfsson e MacAfee, è quello che è successo con Waze, uno dei tanti social network per il traffico nati negli scorsi, presto diventato “il” social network per il traffico dopo esser stato acquisito da Google. Waze aveva anche competitor di qualità che avrebbero potuto guadagnarsi una fetta di mercato o prendere il suo posto ma l’app scelta dalla Grande G è stata solo una. Avevano ragione gli Abba: il vincitore si prende tutto.
***
C’è chi teme che le nuove macchine, dopo aver intaccato il terziario, possano impadronirsi anche dei cosiddetti “lavori creativi”, club di professioni elitario che si presume essere al riparo dal ronzio dei computer. La questione è ancora aperta e, come spiega Stevan Harnard, autore di “Creativity: Method or Magic?” (2007) potrebbe rimanerlo a lungo: nel corso dei secoli, infatti, l’umanità non è riuscita a concordare su una definizione unica e convincente di “creatività”, concetto amplio e misterioso che secondo alcuni ha del magico. In genere però ogni mestiere basato sulla scrittura (scrittore, giornalista, copy, redattore, poeta, pubblicitario…) è considerato un mestiere “creativo”, un’equivalenza che nella realtà potrebbe non sussistere. Da qualche anno esistono ottimi bot in grado di redarre articoli indistinguibili da quelli tradizionali o di selezionare notizie seguendo l’agenda del momento. Gli studiosi del settore sono abbastanza concordi nel dire che nessun bot firmerà mai lo scoop del Watergate ma è chiaro che anche nel settore “creativo” ci siano mansioni di routine che potranno essere assorbite dai computer.
Negli anni seguenti, visto lo strapotere della macchine sulla scacchiera, è nato un nuovo gioco chiamato “scacchi avanzati” o “scacchi a stile libero” in cui a sfidare un supercomputer sono team composti da umani e macchine.
Non che questo sia di per sé una tragedia. Nella loro teoria economia futuristica Brynjolfsson e McAfee ricordano che la digitalizzazione di un’azienda non è un invasione degli Unni che nulla lascia alle sue spalle se non sangue e disperazione: le macchine garantiscono notevoli risparmi alle aziende che – è già successo – sono libere di investire più soldi nei loro dipendenti umani (e più qualificati).
Ci saranno vincitori e perdenti: i primi riusciranno ad accumulare capitale umano (oggetti di valore, copyright, idee…) e non umano (skills, capacità e competenze ricercate nel nuovo mondo – come la conoscenza dei big data); i secondi saranno quelli non specializzati, auto-relegatesi in competenze elementari, molto probabilmente affidate ai computer. Il mantra tra gli specialisti del settore è sempre lo stesso e sembra uscire dal dialogo di un vecchio Urania: ricordatevi, le macchine non sono meglio di voi. Proprio così: sono tempi strani quelli in cui il professor Osborne della Oxford University raccomanda ai giovani «di coltivare capacità cognitive e creative che [vi] rendano competitivi nei confronti dei computer», eppure sembra proprio questo il segreto. Non si tratta di sfidare i computer a una folle gara d’intelligenza, quanto d’accettare la loro presenza e le loro capacità.
***
Quando nel 1997 il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov perse una partita contro “Deep Blue”, il super computer della Ibm, in molti gridarono al tramonto del genio umano. Negli anni seguenti, visto lo strapotere della macchine sulla scacchiera, è nato un nuovo gioco chiamato “scacchi avanzati” o “scacchi a stile libero” in cui a sfidare un supercomputer sono team composti da umani e macchine. In questa nuova specialità non solo gli uomini sono tornati a trionfare ma spesso i vincitori sono giocatori amatoriali con grandi doti informatiche. È una novità che ha sorpreso lo stesso Kasparov, che ha notato come la combinazione «debole umano + macchina + migliore processo di gioco sia superiore a un computer». Volevate una risposta chiara e concisa a questa enigmatica scommessa sul futuro? Eccola: alleatevi con i computer e coltivate il vostro genio fino a rendere palese l’utile stupidità di quelle macchine.
Forse lo spirito animale perfetto per il XXI secolo è il pittore Pablo Picasso, che nel 1968 ebbe l’opportunità di vedere in funzione un calcolatore. Certo, la tecnologia dell’epoca arrossisce al confronto con quella odierna ma val la pena ricordare la reazione dell’artista dopo qualche minuto d’osservazione. «Ma sono inutili», disse Picasso alzandosi in piedi infastidito, «sanno solo dare risposte».
Dal numero 20 di Studio
Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.



