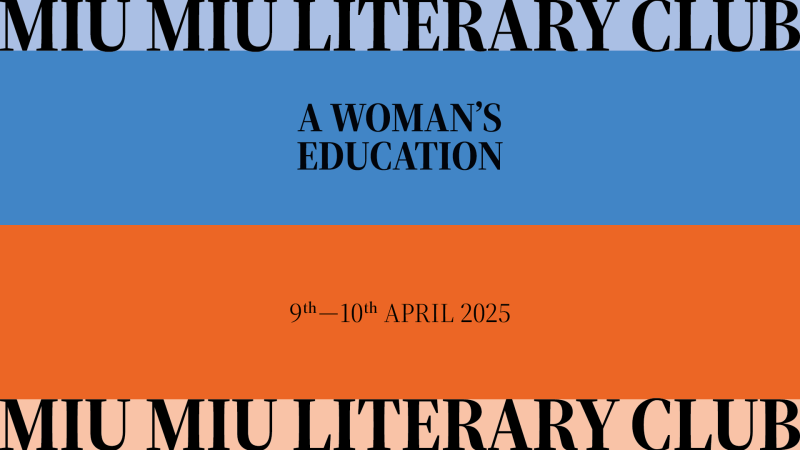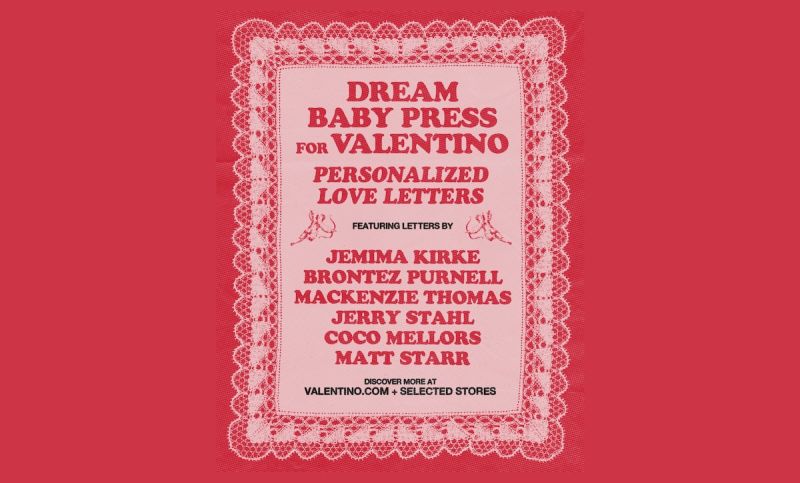Il volto di Vivienne Westwood nella pubblicità di Burberry, uno dei primi segnali della nuova direzione artistica di Riccardo Tisci, la borsa realizzata da Alessandro Michele e Rei Kawakubo, dove i colori di Gucci si sovrappongono al logo di Comme des Garçons, il progetto Moncler Genius, con sei designer esterni che ridisegnano il piumino: sono solo alcuni degli esempi più recenti, e meglio riusciti, di co-branding. Lo sdoganamento della collaborazione fra marchi, d’altronde, è uno dei tanti modi in cui streetwear e sportswear (due mondi nei quali è sempre stata praticata) hanno significativamente modificato l’industria della moda negli ultimi vent’anni, offrendo ai brand del lusso una via alternativa per raccontare se stessi. Ne avevamo parlato all’uscita della collezione di Balmain per H&M, disegnata alla fine del 2015 da Olivier Rousteing: quasi tre anni dopo, al suo posto ci sono Moschino e Jeremy Scott. E se quest’ultima operazione sembra ormai aver perso di smalto, considerando anche la fase difficile attraversata dal fast fashion, le partnership fra le case di moda godono al contrario di ottima salute. Di fatto, sono oggi la maniera più agile per rinnovare l’immagine di un brand e allargarne il pubblico di riferimento.
Come spiega Osman Ahmed su New York Times, in un momento in cui i direttori creativi continuano a succedersi senza troppe cerimonie e i marchi devono offrire altro dal loro heritage a un consumatore sempre più difficile da fidelizzare, instaurare collaborazioni occasionali è una scommessa tutto sommato meno rischiosa rispetto a quella di imbarcarsi in una più ampia riscrittura della propria identità. A volte, come nel caso dell’universo complesso di Gucci, può essere uno dei tanti modi in cui quell’operazione di riscrittura avviene; per altre, si pensi a Moncler o a Tod’s, si tratta di un intelligente lavoro sui capi longseller che hanno fatto la fortuna del marchio, rinfrescati da visioni differenti. È un’evoluzione delle collezioni a edizione limitata sul modello H&M, continua Ahmed, e si potrebbe aggiungere che – messa definitivamente da parte la pretesa di democratizzare il lusso (a quello ci pensa il mercato unico) – oggi i co-branding puntano sempre più all’interdisciplinarietà e ridefiniscono il ruolo del designer di moda. Lo sa bene Virgil Abloh, a capo dell’uomo di Louis Vuitton e direttore creativo per eccellenza, che ha all’attivo collaborazioni con Ikea, il Museum of Contemporary Art di Chicago, Nike e Dr. Martens fra le altre cose e che a Studio ha detto: «Voglio disegnare un aereo, voglio disegnare un grattacielo. E voglio che queste cose siano considerate normali [per qualcuno che viene dalla moda, nda] e non “avant-garde”».

La borsa di Gucci e Comme des Garçons
È il metodo meno rischioso per rinnovare, dicevamo, soprattutto perché il più delle volte è a tempo determinato (come tutto il lavoro contemporaneo). D’altra parte «con un solo direttore creativo parli a una sola generazione» ha spiegato efficacemente Remo Ruffini, presidente di Moncler, al Nyt, aggiungendo che «il lusso può diventare noioso in fretta, perciò devi creare dei contenuti ogni mese, ogni settimana. È quello che vuole il mio consumatore». Lo ha scritto anche Lou Stoppard recentemente su Financial Times, poi, che questa è l’era del contenuto. Tutto è contenuto, dalle didascalie degli e-commerce agli approfondimenti dei giornali, dalle stories degli influencer (macro, micro o nano che siano) su Instagram al racconto dell’ultima insospettabile collaborazione (Valentino e UNDERCOVER, ad esempio, binomio perfetto per la sfilata del marchio italiano a Tokyo). È comunicazione del marchio, insomma, e se fatta bene non dovremmo nemmeno percepirla come tale. Effetti del multitasking digitale, dicono ancora gli esperti al Ft, e cioè che ce lo siamo voluti da soli.