Se avete la carnagione molto chiara o siete amanti di videogiochi, potrebbe essere la grande occasione per esordire al cinema.
Le tante care cose di Chiara Alessi
Dopo il successo di #designinpigiama, la curatrice e docente di design pubblica il suo libro dedicato ai 74 oggetti che ci hanno cambiato la vita.
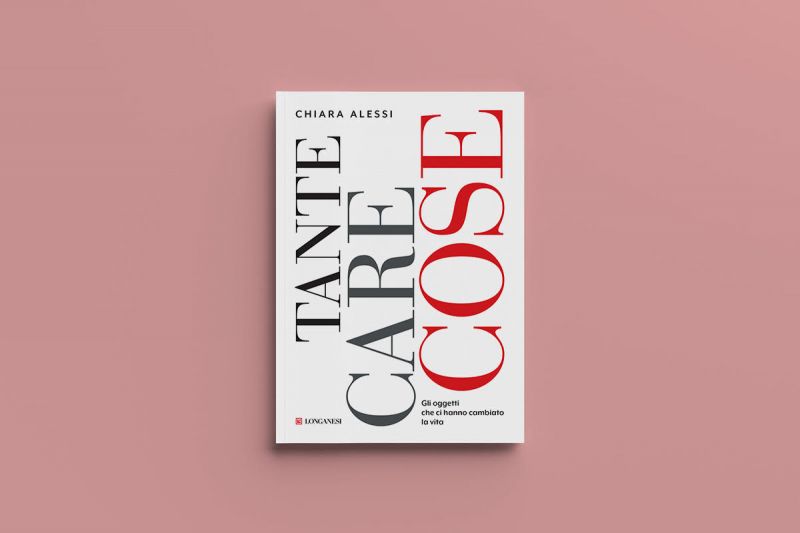
Skype sfarfalla e la telecamera si accende su Chiara Alessi, che oggi non si staglia sulle coste colorate dei suoi libri, ma sul cielo perlaceo di una mattina di non so più quale ondata pandemica, e questa volta non è uno dei suoi video informali sul Super Santos, la Rinascente o la cedrata Tassoni, ma una altrettanto informale chiacchierata su Tante care cose, il libro uscito il 4 febbraio per Longanesi, sgorgato proprio dall’esperienza social di #designinpigiama. Nei mesi del primo lockdown, Chiara Alessi, giornalista curatrice e docente a contratto al Politecnico di Milano, ma anche bisnipote d’arte del signor Bialetti e del signor Alessi, ha provato a raccontare su Twitter in modo informale (in pigiama, appunto) una novantina di oggetti, dal telefono rosso e grigio della Sip di Giugiaro alle biglie con dentro i ciclisti. Per qualche felice gioco di prestigio, è riuscita a colare, forse col noto imbuto a forma di Pinocchio, lo stesso acuto stupore dei suoi video in questo saggio, che io ho trovato intimo e amoroso, mentre lei giura di essere il contrario di una feticista e di una sentimentale.
ⓢ A parte la fugace comparsa di un bisnonno che dal filtro della cenere per il bucato immaginò la moka, questo libro non ha quasi niente di autobiografico. Eppure io l’ho letto come un romanzo, con lo stesso godimento che riservo alle autobiografie infantili di Nabokov o de Beauvoir, dense di revocazioni di spazi, case, forme, colori e tagli di luce sugli oggetti. Secondo te perché?
Non c’è una ragione intima in questo racconto, mentre mi piaceva l’idea di trattare gli oggetti come se fossero loro dei personaggi che parlano con una voce propria. Il mio ruolo è quello di fare delle domande precise a questi oggetti, come stai facendo tu con me. Credo che questo dia anche un ritmo stilistico particolare al libro, con oggetti descritti in rima baciata o in forma epistolare. Il capitolo dedicato alla zip è scritto come un manifesto futurista, sfruttando il suo nome onomatopeico come compare nei fumetti; altri capitoli sono costruiti sotto forma di test, elenco o articolo di giornale. Ora che ci penso gli oggetti avrebbero potuto parlare anche in prima persona. Se mai, quel che c’è di mio è l’idea di mettere gli oggetti in pigiama, perché non ho mai guardato al design come una cosa di lusso, da museo.
ⓢ Perché proprio quegli oggetti lì?
Per me il sottotitolo «gli oggetti che ci hanno cambiato la vita» è apodittico: io mi sono occupata di 74 oggetti, ma non li ho scelti in quanto oggetti di affezione personale o perché fossero davvero quelle lì e basta le cose di cui parlare. Li ho scelti perché su questi avevo scoperto storie sconosciute e affascianti, e credevo potessero essere cari a tante persone della mia generazione, di quella appena precedente e successiva. Ecco, se c’è un aspetto biografico, è di una biografia corale, collettiva.
ⓢ Nei mesi del lockdown, quando la casa si è ridotta a mondo, abbiamo tutti pensato di vivere in case orrende, e ci siamo pentiti di ogni quadro e divano. Qual è la conseguenza della prolungata vita domestica sulla nostra percezione degli oggetti?
Durante il lockdown abbiamo usato uno strumento freddo per entrare in contatto con gli altri, e però entravamo nelle case, vedevamo i letti, come io vedo il tuo adesso. In questo senso, le nostre case sono diventate i nostri vestiti, e, non potendo andare nei musei, tutti abbiamo iniziato a fare più caso agli oggetti che avevamo intorno, a interrogarli.
ⓢ Ho letto che non hai tanti oggetti di design in casa. Qual è la regola d’oro per non circondarsi di cose di cui poi ci si pente?
Sì, ho pochi oggetti di cosiddetto “design”. Soffro molto la sovrabbondanza. Preferisco gli oggetti sulle pagine dei libri, e di questi ho un discreto inventario. Quando ho fatto #designinpigiama su Twitter, non potevo mostrare un granché perché non ho un granché. Potevo aprire i miei libri, ma preferivo parlare di oggetti che tutti avessero ben presente, come le sedie usate all’asilo, oggetti che accendessero lampadine. E in effetti poi la gente è andata in garage o dalla nonna a recuperare e rispolverare cimeli. È ovvio che sentire la casa stretta nella pandemia è un sintomo, non un problema della casa. Ma un criterio per stare bene è somigliare alle case che si abitano. Il punto è che poi si cambia, e a volte non ci si riconosce più negli oggetti che si hanno intorno. A Milano, per esempio, si dovrebbe abitare una casa in grado di armonizzarsi col grigio fuori: se la scegli in estate poi rischi che succeda come con quegli acquisti che fai in viaggio e poi fuori da quel momento stonano.
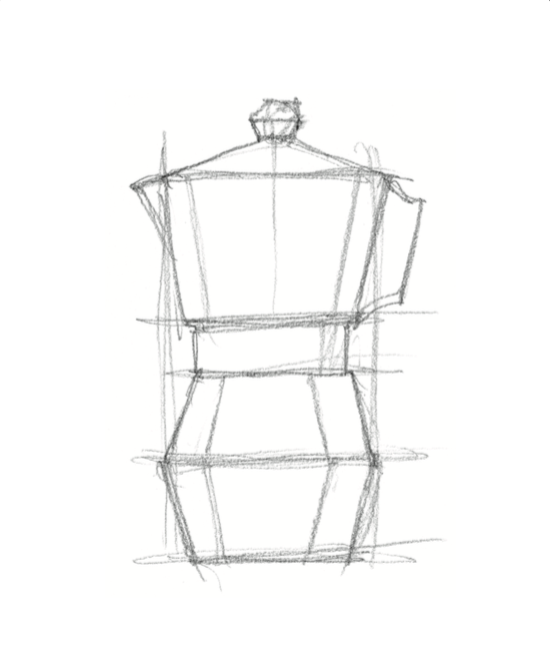
1933, la moka di Alfonso Bialetti (disegno di Paolo D’Altan)
ⓢ Nel libro, ho amato quando parli della metropolitana di Milano come esempio di buon design invisibile: il lettering per le scritte, disegnato apposta da Bob Noorda, la distanza precisa a cui sono ripetuti i nomi delle fermate, a cui non facciamo caso perché sono perfetti… Nel 2020, il Comune di Milano ha fatto appello ai designer per immaginare la nuova città sociale col distanziamento. Cosa ne pensi?
Rileggendo il libro, ho realizzato che tantissimi oggetti di cui ho parlato erano stati inventati nel dopoguerra. Io rifiuto la metafora della guerra rispetto a quello che stiamo vivendo noi, lo trovo un errore sia storico che filosofico, però si possono confrontare il contesto creativo post-bellico e quello del post-pandemia. Quando grandi eventi sconvolgono la società e la cultura, va ripensato tutto. La cosa interessante è che allora nascevano progetti in totale controtendenza con la situazione appena vissuta: la Vespa, l’Ape, la Fiat. Che il tema della mobilità e del tempo libero emergessero in luoghi dove fino a poco tempo prima c’era il terrore di uscire, ci fa capire come progetti contraddicessero il mondo immaginando nuovi bisogni. Mi fa specie che adesso il mondo dei progetti giochi in difesa invece di rilanciare. La soluzione immediata al problema di disegnare i dehors non è il vero contributo del mondo del progetto in grado di spostare il paradigma. Questa dovrebbe essere l’occasione per aggiornare il design italiano: adesso la cultura immateriale e il design dei processi sono diventati fondamentali in tutte le industrie. Mi chiedo perché non siamo arrivati con una classe di pensatori e designer per organizzare i vaccini, braccia a braccia con qualcuno competente dal punto di vista sanitario. Non mi riferisco a disegnare il padiglione, ma a qualcuno che immagini col suo pensiero laterale la distribuzione logistica delle dosi.
ⓢ Immaginare il futuro degli eventi, quindi, è a tutti gli effetti tra i nuovi campi di azione del design?
Il Politecnico di oggi ha moltissimi corsi orientati ai processi, al mondo della comunicazione e degli eventi, al design per gli ospedali. In questo momento, però, purtroppo, il design negli ospedali è considerato la panna montata. Ma è sbagliato. C’è invece gran bisogno di qualcuno che organizzi il funzionamento delle corsie e l’immediatezza della segnaletica. Questo non significa che nessuno deve più disegnare belle sedie e belle lampade, ma che ci deve essere un adeguamento del valore che noi diamo al processo per renderci la vita migliore. L’amministrazione comunale del 1964 chiamò il migliore di tutti per fargli ridisegnare il font Helvetica e rendere i segnali della metro più leggibili; decenni dopo, per l’ampliamento della rete metropolitana, nessuno ha pensato di richiamarlo per disegnare nuovi caratteri, come la Y, che allora non erano stati necessari. Pare che Noorda in quell’occasione abbia detto: forse pensavano che fossi già morto!
ⓢ Del tuo periodo preferito del design, sottolinei una cosa: che azienda e design erano integrati, armonici, parti complementari di un tutto. Adesso non è più così?
Ci sono due discorsi separati da fare. Il rapporto designer/azienda è la cifra del periodo tra il dopoguerra e gli anni Ottanta. Quand’è nato il design? Quando il primo uomo ha pensato di lavorare uno strumento o con il primo che lo ha firmato? Con Pompei o con la rivoluzione industriale? Per me, in Italia, nasce quando le aziende iniziarono a pensarsi come editori, e i loro autori erano i progettisti. Vico Magistretti, designer milanesissimo, diceva che design e azienda sono come pane e marmellata. Altra cosa è invece il rapporto tra intellettuali e aziende, che caratterizza specialmente la cultura italiana e che inizia a incrinarsi tra anni gli anni Cinquanta e Sessanta per ragioni politiche. Prima ancora che la managerialità si sostituisca all’imprenditorialità e che il marketing diventi il fattore di ricerca culturale, questa cosa viene anticipata dal mondo intellettuale che inizia a snobbare l’azienda, ma forse in generale la realtà, trasformandosi in un indignato permanente, una minoranza che ragiona in un Paese che ha torto. Prendiamo il caso della Rai, la Rai aveva un Ufficio Stile con i migliori grafici e poeti. Come racconto nel libro, Vittorio Sereni, uno dei più grandi poeti del Novecento, era l’ufficio stampa di Pirelli, l’ufficio stampa di un’azienda che fa pneumatici! Oggi sembra incredibile.
ⓢ Abbiamo parlato di dopoguerra come età dell’oro del design. Nel libro, mi hanno affascinato le tante invenzioni nate in contesto bellico e poi traslate nel mondo della società civile, come il latte in polvere e la zip, passate direttamente dai soldati alla prima infanzia.
Il settore militare è un settore che storicamente ha sempre prodotto innovazione. Il telefono cordless e il cellulare nascono in guerra, per un’esigenza che non era delle persone normali, ma dei soldati. Ci sono tante cose nella storia del design che nascono per un’esigenza molto specifica, e poi salta fuori che sono adatte a tutti. Le situazioni emergenziali ci insegnano che l’obiettivo non è, come si può pensare, l’uomo medio. Chi è l’uomo medio? Tanto per cominciare, è uomo o donna? Alto o basso? Giovane o vecchio? L’uomo medio non esiste, esistono solo le deviazioni: è meglio lavorare su qualcosa di particolare che poi magari andrà bene per tanti. Anche il tampax nasce in guerra: c’era il problema di dover lavare spesso le bende di cotone insanguinate dei soldati. Le aziende presero a produrre bende in cellulosa usa e getta e le infermiere da campo scoprirono che erano comode anche per il ciclo. Nel 1929 venne brevettato l’assorbente: nato per gli uomini, e cent’anni dopo ancora usato da noi donne.

anni Trenta, la Zip di Elsa Schiaparelli (disegno di Paolo D’Altan)
ⓢ Ancora Magistretti, che descrisse per telefono il progetto per la lampada Eclissi, dice che se un’idea è buona non serve il disegno. Tu, cresciuta in mezzo ai giocosi spazzolini dell’azienda di famiglia, hai mai pensato di disegnare, anziché fare lo storico?
Non saper disegnare è il mio principale complesso, perché molti mi scambiano per un architetto, e si aspettano che abbia l’abilità, da me sommamente invidiata, di trasferire su carta. Invece, tutto quel che sono riuscita a sviluppare nel tempo è un buon occhio. [Le illustrazioni dei 74 oggetti, di Paolo D’Altan, schizzate come labili ombre emerse dall’immaginario collettivo, sono meravigliose, nda] La scelta di occuparmi di storia del design non la definirei casuale: è andata che mio zio Alberto Alessi stava curando una mostra col designer Alessandro Mendini, e mi ha chiesto una mano per il catalogo. Così, avendo avuto la fortuna di lavorare con un maestro del genere, ho iniziato a studiare, approfondire e confrontarmi con altre persone che potevano insegnarmi altre cose. E sono stata fortunata. Mi piace pensare che fra dieci anni potrei anche fare lo stesso occupandomi d’altro. In fondo arrivo al design dal mondo del teatro…
ⓢ Da professoressa a influencer: come ti trovi?
Un po’ a disagio: una parte consistente di chi mi segue pensa che io sia un’arredatrice e mi arrivano domande molto tecniche su come sistemare i mobili o sul loro eventuale valore, domande a cui io non so rispondere. Invece mi piace essere taggata in discussioni in cui si parla di ricerca e storia. La cosa più bella che mi è successa su Twitter è stata la creazione di una comunità di persone che io non avrei mai raggiunto, e che a loro volta non sarebbero arrivate a me perché non sapevano di essere interessate al design.
ⓢ Infatti, sarò naïf, ma per me è strana tutta questa distanza tra noi e le cose che usiamo da sempre. Penso alla Coca Cola, ma anche all’interruttore dei fratelli Castiglioni, quello che, con parole tue, «le dita trovano anche al buio» e che «abbiamo l’impressione ci sia sempre stato».
La scommessa infatti, con #designinpigiama, è stata parlare, su un social di tendenze e attualità, di storia e di oggetti. Era un cortocircuito. Io non mi sento una divulgatrice, ma in quel momento ho avuto l’intuizione che le cose che sapevo e m’incuriosivano intercettavano la curiosità della gente: la sfida era illuminare gli oggetti che tutti conoscono con una luce un po’ diversa. E alla fine, il libro è stato costruito anche con le suggestioni arrivate dalla gente.
ⓢ Quindi l’idea del libro non preesisteva, ma è partita proprio dai video della prima quarantena?
Non solo non avevo in mente questo libro, ma a posteriori non ero nemmeno convinta che due minuti di video racconto scapestrato si potessero tradurre in libro. Non volevo fare la replica del classico atlante di design. È stato Giuseppe Strazzeri, il direttore editoriale di Longanesi, a contattarmi, convinto che qualcuno avesse già bloccato l’idea, invece era il primo a chiedermelo. Siamo stati subito in sintonia sul fatto che la voce non doveva essere quella accademica e che il libro dovesse rivolgersi a un pubblico più ampio possibile. Per questo ho cercato di far parlare gli oggetti, e loro mi hanno insegnato tantissimo di sé.
ⓢ Il titolo ha una genesi speciale?
Viene da una persona cara che aveva fatto un progetto con questo hashtag, un progetto che non c’entrava niente con gli oggetti, ed era così bello, così giusto che a un certo punto ho dovuto chiederle se me lo prestava. Tante care cose è un augurio, un’espressione di congedo affettuosa. Ed è una dedica a tutte le persone che lo terranno in mano, spero anche tra tanto tempo.






