Lo ha scritto in un articolo pubblicato sull'Irish Times, in cui attacca (di nuovo) il governo inglese per le sue posizioni filoisraeliane.
La paura di tornare in ufficio
Per alcuni il Covid ha cambiato definitivamente il nostro modo di lavorare, ma molte aziende stanno chiedendo ai propri dipendenti di tornare in presenza.

Il 22 agosto una Milano completamente deserta assisteva alla chiusura della grande mostra di Elmgreen & Dragset alla Fondazione Prada. Chissà dove saranno finite tutte le scrivanie e le sedie, ora completamente inutili, che componevano l’opera “Garden of Eden”, un ufficio deserto tranne che per qualche oggetto personale dimenticato o abbandonato dagli impiegati immaginari che lo popolavano. La mostra si chiamava Useless Bodies? e si interrogava sulla funzione dei nostri corpi oggi. Tra le tante domande sollevate, c’erano quelle suscitate dall’opera dell’ufficio: cosa siamo se il nostro corpo diventa superfluo, se resta nascosto, se la nostra produttività non coincide più con la sua manifestazione fisica in un luogo? Il lockdown, lo smartworking, la Great Resignation: l’opera dell’ufficio vuoto (o abbandonato?) parlava di corpi e società e rappresentava perfettamente quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Interrogati sulla genesi dell’opera, però, gli artisti ci avevano raccontato che l’idea di riprodurre un ufficio vuoto gli era venuta un anno e mezzo prima della pandemia. «Prima del Covid», ci avevano detto qui, «pensavamo di rappresentare l’ambiente dell’ufficio come luogo in cui si cerca di ottimizzare le risorse umane, riunendo più persone possibili nel minor spazio possibile. È folle che anche in ambienti creativi o artistici ci siano uffici del genere: obblighi le persone a lavorare 8 ore al giorno con così poco spazio a disposizione, è come un allevamento di animali, stai seduto nel tuo piccolo spazio e puoi rivendicare la tua personalità con qualche oggetto, ma quello spazio è identico a quello dei tuoi colleghi e le condizioni di lavoro sono totalmente uniformate». Come accade spesso alle grandi menti (un altro esempio è Ottessa Moshfegh con le dimissioni e l’isolamento della protagonista ne Il mio anno di riposo e oblio), Elmgreen & Dragset hanno profetizzato il drastico cambiamento avvenuto (e ancora in corso) nel rapporto tra il nostro corpo e il luogo in cui lavoriamo.
Prima del Covid, sarebbe stato difficile immaginare di poter pretendere di lavorare da casa. Chi non aveva la “fortuna” di essere free-lance (una libertà che porta con sé un bel bagaglio di rotture di palle) si recava ogni giorno nello stesso luogo alla stessa ora senza battere ciglio, anzi, magari imparando a costruirsi e gustarsi una sua routine, come quelle ragazze su TikTok che elogiano lo stile di vita “9 to 5”, rassicurandoci che non c’è niente di male a non mollare il proprio lavoro d’ufficio per fare carriera come influencer o scrittori, ricordandoci che non essere ambiziosi non coincide per forza con l’essere scemi: nel mondo esistono persone umili che, spesso, si manifestano sottoforma di impiegati sereni. Ma la vita è così: a volte non ti accorgi di desiderare una cosa finché non hai modo di provarla. Il lockdown ha illuminato anche i più appassionati frequentatori dell’ufficio: quelli che amano gossippare coi colleghi – “I love my colleagues” recitava un segnaposto dimenticato su una delle scrivanie dell’opera di Elmgreen & Dragset – , quelli che hanno bisogno di fare brainstorming di persona, perché “parlare guardandosi negli occhi (senza schermi di mezzo) è un’altra cosa”, quelli che si piacciono così tanto che per loro è un peccato restare chiusi in casa con addosso il pigiama, hanno bisogno di vestirsi bene, esistere fuori dalle mura di casa, farsi vedere dagli altri. Perfino loro hanno dovuto ammettere che la soluzione ideale sarebbe un mix di ufficio e smartworking.
Ma se il lavoro a distanza è così fruttuoso per tutti, perché molti manager pretendono che si torni in ufficio? Si è parlato del caso dei dipendenti di Apple, che prima delle ferie hanno ricevuto una comunicazione firmata dal Ceo Tim Cook: preparatevi perché a settembre si torna in ufficio almeno per tre giorni alla settimana. Molti di loro si sono rifiutati e hanno firmato una petizione per ottenere la possibilità di continuare col remote working. Al contrario di Twitter e Facebook, che hanno concesso ai loro dipendenti la possibilità di scegliere di lavorare permanentemente da casa, Apple non sembra aver intenzione di cedere e pur di vedere i dipendenti tornare alle scrivanie sembra disposta a perderne alcuni a favore della concorrenza.

Nell’articolo “Why Managers Fear a Remote-Work Future”, l’Atlantic confronta questo dibattito alla battaglia di Spielberg contro i servizi di streaming e a favore delle sale: alla fine ha dovuto cedere anche lui e la sua società ha firmato un accordo con Netflix. Ed Zitron, autore dell’articolo, propone a ogni manager un breve test/esame di coscienza. Alcune domande sono un po’ bizzarre, ad esempio: prima del Covid, quante volte andavi tu stesso in ufficio? Alcune hanno più senso: il tuo business ha sofferto per lo smartworking, e se sì, esattamente, in che modo? Zitron non la tocca piano, e scrive: «Il lavoro a distanza dà potere a chi produce e priva di potere coloro che hanno avuto successo essendo eccellenti diplomatici e scarsi lavoratori, insieme a coloro che hanno avuto successo trovando sempre qualcuno da incolpare per i loro fallimenti. Rimuove la capacità di sembrare produttivo (stare seduto alla scrivania con l’aria stressata o farti vedere sempre al telefono) e, soprattutto, può rivelare quanti capi e manager semplicemente non contribuiscono ai profitti». Poi specifica che questo vale solo per certe professioni: «Non puoi lavare i piatti su Zoom o cambiare le lenzuola su Slack». Acuta osservazione. Zitron dipinge un ambiente di lavoro da incubo, pieno di furbastri che, lavorando da casa, non avrebbero più modo di esercitare le loro doti manipolatorie. Ignora del tutto l’ipotesi dell’esistenza di un team di lavoro affiatato e i contro del remote working, ad esempio quanto è più facile fraintendersi e innervosirsi conversando soltanto su Slack o Whatsapp o via mail piuttosto che di persona. Quella cosa di guardarsi negli occhi sarà pure stucchevole, ma è vera.
Ci sono tanti motivi per promuovere il remote working. Si inquina meno, si risparmia in tutto. Spende meno anche l’azienda, soprattutto considerando i tempi oscuri (ancora più oscuri) che ci attendono: se non c’è ufficio, non c’è affitto né bollette, non c’è aria condizionata né riscaldamento. Il remote working, però, è meno democratico. Io, ad esempio, sono relativamente fortunata: vivo da sola in una casa spaziosa, non ho compagni né figli che mi disturbano. La mia abitazione non è dotata, però, di aria condizionata. Motivo per cui, nell’estate bollente appena trascorsa, la redazione appariva davanti a me come un’oasi, allo stesso modo in cui, forse, è stata un’oasi per i miei colleghi con una casa molto piccola, o quelli pieni di figli. Paradossalmente, nella vita da ufficio siamo tutti uguali: non importa cosa ci aspetta dopo, se una cena in un ristorante stellato o una pasta in bianco, se un monolocale di 17 metri quadri o un enorme attico con tutti comfort. Non importa se abbiamo 3 case al mare o nessuna. Per 8 ore al giorno abbiamo condiviso lo stesso spazio. E forse è questo un rischio del remote working: perdere la possibilità del dialogo (o perlomeno la compresenza) tra classi sociali e situazioni esistenziali diverse. Ritrovarci blindati nel nostro status, senza vie di fuga.
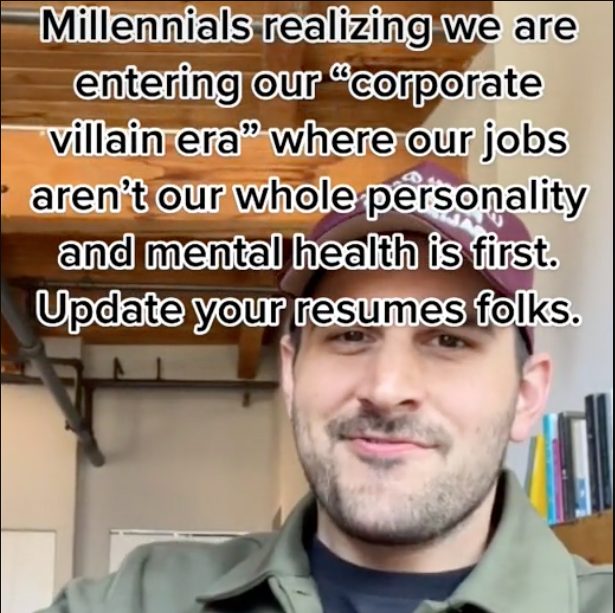
All’inizio dell’estate sul Guardian è uscito un articolo dal titolo “Working from home: how it changed us forever”, in cui diversi collaboratori analizzano vari aspetti dello smartworking: il rapporto coi colleghi, le case, il cibo, le relazioni, lo shopping. Come scrive Eva Wiseman: «Ho letto e pensato di più alla vita in ufficio negli ultimi due anni di quanto non abbia fatto in qualsiasi momento negli ultimi due decenni». Abbiamo iniziato a interrogarci sul peso del lavoro nelle nostre vite, su quello che significa per noi. Quello che davamo per scontato, non lo è più. Nelle mail firmate da tutto il team, i dipendenti scrivono ai loro capi che lo smartworking li ha resi più felici. Anche questo è un grande cambiamento: da quando presumiamo che alle persone ai vertici possa interessare la nostra felicità? Siamo convinti che condividere l’esperienza scioccante del Covid ci abbia reso più emotivi e compassionevoli. Improvvisamente, pensiamo di avere il diritto di lavorare nelle condizioni migliori per noi, e che nessuno ce lo possa negare.
Un reportage pubblicato nei giorni scorsi dal New York Times, dal titolo “The Office Last Stand”, racconta la situazione della Credit Karma, un’azienda che a settembre, come Apple, ha richiesto il “back to school” dei dipendenti, dopo un’estate di uffici deserti ogni venerdì, ferie d’agosto raddoppiate, lavoratori spariti e mai più tornati. Il chief strategy officer di Topia (azienda leader nella Global Talent Mobility) racconta di una società che a un certo punto ha chiesto ai dipendenti di aggiornare il proprio indirizzo postale per poter inviare loro delle felpe aziendali, scovando persone sparse in tutto il mondo. Ma se la produttività di un dipendente che lavora da una spiaggia della Sardegna è la stessa, se non superiore, di uno che lavora in ufficio a Milano, che problema c’è? Purché lavori: questo scetticismo diffuso nei confronti del dipendente disperso è il motivo per cui alcune aziende che non possono più contare sul timbro del cartellino stanno inasprendo i loro sistemi di tracciamento. Programmi come ActivTrak, Hubstaff e InterGuard acquisiscono schermate dei computer dei dipendenti e registrano il tempo passato effettivamente a lavorare. Secondo un’analisi di Market Research Future, quello del monitoraggio dei dipendenti è un settore che crescerà a dismisura, così come è cresciuto quello delle piattaforme per lavorare a distanza. Non a caso, tra i più entusiasti sostenitori del remote working c’è Chris Herd, che nel 2018, a 31 anni, ha profetizzato lo smartworking (anche lui) creando Firstbase, una piattaforma per creare business completamente online: «Start and grow a US business from anywhere» (qui intervistato dal New Yorker). Anche per lui lavorare a distanza è più meritocratico: conta il talento e quello che sai fare. Senza la limitazione di uno spazio fisico, ogni azienda potrebbe assumere le menti perfette per le sue esigenze, anche se stanno dall’altra parte del mondo.

Che è anche il motivo per cui sarà molto difficile frenare la trasformazione in atto: per i lavoratori più bravi, trovare un’altra azienda pronta ad assumerli con condizioni più flessibili diventerà sempre più facile. E per i meno bravi, quelli stufi e stanchi di tutto? Restano due possibilità. Entrare a fare parte del nutrito gruppo della Great Resignation, ovvero dimettersi e cambiare vita. Oppure entrare nella modalità diventata virale su TikTok, il “Quiet Quitting“, ovvero ritirarsi lentamente dall’overworking facendo il meno possibile, imparando a mettere una distanza tra sé e il lavoro, magari cercandone un altro ma con molta, moltissima calma. Con un rischio: che i capi entrino in modalità “Quiet Firing”. E invece di fornire al dipendente un feedback onesto e consigli per migliorare, comincino a tollerarlo e ignorarlo silenziosamente, attendendo che si senta abbastanza demoralizzato da andarsene da solo. Modalità passivo-aggressive che non fanno bene a nessuno, scrive Fortune. «Realtà che esistono da decenni», scrive la Bbc, «ma la loro ritrovata popolarità la dice lunga sul nostro attuale rapporto col lavoro».

La donna che viaggia da sola per ritrovare sé stessa è un luogo comune che passa per Mangia, prega, ama e arriva fino alle solo travel influencer di oggi, anche se continua a nascondere un suo lato oscuro di disagio e delusione: forse, per godersi davvero il viaggio, sarebbe meglio partire già ritrovate.

La campagna pubblicitaria di American Eagle è stata indubbiamente efficace: i liberal di tutto il mondo hanno abboccato alla provocazione e i conservatori hanno colto al volo l'occasione per ribadire che non si può più dire niente.





