Già il videogioco più discusso dell'anno, la nuova opera del game designer giapponese segna un cambiamento radicale della sua poetica: da sempre un ottimista, adesso anche lui sembra essersi rassegnato al peggio.
Parlare della fine del mondo con William Gibson
Intervista allo scrittore padre del Cyberpunk, inventore di mondi dove macchine e umani si incontrano e si scontrano. Dal numero Behind The Screen in edicola.

Mentre sto scrivendo questo articolo, il razzo di una società privata, la Space X di Elon Musk, sta partendo da Cape Canaveral con un equipaggio umano per raggiungere la stazione spaziale internazionale. Per molti è l’inizio della “privatizzazione dello spazio”, la fine del monopolio delle grandi potenze statuali sui voli oltre l’atmosfera. Nello stesso momento l’uomo più ricco del pianeta, Jeff Bezos, sta diventando ancora più ricco grazie al commercio elettronico durante il lockdown per la pandemia del Covid-19 (nelle 11 settimane di blocco ha guadagnato 32 miliardi di dollari; potrebbe diventare il primo trilionario della storia): è così ricco che ha pensato bene di investire anche lui nella corsa spaziale con una sua società, la Blue Origin. Nello stesso momento le strade delle città americane sono attraversate dalle proteste per l’omicidio di George Floyd da parte della polizia. Il soffocamento di Floyd è stato ripreso da una nuvola di smartphone e telecamere di sorveglianza e il video ha fatto il giro dei social network. Nello stesso momento il presidente Donald Trump getta benzina sul fuoco delle proteste incitando governatori e polizia a rispondere a muso duro. Nello stesso momento l’Italia sta uscendo con passo malfermo da mesi di quarantena dirigendosi verso un incerto futuro fatto di crisi economica e distanziamento sociale. Tutto accade contemporaneamente, o almeno dà quest’impressione: tutto è visibile, tutto scorre davanti ai nostri occhi spalancati in un flusso senza fine di notizie, stimoli, segnali, tutto entra nel nostro sistema nervoso, altera il nostro umore, si mescola e si confonde in un segnale indistinto, come «un televisore sintonizzato su un canale morto». Sembra che il 2020 ci tenga con particolare acribia a ricordarci che viviamo in un “continuum temporale” uscito da un romanzo di William Gibson.
Pochi scrittori viventi possiedono la stessa aura di cui gode Gibson perché nessun altro come lui ha il potere misterioso di farti percepire la contemporaneità. Non solo perché sa raccontare la complessità del mondo contemporaneo. Ma perché riesce a catturare la contemporaneità degli eventi, il fatto che tutto sembra accadere nello stesso momento. I suoi libri ricreano in forma letteraria lo shock cognitivo in cui siamo costantemente immersi: quel disturbo post-traumatico a cui diamo il nome di presente. Cavalieri elettrici in una foresta di simboli digitali, i suoi eroi sono quelli che sanno leggere meglio il flusso di informazione, trovarci un filo e seguirlo, come rabdomanti, sciamani, «cow-boys dell’interfaccia».
Quello che io ho chiamato “una foresta di simboli digitali” ha un nome: è il cyberspace. La parola che nel tempo è diventata sinonimo di rete è stata coniata da William Gibson in un racconto del 1981, “La notte che bruciammo Chrome”. «Un’allucinazione condivisa», «lo spazio tra due telefonate», l’idea di ciberspazio verrà sviluppata nel primo romanzo di Gibson, Neuromante. Uscito nel 1984, due anni dopo Blade Runner, è la storia di una rapina che si svolge su due piani, online e nella realtà fisica. Atmosfere hard-boiled e iconografia giapponese, argot informatico inventato e sensibilità neo-romantica, visionaria estrapolazione delle politiche neoliberiste e avventura sensuale e disperata, Neuromante è uno dei romanzi più importanti degli ultimi quarant’anni: è il seme da cui è gemmato uno degli immaginari più diffusi e potenti, il cyberpunk, che ha contagiato qualsiasi forma espressiva e artistica, dalla letteratura ai videogiochi, dal cinema (basti pensare a Matrix) all’animazione, dai manga (con titoli altrettanto fondamentali come Ghost in the Shell e Akira) al design, dall’architettura alle serie tv (la terza stagione di Westworld è la miglior trasposizione non ufficiale di un romanzo di Gibson). Il cyberpunk è stato l’ultimo movimento che aveva al suo centro un’idea di futuro. E quest’idea era: il futuro è morto.
Nessuna cultura ha mai immaginato la sua “fine del mondo” come un processo lento e graduale
Il futuro io l’ho visitato nel 1993: la prima volta che sono stato su internet. Oggi suona strano dire “vado su” internet: la rete è una nuvola costante di device dentro cui ci muoviamo, sono i dati che generiamo anche quando ci pesiamo o usiamo il Telepass, non è qualcosa di cui facciamo esperienza solo davanti a uno schermo, o comunque di diverso dalla “vita vera”. Nel 1993 in Italia non c’erano ancora dei veri e propri provider che permettessero di andare direttamente nella «rete delle reti», come si diceva allora, né del resto il web e i browser erano molto diffusi: ci si collegava a una Bbs (un sistema telematico che connetteva tra di loro una piccola serie di computer) e attraverso di essa si potevano fruire alcuni dei protocolli dell’internet di allora come Ftp, gopher, telnet (esistono ancora oggi, immagino, ma ovviamente il www li ha resi per la maggior parte obsoleti). Ricordo l’emozione quando, dopo non pochi tentativi, riuscii a entrare in un server Ftp di un’università americana. Seguendo l’albero delle directory, ne trovai una con dei racconti di Gibson che qualcuno aveva ricopiato in un file txt. Fu la prima cosa che scaricai da internet nella mia vita. Il primo bottino che riportai a casa dopo aver scorrazzato dall’altra parte del mondo.
Il suo primo romanzo, Neuromante, è uscito quando Gibson aveva trentasei anni. Nato nel 1948 in Tennessee, ma dopo la morte del padre quando lui era ancora un bambino, cresce in un piccolo paese in Virginia, dove la madre apre una libreria. Da ragazzo, invece di finire il liceo, scappa a Toronto per unirsi con una comune hippie. Poco prima dei trenta, però, conclude gli studi laureandosi in Letteratura all’università della British Columbia. I primi racconti, ispirati tanto da Burroughs e le avanguardie europee quanto dai romanzi visionari di un altro grande della fantascienza, Samuel Delany, vengono pubblicati in rivista all’inizio degli anni Ottanta. Ma è Neuromante a decretarne il successo e farne un fenomeno culturale: finisce sulla copertina di Wired, gli U2 avevano intenzione di proiettare l’intero testo del libro durante i concerti di Zooropa (del resto il disco è ispirato alle atmosfere gibsoniane), negli anni Novanta viene presentato come lo scrittore che «aveva predetto internet». Seguiranno altri dieci romanzi, ambientati via via in un tempo sempre più vicino al presente: Pattern Recognition (L’accademia dei sogni, Mondadori) è addirittura ambientato l’anno prima della sua pubblicazione, il 2003, eppure Gibson ha questa capacità pazzesca di far apparire fantascientifico il presente, e quotidiano il futuro. Oggi ha settantadue anni, i modi gentilissimi e la voce flebile in cui la saggezza raggiunta si intreccia a una mai sopita ironia.

Artwork dell’artista australiano law_degree, rielaborato dalla piattaforma multimediale NO TEXT Azienda
«Per quanto ne so», mi dice Gibson, «nessuna cultura ha mai immaginato la sua “fine del mondo” come un processo lento e graduale. Nei miei romanzi dura più di un secolo, almeno». Poche settimane prima della pandemia è uscito negli Stati Uniti il suo ultimo romanzo, Agency, non ancora tradotto in italiano. È il seguito di Inverso del 2014 (in italiano per Mondadori. Tutti le opere di Gibson possono essere divise in trilogie). Questi ultimi due sono ambientati in un mondo in cui è accaduto un evento noto come jackpot: una sorta di apocalisse “a rate”, dilazionata nel tempo, una fine del mondo con tante cause diverse, tante motivazioni divergenti: «un processo lento e che è interamente colpa nostra. Mi sembra questa la natura dell’apocalisse con cui dobbiamo fare i conti, che dobbiamo guardare in faccia». C’è una frase molto famosa di Gibson che fa «il futuro è già avvenuto, ma non è ancora arrivato dappertutto». Ecco, si potrebbe applicare anche alla fine del mondo: la fine del mondo è già arrivata, ma a rate. Mi sembra una definizione perfetta per quello che sta avvenendo: cambiamento climatico, guerre a bassa intensità ai confini di Russia e Cina, rivolte popolari, cyberwar, e adesso le pandemie. «Il jackpot lo chiamo così perché è l’inizio del “payoff”, la ricaduta, il risultato di tutto l’insieme di attività tecnologiche umane a partire, diciamo, dall’inizio del XIX secolo».
Quando me lo dice penso che non sia un caso che il suo romanzo del 1990, La macchina della realtà scritto insieme a Bruce Sterling e che ha dato il via allo spin-off del cyberpunk noto come steampunk, fosse ambientato proprio nell’Ottocento. «Il punto è che all’inizio non eravamo consapevoli degli effetti collaterali di queste tecnologie. Non eravamo consapevoli, per esempio, che l’avvento dell’onnipresente uso della plastica avrebbe minacciato la vita negli oceani, o che alcuni insetticidi avrebbero rischiato di provocare l’estinzione delle api, o che l’uso incontrollato e a cuor leggero degli antibiotici, dopo molti decenni, avrebbe portato all’evoluzione di ceppi resistenti ai farmaci di quelle stesse malattie per cui abbiamo usato gli antibiotici all’inizio». È questo il senso dietro a quel «non è ancora arrivato dappertutto»: è la consapevolezza a non essere distribuita in maniera omogenea nel tempo e nello spazio. «Il jackpot, che come l’immagino nei miei romanzi alla fine riduce la popolazione del pianeta dell’80 per cento, è quest’insieme di tutti i risultati inattesi delle tecnologie e della loro onnipresenza. Come quando nelle slot-machine escono tutte ciliegie: un insieme che minaccia la nostra specie anche se già non lo facesse il cambiamento climatico». Gibson fa una pausa, poi riprende: «Quel che è cambiato è che oggi non c’è più spazio per la negazione. Oggi questa catastrofe lenta, multi-causale (sebbene interamente antropogenica, causata dall’uomo), diventa innegabile e ovvia per tutti di noi. Credo che siamo a questo livello, ormai, e che trent’anni fa non lo eravamo». Come si inserisce la pandemia di Covid-19 in tutto questo? «In Inverso e Agency ci sono già dei riferimenti alle pandemie, al plurale. Quella di Covid è la prima pandemia globale del jackpot e non c’è motivo di pensare che sarà l’ultima. Al contrario. Il terzo volume della “trilogia del jackpot” affronterà anche il Covid: ma non posso ancora dire come».
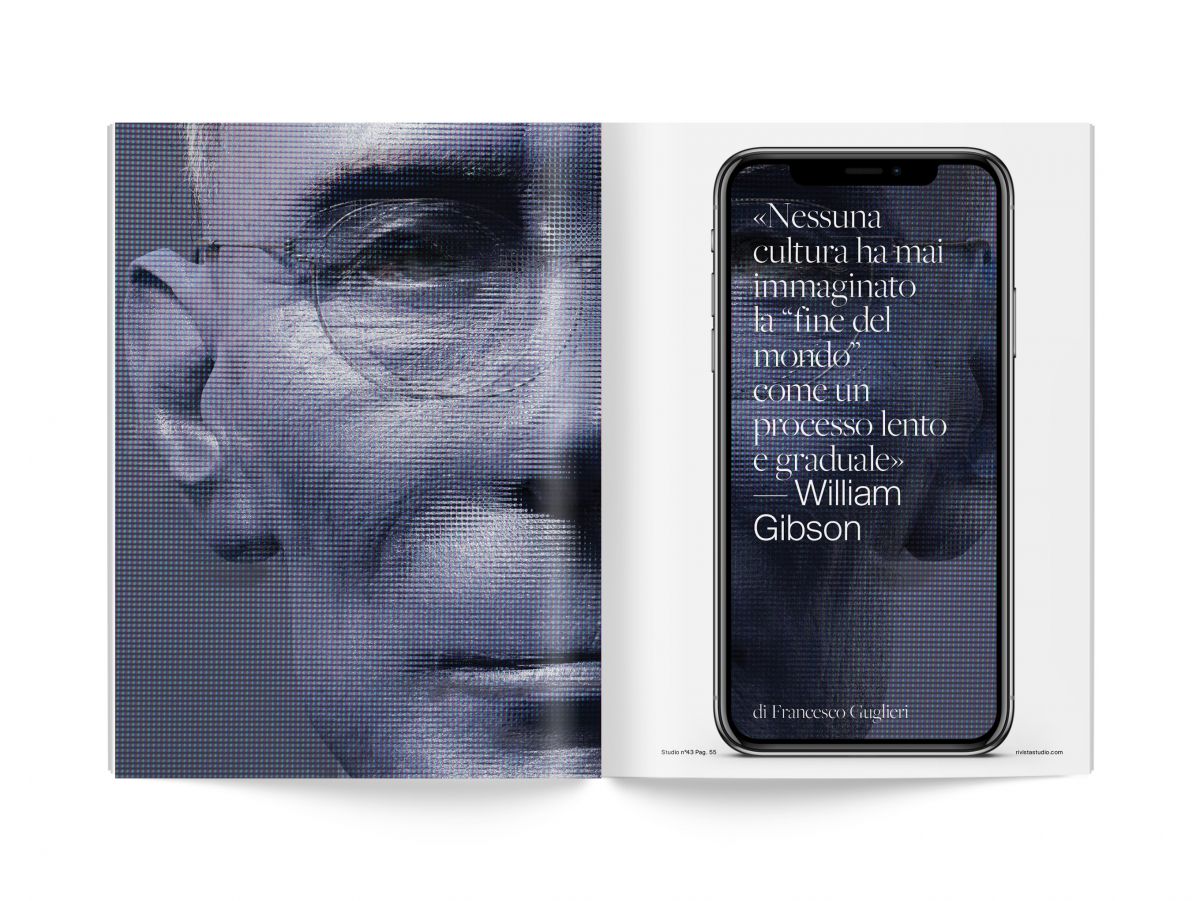
Viviamo in un mondo cyberpunk, i romanzi di Gibson si possono leggere come autentici manuali d’istruzione della nostra realtà. Ovviamente non si tratta di profezie: gli scrittori non sono profeti, neanche quelli di fantascienza. Gibson ha saputo vedere, con una precisione e un’intensità sconosciuta alla maggior parte dei suoi colleghi, una realtà che era già in potenza, lì, all’inizio degli anni Ottanta, nei corpi presenti ma assenti dei ragazzini smanettanti davanti a un videogioco arcade, dal diventare personal della musica portata in giro dentro un walkman. Non è un caso che alcuni storici parlano di «lunghi anni Ottanta»: allora è iniziato un periodo storico che, forse, solo il Covid sarà in grado di chiudere. Negli Ottanta si sono definiti rapporti di forza tra occidente e oriente, è emersa l’Asia come attore politico e centro dell’immaginario, hanno preso piede le identity politics. Ma soprattutto si è assistito al ritirarsi dello Stato a favore delle corporation. Quelli di Gibson sono mondi senza Stato, in cui il controllo della forza è detenuto da una super-classe di ricchi e da industrie tecnologiche tanto misteriose quanto ramificate, come la famiglia Tessier-Ashpool in Neuromante i cui membri passano la maggior parte del tempo in sospensione criogenica in una stazione orbitale. Le attuali Big Five tecnologiche hanno bilanci grossi il Pil di interi paesi, e hanno un peso politico che le rende più simili a degli autentici stati sovrani che a un’azienda.
C’era una certa compiaciuta fiducia che il cambiamento fosse una cosa buona di per sé. Mi colpiva – e mi lasciava ancora più perplesso – notare come le persone che più sostenevano queste opinioni erano anche dei fan dei miei romanzi
Mi colpisce sempre come sia cambiato profondamente il nostro approccio alla rete, il giudizio su di essa. Negli anni Novanta sembrava che internet fosse il più grande strumento di emancipazione della storia. Oggi, dopo esserci affidati mani e piedi prima di capirlo veramente, ci appare in tutta la sua complessità, anche minacciosa. Se c’è una cosa che abbiamo imparato a fare durante il lockdown è “parlare con le macchine”. Siamo stati più di frequente su Zoom o altri servizi di videocall. Abbiamo consultato più spesso i social network in cerca di notizie. Abbiamo chiesto ai nostri assistenti virutali di accendere la luce o mettere una canzone – o, nei momenti di depressione abissale, di raccontarci una barzelletta. Tutte cose che facevamo anche prima, ovviamente: ma con il lockdown le facciamo ancora di più. La nostra vita, la nostra esperienza è ancora più mediata dalle macchine. La fantascienza è sempre stata piena di situazioni in cui si parla con le macchine (robot, androidi e compagnia bella): nei libri di Gibson viene fuori per la prima volta l’idea che non saranno solo le macchine a essere più simili agli esseri umani, ma saranno anche gli esseri umani a farsi più simili alle macchine. Ci stiamo incontrando a metà strada. Un autista di Uber che riceve gli ordini da un algoritmo e ci si deve attenere, io che quando parlo con Alexa assumo un altro tono di voce, un giornalista che immagina il suo articolo già in vista del Seo: iniziamo a pensare come loro per poter meglio adattarci all’ambiente in cui conviviamo con le macchine. «Questo è un altro risultato della nostra incapacità di anticipare gli effetti collaterali negativi di una tecnologia onnipresente. Io per primo ero sempre a dir poco perplesso per l’assenza, negli anni Novanta, di scenari meno che ottimistici sullo sviluppo della rete. La parola “disruption” era sulla bocca di tutti, la distruzione del mondo come lo conoscevamo era una prospettiva di cui tutti sembravano ben lieti. C’era una certa compiaciuta fiducia che questo cambiamento fosse una cosa buona di per sé. Mi colpiva – e mi lasciava ancora più perplesso – anche notare come le persone che più sostenevano queste opinioni erano anche dei fan dei miei romanzi! Eppure io ho sempre fatto di tutto per descrivere i risultati complessi e problematici di quelle tecnologie che hanno finito per assomigliare a internet». Proprio in quegli anni Gibson disse che «la strada trova i suoi usi per le cose»: «intendevo dire che gli sviluppatori di tecnologie emergenti sembrano incapaci di indovinare gli effetti negativi delle loro innovazioni nel momento in cui si diffondono e ci mettono le mani sopra molte persone, sia buone che cattive. Tutto questo mi sembrava ovvio, e devo dire che gli esiti successivi mi hanno convinto ulteriormente di tutto ciò».
«Gli effetti a lungo termine di questa pandemia non sono prevedibili ora», conclude Gibson, «poiché si sa ancora troppo poco sulla malattia stessa o sulle conseguenze delle nostre strategie per affrontarla». Durante i mesi del lockdown ci chiedevamo ossessivamente come sarebbe stato il futuro. La forma che avrebbe preso. Era un modo per quarantenare la paura, costruire intorno all’ignoto degli argini, delle transenne a cui aggrapparsi. Perché il futuro sembrava – sembra – qualcosa di incombente e sconosciuto, una minaccia straniera pronta a invaderci. Invece, ed è quello che ha fatto William Gibson in ogni suo libro, dovremmo ricordarci che il futuro è già qui, intorno a noi. Dentro di noi. Dobbiamo solo guardarlo attentamente. Saperlo riconoscere quando arriva.

Il regista inglese torna alla saga che lo ha reso famoso e decide di stravolgerla: il risultato è un film d'autore, horror ma anche politico e sentimentale, che disattende tutte le aspettative e che ha diviso i fan.





