La nuova serie della creatrice di Girls è piena di difetti ma ha un pregio che da solo quasi basta a redimerla: rende bene l'idea di che cosa terribile siano le relazioni oggi.
L’inutile bellezza del fact-checking
L’ossessione giornalistica per i fatti, nell’era in cui contano sempre meno, tra post-truth, populismi e filter bubble.
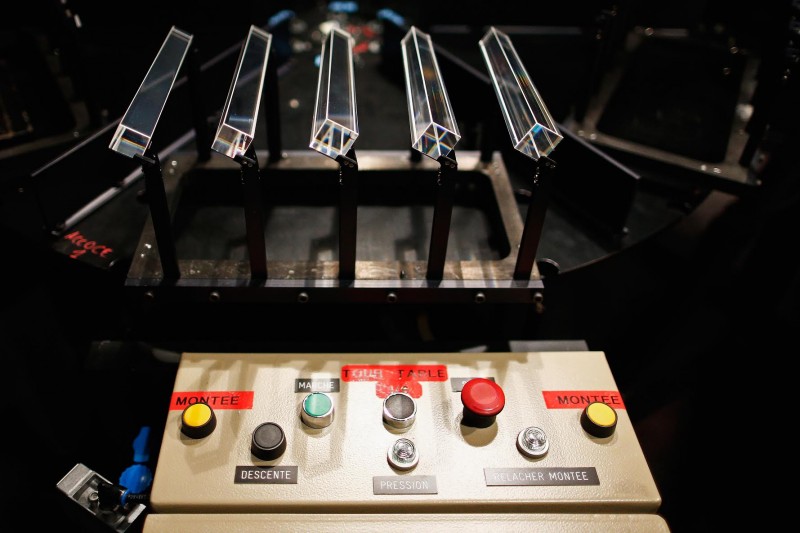
Nel 2014 si svolse a Londra la convention mondiale dei fact-checker. Mentre un redattore di PolitiFact, testata specializzata in fact-checking, teneva un discorso motivazionale sul «potere restituito ai cittadini, rimasti in una posizione di svantaggio nel libero mercato del dibattito politico», un giornalista italiano fece una domanda: questa cosa ha un impatto? Esistono dati concreti, fatti, che dimostrino che mettere a nudo menzogne e inesattezze aiuti ad arginarle? Due anni dopo, è stato eletto presidente degli Stati Uniti un candidato le cui dichiarazioni sono state valutate sette volte su dieci «false», «completamente campate in aria» o «prevalentemente false» da PolitiFact (stime di siti analoghi cambiano di poco). I cittadini del Regno Unito hanno votato per lasciare l’Unione europea grazie a una campagna pro-Brexit in gran parte incentrata su un dato falso: «Ogni settimana diamo 350 milioni di sterline a Bruxelles». Secondo un recente sondaggio di Ipsos la maggioranza degli italiani è convinta che nel nostro Paese ci siano più di 15 milioni di immigrati, un quarto della popolazione (sono l’otto per cento), ed è probabile che percezioni di questo genere abbiano un impatto nelle decisioni elettorali. È evidente che il divorzio tra realtà e politica è un fatto compiuto.
C’è chi dà la colpa a Internet, alle bufale che rimbalzano sui social più delle notizie vere. Altri hanno fatto notare, già in tempi pre-Facebook, che si tratta di un divorzio inevitabile, non tanto per la vulgata populista secondo cui “i politici sono tutti bugiardi”, ma per la natura intrinseca del dibattito politico: se conta l’opinione della maggioranza, allora è consequenziale che la percezione dei fatti abbia un impatto maggiore dei fatti stessi. A meno che non si voglia pensare che esista una “mano invisibile” che porti all’auto-regolamentazione del “mercato delle idee”, nulla fa pensare che, dove c’è dibattito, debba prevalere per forza l’idea corretta: al contrario, per citare Hannah Arendt, la verità «preclude il dibattito». Resta da chiedersi se questa ossessione dei media di qualità per i fatti sia l’ennesima conferma della distanza che separa il giornalismo dal mondo reale, oppure l’ultimo baluardo dell’obiettività in un clima sempre più “post-truth”, o più semplicemente una reazione a esso.

Il fact-checking come genere giornalistico è una creatura relativamente recente. I giornali anglosassoni, certo, hanno sempre fatto fact-checking, inteso come routine consolidata di controllare dati, fatti e affermazioni riportati in un articolo prima di pubblicarlo. Quello che è avvenuto nell’ultimo decennio, però, è l’inizio di un processo inverso, giornalisti concentrati nel verificare numeri e dichiarazioni dopo la loro pubblicazione: un fenomeno che ha iniziato a prendere piede tra il 2003 e il 2007, con la nascita di FactCheck.org e del blog Fact Checker sul Washington Post; per poi esplodere nei primi anni Dieci: le vicende sono raccontate da Lucas Graves, docente di comunicazione all’università del Winsconsin, in Deciding What’s True: The Rise of Political Fact-Checking in American Journalism. Il saggio è stato a pubblicato dalla Columbia University Press a giugno, ma se ne è parlato parecchio in queste ultime settimane, a ridosso della vittoria di Trump e del dibattito sulla “post-verità”. Che senso ha fare fact-checking in un’era di disinformazione di massa, dove «la debolezza dei fatti è al cuore del problema»?, domandava in una recensione il Washington Post. Il fact-checking piace ma è, evidentemente, ininfluente.
Lo scorso 15 novembre Oxford Dictionaries ha dichiarato parola dell’anno “post-truth”, un «aggettivo che denota circostanze in cui i fatti obiettivi sono meno influenti nel formare l’opinione pubblica, rispetto alle emozioni e alle convinzioni personali». Il concetto non è nuovo, ha spiegato, ma s’è diffuso nel 2016 grazie alle elezioni americane e al referendum nel Regno Unito: «La parola “post-truth” è passata dall’essere circoscritta ai commentari politici all’essere utilizzata nei titoli delle grandi testate senza il bisogno di spiegazioni». Oxford Dictionaries dice che la parola è apparsa per la prima volta nel 1992, in un articolo di Steve Tesich su The Nation. Ma per molti “media-nerd” il concetto è iniziato a circolare una decina di anni fa, quando alcuni commentatori tecno-scettici hanno cominciato a riflettere sul fatto che la diffusione di Internet potesse indebolire il nostro rapporto con la realtà. Nel 2008 Farhad Manjoo ha pubblicato il saggio True Enough: Learning to Live in a Post-Fact Society: «Ora che abbiamo dissolto l’informazione mainstream in tante nicchie circondate da filo spinato, ora che ognuno di noi ha iniziato a creare e diffondere la proprie immagini e suoni, abbiamo spianato la strada alla propaganda, che ha contagiato la nostra scrittura».

È un discorso che abbiamo sentito spesso, che parte da quello che i sociologi definiscono confirmation bias, la tendenza umana a cercare le informazioni che confermino le nostre idee preconcette, e arriva alla filter bubble, la condizione in cui l’esposizione alle idee che confermano i nostri preconcetti è un processo automatico, a causa degli algoritmi che ci fanno vedere le cose più conformi ai nostri gusti. Gli esseri umani tendono a vedere quello che vogliono vedere; un tempo però erano i media a scegliere cosa farci vedere, al massimo si poteva scegliere se guardare un tg di destra o di sinistra, ma c’erano un controllo editoriale e una gerarchia dei contenuti; con Internet invece siamo noi a selezionare ogni singolo contenuto su cui cliccare, così la gerarchia salta; coi filtri dei social media, poi, viviamo in una bolla dove la selezione in base ai nostri gusti è addirittura preventiva; così ci ingozziamo di cliché o di bufale, e il risultato è che ci ritroviamo leader come Trump: questa, riassunta per sommi capi, è l’argomentazione di chi sostiene che Internet ha creato un mondo post-verità (il Guardian titolava “How technology disrupted the truth”). Se è vero che la rete ha esacerbato la tendenza umana a vedere ciò che si vuole vedere, è anche vero che ha amplificato un altro comportamento, altrettanto umano e pre-Internet: esprimere opinioni e discuterne. Paradossalmente, anche questo aiuta a capire l’evaporazione dei fatti.
«Mai come oggi la verità fattuale è stata recepita con ostilità»
Nel 1967 Hannah Arendt ha pubblicato sul New Yorker il saggio intitolato Verità e politica (tradotto in Italia da Bollati Boringhieri) che ha anticipato per alcuni versi il dibattito odierno sulla post-verità: «Mentre probabilmente nessun’altra epoca storica ha tollerato tante opinioni diverse, mai come oggi la verità fattuale è stata recepita con tanta ostilità», scrive. Certo, i regimi totalitari hanno una forte predisposizione a osteggiare i fatti, sostiene Arendt, tanto che nell’Urss parlare dei gulag è più rischioso che esprimere un’opinione dissidente, ma anche nelle democrazie i fatti non hanno vita facile. Il problema è che «il pensiero politico è rappresentativo», si basa cioè sul «concordare dei molti», dunque sul dibattito e sulla capacità di convincimento. Mentre la verità è l’esatto opposto, è «di natura dispotica»: un fatto è o non è, non c’è nulla da dibattere. Anche nel «concordare dei molti», può capitare che la verità s’imponga; ma avviene raramente, perché «chi mente è spesso più convincente» (la filosofa non condivideva l’idea di un “mercato delle idee” dove la ragione s’imporrebbe a forza di numeri, che poi è l’argomentazione di chi dice che “gli svarioni di Wikipedia vengono sempre corretti perché ci sono tanti utenti”; o di chi sostiene che “le bufale hanno vita corta perché ci sono fact-checker”, altra variante della “mano invisibile” di Internet).
Anche quando la verità prevale, prosegue, è «una vittoria di Pirro», perché significa che s’è imposta in quanto opinione più convincente, non in quanto verità «al di là del dibattito». Anche dove c’è libertà d’espressione, lamenta la filosofa, i fatti sono ridotti a opinione, a un flebile «mi pare che» (Arendt citava la caverna di Platone, ma l’espressione che utilizza, “it seems to me”, evoca i tic che la linguista Sally McConnell-Ginet ha notato tra i Millennial che discutono di politica online, tutto un fiorire di “impressioni” e “opinioni”, quasi ci fosse da vergognarsi a parlare di fatti: «Tutti dicono “It feels to me”, c’è un relativismo dilagante: va bene riconoscere che esistono punti di vista, ma siamo sempre meno ancorati ai fatti»).
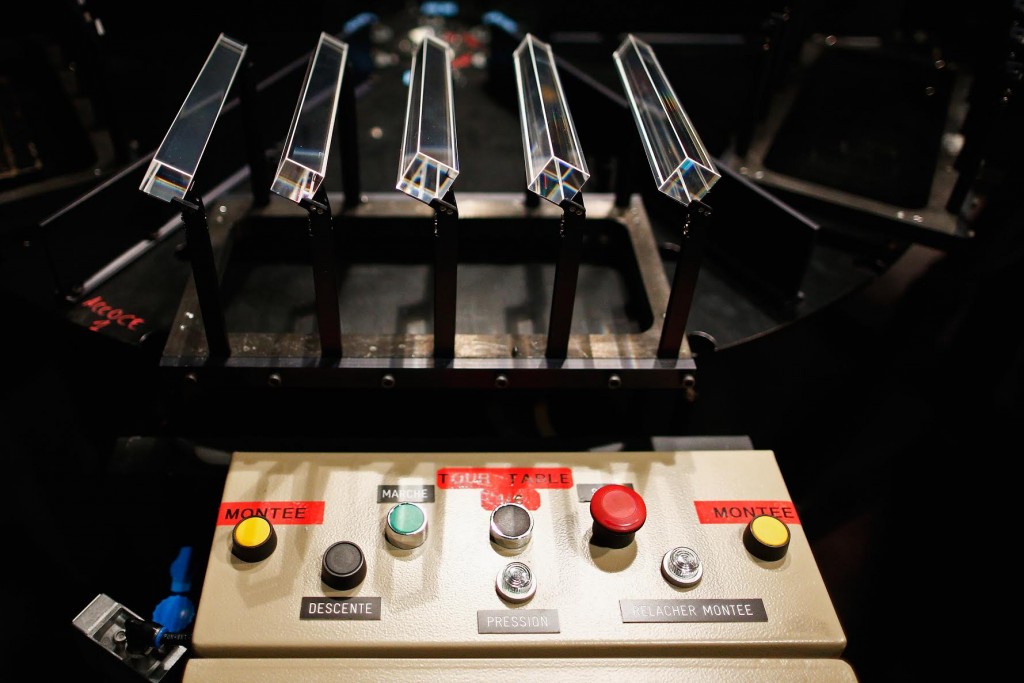
Se la politica è rappresentativa e dunque dibattito e dunque opinioni, allora tocca ammettere «la natura anti-politica» della verità. È un’osservazione attuale, perché solleva questioni non solo sul clima di post-verità, ma anche sui populismi che da esso traggono forza. Ad alcuni piace bollarli come para-fascisti e nemici della libertà d’espressione, invece sono lo specchio di dibattito incessante e amplificato, dove ogni idea viene espressa e ha un peso. Quasi un eccesso di libertà di espressione e di rappresentatività, dove cento cittadini che dicono che i vaccini causano l’autismo contano più di dieci scienziati che dicono che non è vero. Se la verità è «anti-politica» perché trascende il dibattito, allora il populismo dell’uno-vale-uno non è affatto anti-politica: è iper-politica.
Tutte le democrazie degne di questo nome hanno strumenti volti ad assicurare che la volontà/opinione dei più non si trasformi in dittatura della maggioranza: costituzioni, diritti inalienabili, poteri separati che vigilino l’uno sull’altro. Secondo Arendt però la tensione tra politica e verità «solleva la questione se il potere possa e debba essere controllato non soltanto dalle costituzioni e dal potere stesso, ma anche qualcosa di esterno». La verità, i fatti sono esterni alla democrazia. Il problema doppio è chi decide cosa è vero, quando nessuno sembra concordare sui fatti, e che valore ha decidere cosa è vero, ora che i fatti contano sempre meno. Con tutti i limiti del caso e nonostante la loro ininfluenza, i fact-checker si sono appropriati del ruolo di «decidere che cosa è vero» scrive Graves nel suo saggio. Scrivono per un «pubblico idealizzato di cittadini affamati di verità» per poi scontrarsi «scontrarsi quotidianamente con il vero pubblico» che di realtà non è poi così affamato. Il loro è un lavoro bello, cocciuto e, forse, inutile.






