Se avete la carnagione molto chiara o siete amanti di videogiochi, potrebbe essere la grande occasione per esordire al cinema.
Paolo Giordano, uno scrittore nel 2020
Negli ultimi mesi ha scritto una serie di articoli e un pamphlet per l'emergenza coronavirus, un racconto per il New York Times e adesso esce la serie di Luca Guadagnino di cui è stato co-autore. Abbiamo parlato con lui di quest'anno strano ed eccezionale, di libri di successo e di impegno degli intellettuali.

Sembra che Paolo Giordano abbia molte vite o molte personalità, per quanto all’apparenza dia l’idea di essere una persona integra, rigorosa e in equilibrio, quello che si chiama “un esperto”. Nel 2008, il suo esordio, La solitudine dei numeri primi, è stato un best-seller da due milioni e mezzo di copie e l’ultimo grande successo di massa della narrativa italiana, ma dopo, da un punto di vista letterario e forse non solo, lo scrittore sembra essersi nascosto, imbarcandosi in romanzi se non di nicchia, sicuramente più difficili (Il corpo umano, Il nero e l’argento, Divorare il cielo), come se assurdamente avesse voluto ricostruirsi una credibilità che quel primo successo aveva reso impossibile. Questo è stato invece un anno in cui è uscito più fuori. Innanzitutto per il suo ciclo di articoli sull’emergenza coronavirus, apparsi sul Corriere da febbraio a oggi e poi diventati il pamphlet Nel contagio (Einaudi), tradotto e “adottato” in molti Paesi. La sua visibilità su questo fronte gli ha permesso poi di essere invitato al prestigioso progetto di un nuovo “Decameron” pubblicato sul New York Times Magazine. In ultimo, proprio questa settimana uscirà la serie di Luca Guadagnino, We Are Who We Are, di cui è stato co-autore. In questa lunga chiacchierata abbiamo parlato delle sue numerose vite, di quest’anno strano, ma anche del passato e più in generale del paesaggio culturale italiano.
ⓢ Come ti è venuto l’impulso di scrivere in quei giorni quel primo articolo che ha dato poi origine al libro Nel contagio e anche un po’ a una tua nuova veste?
È stato molto istintivo come gesto, neanche con tanto tempo per ponderarlo. Era da gennaio che tenevo d’occhio la situazione in Cina. Sono entrato in uno stato di preallerta. Avendo un po’ nel passato non dico studiato ma sicuramente letto cose a proposito delle ultime epidemie, avevo un sensore attivato rispetto al famoso big one che gli scienziati attendevano. Anche l’ultimo romanzo (Divorare il cielo, ndr) era ambientato durante l’epidemia degli ulivi in Puglia, quindi era un set mentale in cui mi trovavo. Quando c’è stato poi il weekend in cui è stato scoperto il primo focolaio, a fine febbraio, si diceva ancora tutto e il contrario di tutto, c’era molta confusione e io ho proprio sentito lì che bisognava fare un’azione di forza contro questa confusione, contro il proliferare di idee opposte che erano anche all’interno della comunità scientifica. Ho sentito che il mio apporto in quel momento poteva essere di mettere un piccolo seme di comprensibilità del fenomeno. E ho scritto e ho continuato a scrivere, fino all’ultimo articolo di qualche giorno fa, in un modo in cui non avevo mai scritto. Non ho mai scritto in un modo emergenziale, sono sempre stato lento. Invece questa volta ho lasciato andare un canale più reattivo, ed è stata un po’ una scoperta anche per me.
ⓢ In Italia si è sempre molto parlato di impegno degli scrittori o degli intellettuali ma lo si è sempre inteso come un impegno politico molto diverso rispetto a quello che coinvolge un tema come questo. Come si coniuga questo tuo nuovo “ruolo” con l’attività letteraria?
Secondo me in Italia si scambia molto l’engagement con il mettersi insistentemente dalla parte giusta a ogni passo. Sta diventando sempre più una forma di strano conformismo quello dell’impegno politico all’interno dell’attività di scrittura. Io tendo a essere un po’ più parsimonioso su questo. Io penso che nessuno di noi abbia cose interessanti da dire su tutto. Nessuno di noi può avere la stessa presa, lo stesso livello di profondità e di sguardo su tutte le tematiche. Anche se pensi nella tua testa di trovarti dalla parte giusta rispetto a questa o quella tematica, quello secondo me attiene alla tua vita personale, fintantoché tu non hai qualcosa da potere aggiungere al discorso. A me è capitato in questo momento per una combinazione di elementi, appunto una formazione di un certo tipo, un percorso di letture e di studio, anche di scrittura, che mi ha portato a interessarmi a un certo tipo di cose, tutto questo mi ha fatto pensare di avere qualcosa da dire sulla pandemia. Una cosa di cui mi sono accorto moltissimo durante il lockdown è il ruolo assolutamente decorativo che ci è stato perimetrato in questo Paese. Pensa agli scrittori in televisione, ma pensa anche in larga parte agli scrittori sui giornali: ti chiamano per dare un commento emotivo alla situazione, o per condire di un po’ di profondità e poesia un argomento che però viene dibattuto in modo serio da altri. C’è da riflettere su questo, capire perché siamo arrivati a questo, se c’è una corresponsabilità degli scrittori, se anzi questo non puntare a un’efficacia o non avere contezza di ciò che uno è in grado di padroneggiare, quindi di esprimere con una certa profondità rispetto al resto, ci ha portato qui, oppure è stata una marginalizzazione che è venuta da fuori, dai giornali e da tutto il resto.
ⓢ E tu non ce l’hai una risposta?
Tenderei a pensare che è una corresponsabilità: da una parte c’è una compiacenza eccessiva di noi scrittori, un’ansia di posizionarsi sempre dalla parte della ragione, che depotenzia l’aspetto più dirompente di quando uno scrittore prende la parola; dall’altra c’è la tendenza a considerare gli scrittori una cosa innocua, l’idea che gli scrittori vadano in televisione a mostrare il loro libro. Questo mi sembra un momento fertile per rivedere queste posizioni.
ⓢ In questi mesi sono usciti vari diari e romanzi sulla quarantena e altri ne usciranno, tu stesso hai scritto per il progetto “Decameron” del New York Times Magazine un racconto in cui si parla di «infections», qualcosa sullo sfondo riconducibile all’emergenza che abbiamo vissuto, ma secondo te si può fare letteratura sull’attualità, oppure la letteratura ha altri tempi e tutto quello che abbiamo vissuto ha ancora bisogno di elaborazione e di distanza?
È chiaro che ognuno ha risposto a ciò che stava succedendo con la propria sensibilità e in quel momento valevano un po’ tutte le reazioni, ma mi sembra che molto di quello che è stato prodotto nell’immediato evaporerà. In quel mio racconto in realtà il fuoco non è la pandemia ma una situazione famigliare, il rapporto con i figli acquisiti, un momento un po’ cruciale di una coppia rispetto a questo passato di famiglie ricomposte, questo è un argomento che riguarda la mia vita da quindici anni, quindi per trovare il materiale vivo di quel racconto non ho guardato ai giorni della quarantena ma agli ultimi quindici anni della mia vita e la pandemia è stato semplicemente un contesto in cui creare questo racconto da camera. Quello era l’unico livello in cui potessi incorporare in quel momento così presente l’attualità. Ma c’è un problema che riguarda adesso tutti i narratori – scrittori, registi, etc – da questo momento se hai intenzione di raccontare una storia e di farlo nel presente, in un modo o nell’altro ti devi misurare con la cosa, anche solo per decidere di evitarla e quindi di retrodatarla, vuoi fare esistere un mondo senza mascherine, oppure vuoi stare a cavallo, o vuoi stare dopo. In ogni caso ci troviamo di fronte a un fatto molto ingombrante, e lo sarà per un po’ di anni. Non puoi fare finta che non esista, a meno che non vuoi scrivere un romanzo storico. Io romanzi storici non li scrivo, ho sempre scritto romanzi sull’elaborazione del presente. E so che devo prendermi tutto il tempo possibile a trovare una sedimentazione di questa esperienza. Ma non so quanto tempo ci vorrà perché questa cosa deve arrivare a intersecarsi profondamente con la tua vita e le tue scelte e la tua percezione delle cose.
ⓢ La cosa migliore forse è avere iniziato a scrivere prima che succedesse tutto questo.
Io non avevo iniziato però avevo un’idea su cui lavoravo da circa due anni, senza scrivere una riga perché ho questi tempi di incubazione molto lunghi, ma adesso è decisamente saltata in aria. Così mi sto prendendo il vuoto di questa situazione.
ⓢ Come vedi la situazione appunto?
Una delle cose più difficili è che è una situazione che cambia e si aggiorna molto rapidamente. Siamo di nuovo su una salita. Adesso stazionari, ma l’autunno, l’influenza, le scuole, anzi in realtà sta già succedendo, e in altri Paesi europei molto vicini lo vediamo in modo ancora più chiaro e lampante. In molti questo scatena il pensiero che torneremo dove eravamo a marzo, ma le condizioni a contorno sono molto diverse, c’è un monitoraggio attivo che sta funzionando, tutti noi abbiamo un livello di allerta che non è paragonabile a quello che c’era prima, negazionisti compresi, abbiamo una linea di numeri che ci può ricordare una certa situazione ma dentro una situazione completamente diversa. Di nuovo si tratta di accordare il sentire rispetto a questo. Credo che si debba fare un accompagnamento informativo che sa cambiare anche i suoi toni. Il saper accordare il tono rispetto al momento in cui si è, questo è stato un altro dei problemi dei media. L’altro giorno ho riacceso i vari talk show che sono ricominciati. Io li guardavo tantissimo all’epoca. E mi ha fatto un po’ specie riguardare le stesse compagnie di giro nelle stesse trasmissioni con lo stesso approccio di aprile. Mi ha molto inquietato. Intanto mi ha inquietato che la nostra tendenza a creare conventicole arrivi fino a creare delle conventicole pandemiche. E poi mi è sembrato dare un’idea complessiva al Paese sbagliata, come a dire “siamo sempre lì” e invece non siamo sempre lì. La situazione è evoluta e noi dobbiamo evolvere con la situazione.
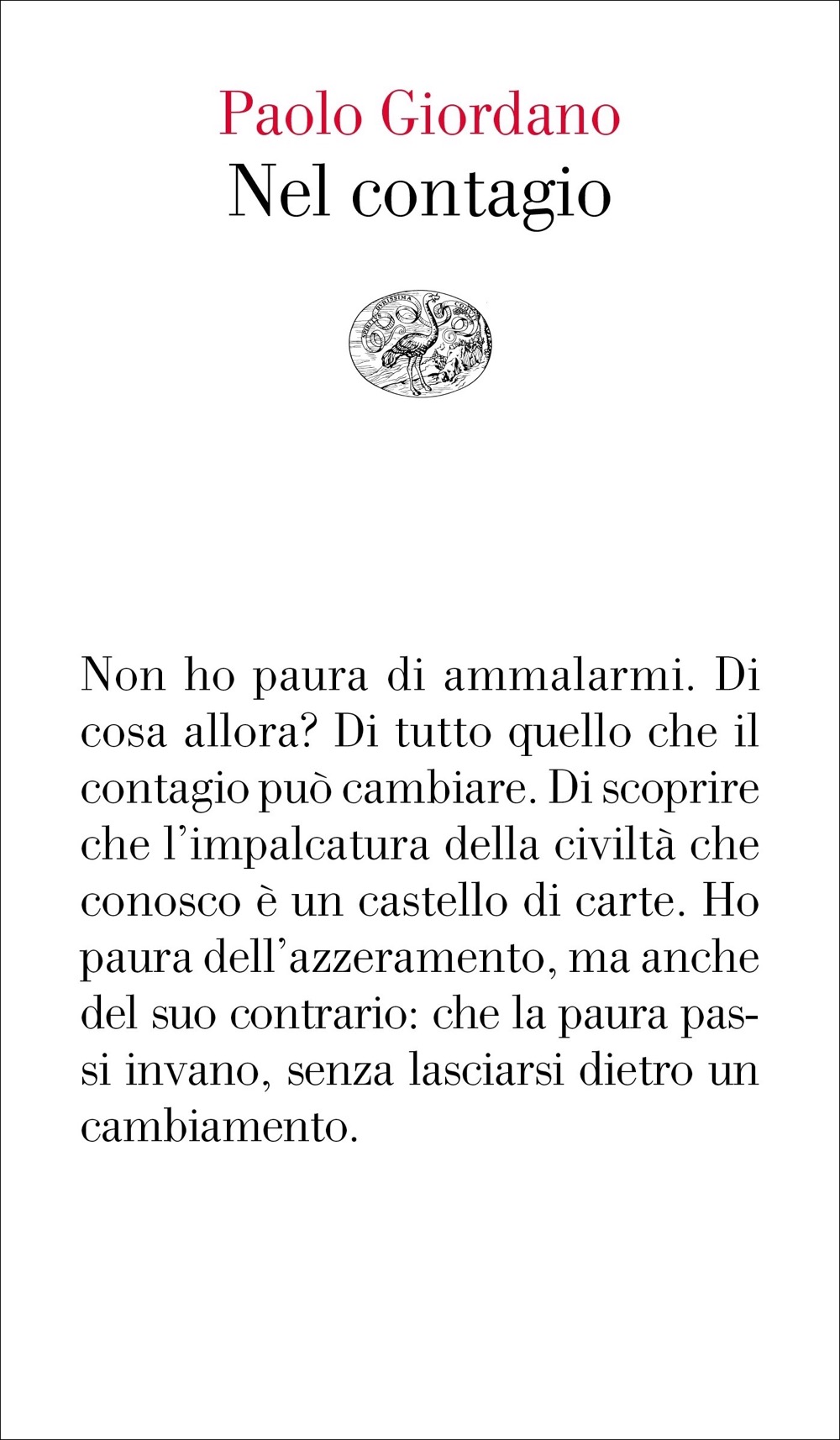
ⓢ Tornando a qualche anno fa, come ci si scrolla di dosso un successo da due milioni e passa di copie come La solitudine dei numeri primi?
Forse decidendo che non te lo puoi scrollare di dosso. Io ho beneficiato enormemente da quel libro. E so che devo a quel punto di partenza anche il fatto di poter parlare di Covid oggi, in parte. Dopodiché è chiaro che mi sento molto lontano, anche anagraficamente, da quel momento della mia vita. In quel senso il successo per me ha assomigliato molto a qualche tipo non proprio di malattia ma a uno stato di ottenebramento, che viene sia da te, sia dal contorno, cioè una cosa che ti definisce al di là di te, quindi un po’ la devi scalzare dentro di te, un po’ la devi scalzare fuori da te, un po’ le devi permettere di esistere perché quello è comunque il tuo percorso, è da dove tu hai cominciato, anche se poi hai fatto altro, ti sei capito meglio.
ⓢ Ti è costato essere considerato uno scrittore commerciale?
Sì mi ha causato dei problemi. Quella cosa lì mi ha definito in un certo modo, che però veramente non mi appartiene. Non mi appartiene innanzitutto nelle letture, ma anche nell’approccio che ho verso la scrittura. Credo che chi ha letto quello che ho scritto dopo se ne renda conto molto chiaramente. Però mi sono sempre trovato un po’ in mezzo, come se non riuscissi a essere nel posto in cui mi sento me.
ⓢ Tra l’altro dopo La solitudine, l’editoria è cambiata profondamente, nessun libro, anche di successo, fa più quei volumi di vendite.
Ti fa capire che quel successo riguarda molto più l’epoca. Quel libro è stato scritto ed è uscito in un mondo molto diverso. Innanzitutto un mondo in cui non c’erano i social. Un mondo in cui anche un certo tipo di società letteraria, mondo della cultura inteso come giornali, premi, aveva ancora una sua interezza e delle regole molto codificate. C’erano rapporti di forza molto specifici tra le case editrici. Adesso siamo in un mondo molto più sbriciolato. I lettori è come se fossero stati sparati tutti in direzioni diverse. Creare quel tipo di attenzione è molto più difficile, tutti siamo più dispersi. Questo non è necessariamente un male. Sono anche crollati dei monopoli. Delle strutture che avevano una loro polverosità, una loro odiosità. Ma se già allora non sapevo come si faceva a scrivere un libro commerciale, adesso mi sembra veramente incomprensibile. Mi sembra che sia un momento in cui si può fare solo quello che viene da una spinta interiore molto forte. E questa volta per me sono stati degli articoli e un piccolo libro su quello che stava succedendo. Non so quale sarà il passo successivo. Sono talmente in attesa che non sono in grado di dire se sarà un romanzo. Anche se lo vorrei moltissimo.
ⓢ Si può dire che quel successo ti ha permesso un’indipendenza che è un po’ il sogno di quando uno decide di fare lo scrittore? Evitare i networking, le relazioni e via dicendo.
Non posso neanche fare la parte del buon selvaggio perché dopo La solitudine ho avuto tanti contatti con la società letteraria. Però è vero che quell’attività di rete che si autosostiene non la faccio. Ma è anche perché sono molto scarso. C’è una parte di quell’attività che per me è in aperto contrasto con il fatto stesso di scrivere e che non mi risulta affatto naturale.

Scritta da Paolo Giordano e Francesca Manieri insieme a Guadagnino, We Are Who We Are è una serie Sky Original coprodotta da Sky e HBO, dal 9 ottobre in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Luca Guadagnino ne è showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista; la serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Mario Gianani per Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Small Forward. Il nuovo numero di Rivista Studio in edicola ha in copertina una delle protagoniste della serie Jordan Krstine Seamón
ⓢ C’è un motivo preciso per cui sei entrato in contatto con Guadagnino e la produzione di We Are Who We Are? Mi sembra che nella serie ricorrano alcuni temi che sono presenti già nei tuoi ultimi libri: la base militare del Corpo umano, l’educazione sentimentale adolescenziale di Divorare il cielo.
In realtà la serie ha avuto una lunga storia, che comincia da un’idea che io avevo sui ragazzi. L’ambientazione militare è arrivata più avanti, con Luca, e per me è stato più che altro ritornare in un mondo che già conoscevo e avevo studiato. Ma nella serie ci sono tutte e tre le esperienze, quella di Francesca Manieri, quella di Luca e la mia.
ⓢ Ti sei specializzato, se così si può dire, nel parlare di adolescenti, come sono cambiati secondo te i giovani, come sono i giovani di questa generazione?
Con tutta la fallacia delle generalizzazioni, sento una maggiore libertà e una maggiore sfacciataggine, un rifiuto dell’autorità molto più forte di quella di prima.
ⓢ Come si fa, anche tecnicamente, a descrivere dei ragazzi che vivono oggi? Quella della serie sono venuti molto bene, mi sembra.
Credo sia molto l’osservazione, che è una forma di umiltà. Bisogna uscire dallo sguardo dell’adulto che si confronta con il ragazzino, altrimenti si perde la presa. Io penso davvero che nell’adolescenza si abbiano in mano le chiavi del presente, che poi si perdono. Penso che la vera chiave del presente ce l’abbiano loro anche senza saperlo. Io cerco di capire e rubare quale sia questa chiave. C’è anche un po’ di invidia. E invidiandoli li ascolto, li guardo.
ⓢ Com’è stato lavorare con Luca Guadagnino?
È stato istruttivo e molto intenso. Luca ha un grande pregio che è quello di avere le idee estremamente chiare su cosa gli va e cosa non gli va, le direzioni di mood che abbiamo discusso all’inizio e che ha suggerito a me e Francesca erano molto chiare e quindi era anche abbastanza facile seguirle. C’è stato moltissimo lavoro. Un lavoro che non è stato “fai la storia, scrivi la sceneggiatura e addio”. Siamo stati presenti sul set. Abbiamo a volte riscritto sul set. Abbiamo riscritto dopo. È stato un lavoro molto esteso, quindi in certi momenti anche snervante. Però penso che avessimo tutti un grande amore per il progetto e per questi personaggi. Secondo me questo passa nella serie.
ⓢ Ultima domanda: il racconto per il Nytimes, la traduzione dei tuoi articoli all’estero, la produzione internazionale della serie, hai mai pensato di fare il salto e andare via dall’Italia e di puntare tutto su un pubblico internazionale?
Non ci penso proprio. Per molti anni mi sono sentito disancorato e ho avuto difficoltà a sentire un legame persino con la mia città. Anche per questo nella Solitudine c’è Torino senza che venga mai nominata. Solo da un paio d’anni, da quando vivo a Roma, ho capito quanto mi abbia influenzato la città dove sono nato e cresciuto e quanto sia forte il legame che ho con quel luogo. Per l’Italia vale un po’ la stessa cosa.






