La nuova serie della creatrice di Girls è piena di difetti ma ha un pregio che da solo quasi basta a redimerla: rende bene l'idea di che cosa terribile siano le relazioni oggi.
La grande fuga di Lawrence Osborne
Giornalista, critico gastronomico, viaggiatore e infine scrittore di successo, ultimo esponente della tradizione del romanzo esotico: dal numero di Rivista Studio in edicola, intervista all'autore di Java Road, suo nuovo romanzo, da poco uscito in Italia per Adelphi.

È uscito il nuovo romanzo di Lawrence Osborne, gentiluomo inglese, studi borghesi e vita scapigliata. Il libro si chiama Java Road, pubblicato al solito da Adelphi. Osborne, come suo costume, racconta di un gruppo incasinato di occidentali benestanti e delle loro vite lussuose in una città esotica, in questo caso Hong Kong, isolati dalla popolazione locale e con un sacco di tempo libero. Forse un po’ come lui, scappato da una carriera giornalistica per trasferirsi a Bangkok. Esperto di ristoranti costosi, vini pregiati, abiti di sartoria e bar degli hotel, Osborne prosegue la tradizione dell’intellettuale espatriato. Lo contattiamo su Zoom, ci risponde in camicia bianca con collo anni Settanta, due bottoni slacciati, occhi blu curiosi e ironici, sopracciglia cespugliose. Ride spesso, parla qualche parola di italiano, si diverte molto a pronunciare “pazzesco”.
ⓢ Quando inizi un libro scegli prima i protagonisti o la città dove ambientarlo?
In questo caso, tutti e due. Volevo scrivere di Hong Kong, città che frequento da molto tempo e che conosco bene. Ero lì nel 2019, durante le manifestazioni contro la Cina e in difesa della democrazia. Quelle proteste sono state molto potenti. Le persone, soprattutto i giovani, si sono comportate con grandissima dignità. La stampa e la tv non hanno raccontato a dovere quello che è successo, e ho pensato che un libro fosse il modo più calzante per rendere giustizia a ciò che avevo visto.
ⓢ Pensi di esserci riuscito?
Non lo so. È stato bello scrivere di Hong Kong. È un posto molto intenso, soprattutto se sei britannico. Abbiamo una relazione stretta, è strano. Hong Kong è, o almeno era, molto british. Ci sono gli autobus a due piani. È diversa dal resto dell’Asia. C’era questo pezzo di mondo anglofono che sembrava andare a pezzi, due visioni della società in conflitto.
ⓢ E i personaggi?
Sono tutti ispirati a persone reali. Jimmy è uno dei miei vecchi amici di Cambridge. C’è molto di autobiografico in Adrian, e Rebecca è simile a una ragazza che conoscevo. L’intreccio è inventato, i personaggi non lo sono
ⓢ Spesso, anche in Java Road, i tuoi personaggi osservano momenti storici dal bancone di un cocktail bar costosissimo, o da una piscina privata, intenti a far niente per la maggior parte della giornata. Conosci molte persone così?
Non è bello trovarsi per strada durante una rivoluzione. Io, per esempio, non sono molto veloce a correre. È meglio osservare da lontano, magari con uno spritz Aperol. Certe sere, durante le rivolte a Hong Kong, me ne stavo sul terrazzo di un amico ricchissimo e sentivamo in sottofondo questi rumori spaventosi, da battaglia, venire da giù. Persone che chiedevano aiuto, grida, spari. La colonna sonora di una rivoluzione. Dalla nostra postazione era come guardare l’opera. Roba da sentirsi in colpa. Poi però scendevi, e vedevi in che condizioni erano ridotte le strade, fra i gas lacrimogeni e tutto il resto. Meglio stare in terrazzo, anche perché la polizia attaccava senza criterio e con brutalità. La situazione era sfuggita di mano.
ⓢ Alla fine, però, non c’è stata una rivoluzione.
No. È stata soffocata. La rivoluzione non è stata trasmessa in televisione, e alla fine non è successa. Giusto qualche ragazzo sbattuto nelle prigioni segrete.
ⓢ Quanto ci hai messo a scrivere Java Road?
Circa sei mesi, ma poi ci sono state un sacco di correzioni, direi che sono durate due anni. I romanzi corti sono più difficili da scrivere di quelli lunghi. In un romanzo lungo gli errori nell’intreccio si mimetizzano, ci vuole meno editing. In un romanzo breve, tutti gli sbagli nella struttura narrativa saltano subito all’occhio. Penso che i romanzi brevi siano il futuro, vanno incontro al modo in cui si legge oggi. È finita, secondo me, l’epoca dei romanzi lunghi.
ⓢ Una curiosità: è vero che vivi nell’edificio dove è ambientato il tuo penultimo libro, Il regno di vetro?
Sì. È uno strano palazzo. Apple sta preparando una serie tv ispirata al libro, e siamo in trattative per girarla qua dentro. I miei vicini, però, non sono entusiasti. Ci toccherà cercare un edificio vuoto altrove. È un peccato, perché questo posto è pazzesco. Non ho esagerato nel romanzo, l’ho descritto com’è. Dalla mia finestra si vedono i grattacieli, stile skyline notturno di Manhattan ma con schermi a cristalli liquidi che trasmettono immagini di ragazze seminude.
ⓢ Passi tutto l’anno a Bangkok? Torni mai in Europa?
Di solito durante le feste vado a Tokyo, mio figlio è sposato con una donna giapponese e hanno una bambina. Sarò là tutto dicembre, verrà anche mio padre. Le uniche due nazioni che visito in Europa sono il Regno Unito e l’Italia. E la Grecia, a volte. Sono cresciuto in Francia, parlo francese, ma non mi piace più tanto. Ho una lunga e complicata relazione con l’Italia, sono stato a scuola lì.
ⓢ Davvero? E dove?
Ho fatto dei corsi estivi a Firenze. La mia madrina era di Fiesole, ho passato un sacco di estati in Toscana. Se dovessi comprare una casa in Europa sceglierei l’Italia, anche se la vostra burocrazia è un casino.
ⓢ Dovresti sbrigarti, le case continuano a salire di prezzo.
Non parlarmene, guardo gli annunci immobiliari tutti i giorni, e ogni mese diventa più deprimente.
ⓢ Non essere così umile, ormai sei passato al grande schermo, parecchi tuoi libri sono diventati film di successo, sei un uomo ricco.
Ho passato la maggior parte della mia vita a guadagnarmi da vivere con i libri e con il giornalismo, cioè a guadagnare poco. Sono sempre stato al verde. E poi, senza preavviso, un tuo libro diventa un film e gli altri vengono opzionati. Sono passato a un livello di introiti superiore. Ho più tasse da pagare. È strano, mi è successo tardi, dopo i cinquant’anni. Non l’avevo programmato, mi sono limitato a credere nella letteratura, come un dinosauro.
ⓢ Come sei entrato nel cinema?
Per caso. Ho saputo che Jessica Chastain aveva opzionato i diritti per il mio romanzo Nella polvere. Dopo un po’ mi ha chiamato il regista, dicendomi: ti do venticinquemila dollari, e ti prometto che finiremo il film. È stato di parola. Ho fatto il produttore esecutivo, cioè sono andato in Marocco e ho dato una mano. Ci abbiamo messo quattro anni per racimolare i soldi, poi è arrivato il Covid. È stata dura ma l’abbiamo finito, e ha avuto successo. Quando una tua idea diventa un film, guadagni credito e iniziano a leggerti con uno sguardo diverso. Pensavo che sarei stato povero per sempre. Se ci ripenso, che fortuna. Il mondo letterario è ok quando sei giovane e hai l’energia per sopravvivere. Io ho vissuto di aria e sigarette per trent’anni. Ma quando sei un uomo di mezza età, inizi a risultare patetico.
ⓢ Un po’ tipo Adrian, il protagonista di Java Road.
È per questo che ho lasciato New York. Servono troppi soldi per vivere là. Ormai ci abitano solo i dipendenti dei fondi speculativi e la gente ricca di famiglia. Una volta era un posto accessibile per quelli come me, ora non più. Me ne sono andato nel 2011, quella decisione mi ha salvato la vita. Gli amici giornalisti che sono rimasti lì non riescono a fare nulla perché non se lo possono permettere. Non hanno tempo libero per scrivere un libro o un film. Devono dedicare tutte le loro energie al giornalismo, per guadagnare soldi appena sufficienti per vivere.
ⓢ E così ti sei trasferito a Bangkok.
Sì. Qua posso permettermi un appartamento economico e spazioso, e mi sono ritrovato con un sacco di tempo. Settimane, mesi con niente da fare. Il mio piano era dedicarmi completamente alla scrittura di romanzi, e recuperare gli anni perduti.
ⓢ Com’è la tua routine di scrittura?
Scrivo di notte, fino all’ora di andare a dormire. Faccio una piccola seduta di correzione nel tardo pomeriggio, dalle sei alle sette, e poi vado a cena con gli amici. Ho bisogno di un drink dopo aver scritto. Bangkok è perfetta, c’è un sacco di vita sociale, i ristoranti sono pazzeschi. Esco tutti i giorni.
ⓢ In tal caso, visti anche i tuoi trascorsi da critico gastronomico, consigliaci il miglior ristorante di Bangkok.
Forse Le Du, una stella Michelin, però è difficilissimo trovare un tavolo. C’è da dire una cosa sul cibo thailandese: il ristorante in fondo alla mia via, gestito da una coppia di nonni, è altrettanto buono. Secondo me sono tutti deliziosi, però la mia fidanzata thailandese dice che fanno tutti schifo. Viene dal nord, pare che il cibo migliore si mangi là. Tutte le volte che la porto in un ristorante qua a Bangkok si lamenta. Forse perché odia Bangkok.
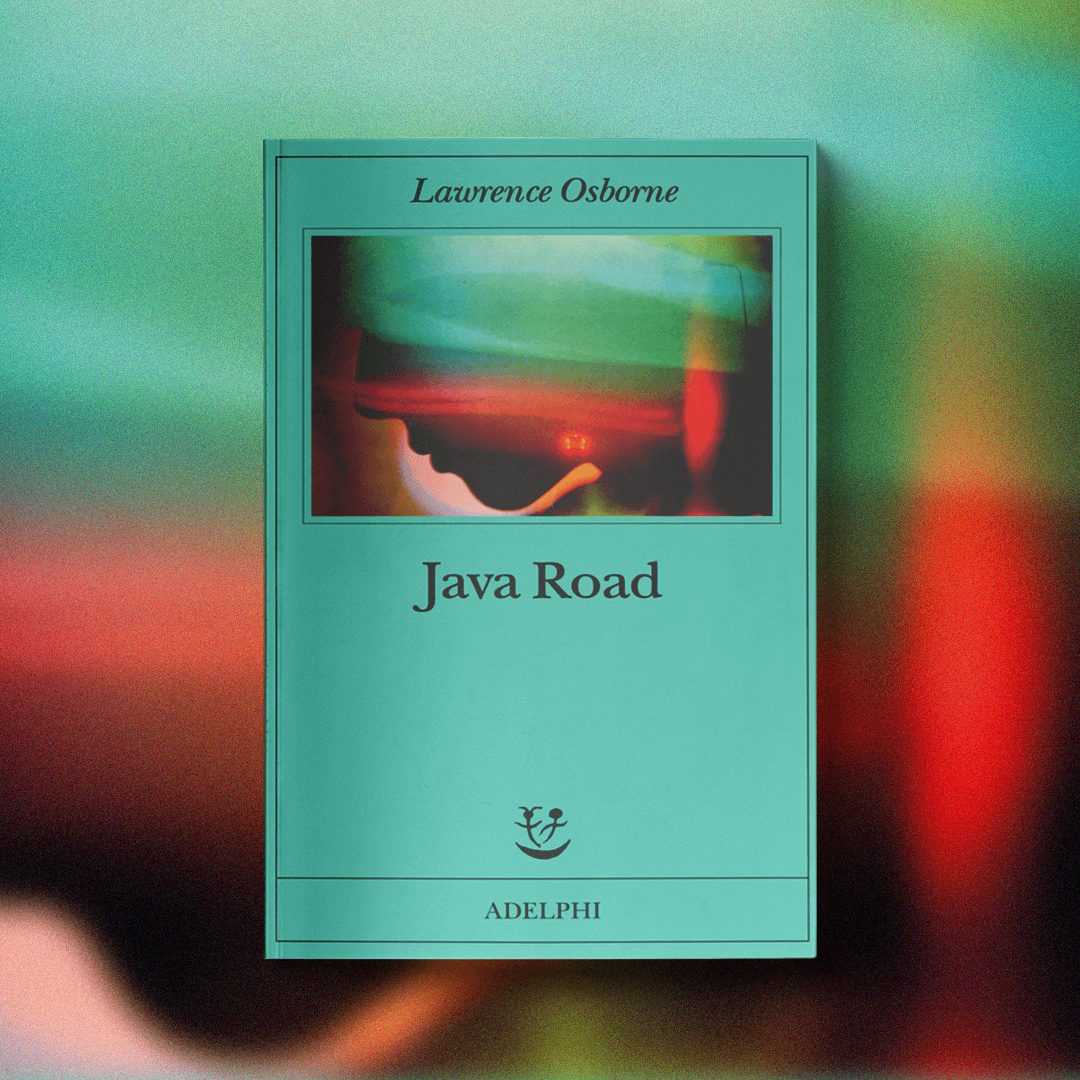
ⓢ Torniamo ai libri. I tuoi sono sempre stati pubblicati in Italia da Adelphi. Ti va di parlarci di Roberto Calasso?
Quindici anni fa ho scritto Bangkok. La maggior parte degli editori sono buoni a nulla. Quando un libro viene tradotto, di solito, succede per caso. Bangkok è capitato sulla scrivania di Matteo Codignola, che l’ha passato a Roberto, dicendogli “c’è questo strano libro, non so niente dell’autore ma dagli un’occhiata”. Gli è piaciuto e mi hanno contattato, chiedendomi i diritti. Bangkok non era stato pubblicato fuori dagli Stati Uniti, quindi ho pensato ok, perché no. La prendevo sottogamba. Calasso mi ha detto che il libro era serio, che mi stavo sottovalutando, che dovevo ripensare la mia carriera: secondo lui ero stato troppo a lungo nel giornalismo americano. È stata una chiacchierata importantissima per me. Poi sono stato in Italia a fare il mio primo tour promozionale, radio, eventi, cose così. Non avevo mai fatto niente del genere negli Stati Uniti. Se lì esce un libro che si chiama Bangkok, a nessuno frega nulla. Per me è stato un momento spartiacque: ho capito che potevo fare questo lavoro in modo diverso. Roberto veniva ai miei reading, sedeva in prima fila, faceva domande. Dopo andavamo a bere. Ho una relazione molto leale, con Adelphi. La considero la miglior casa editrice al mondo. Hanno una grandissima attenzione per i libri.
ⓢ Non è così in America?
No, là pensano solo ai soldi. Secondo me i grandi editori di una volta, quelli con un gusto e una visione, che leggevano tutto, stanno sparendo. Sono stato fortunato a condividere con Calasso qualche anno di strada, e a sbronzarmi con lui di spritz Aperol.
ⓢ In Java Road c’è una citazione di Flaiano, conosci la sua opera?
Ho letto tutto Flaiano. Lo adoro. Diario notturno è uno dei miei libri preferiti. E le sue sceneggiature, Otto e mezzo, La dolce vita. La gente pensa che siano film di Fellini, ma in realtà sono di Flaiano. Ha scritto un romanzo sulla guerra in Etiopia, Tempo di uccidere. È incredibile che quel libro non sia mai stato tradotto in inglese. Sono arrivato a Flaiano grazie alle sue sceneggiature. Polifoniche, brillanti. Ci sono passaggi dove sei persone parlano nello stesso momento. Oggi non si scrive più niente del genere. Flaiano aveva un orecchio incredibile. Certe persone geniali restano famose solo a livello locale, chissà perché.
ⓢ Anche tu hai un gran talento a scrivere i dialoghi. È un’abilità naturale o la si può allenare?
Vado al bar e ascolto, come ai tempi dei racconti intorno al fuoco. Le persone sono strane, disturbanti e affascinanti. Secondo me ha poco senso incontrare chi già conosci al bar, ti leva il piacere più grande: l’anonimato. Non andrei mai al bar con una ragazza.
ⓢ Davvero? E perché mai?
Perché non voglio cementare lì il nostro rapporto. Voglio solo ascoltare gli anziani, come a New York, dove ci sono un sacco di bar interessantissimi pieni di vecchi italiani con storie da raccontare. Sono stato un giornalista per decenni, e il mio lavoro consisteva nell’ascoltare. Persone di tutti i tipi: contadini, pescatori della Papua Nuova Guinea, dottori, politici. Mi sono guadagnato un orecchio per i discorsi. Se vivi in una bolla di scrittori, incontrerai solo persone simili a te. Odiavo fare il giornalista, ma mi ha permesso di incontrare gente diversa da me. E ho imparato un mestiere. Per esempio, il modo migliore per far suonare un dialogo realistico è lavorarci per un bel po’, rendendolo il più irrealistico possibile. Nessuno vuole leggere un flusso di coscienza. A proposito, devo salutarti, ho appuntamento a cena con la mia fidanzata.
ⓢ Va bene, ultima domanda. A cosa stai lavorando adesso?
Ho appena finito un romanzo che parla di studenti americani rivoluzionari a Istanbul. E poi sto scrivendo la sceneggiatura di un film ambientato in Mongolia, la produzione dovrebbe partire a breve.
ⓢ E dove andrai stasera a cena?
In un posto che si chiama Enoteca, un ristorante italiano del quartiere, gestito da un amico. Stasera mi hanno promesso un Trebbiano d’Abruzzo di una cantina particolare, molto raro in Asia. Il vino italiano è una delle mie passioni, e quella è una delle mie bottiglie preferite.
L’immagine di copertina è presa dal sito di Lawrence Osborne.
Per comprare una copia di questo numero vai qui.






