Già il videogioco più discusso dell'anno, la nuova opera del game designer giapponese segna un cambiamento radicale della sua poetica: da sempre un ottimista, adesso anche lui sembra essersi rassegnato al peggio.
James Dyson, ispiratutto
In Invention, autobiografia appena uscita per Rizzoli, l'inventore dell'aspirapolvere più desiderata del mondo racconta come è arrivato al successo: bastano talento, costanza e 5126 tentativi.

Forse James Dyson rappresenta ancora meglio di Steve Jobs ciò che di solito intendiamo – spesso senza averne il bisogno − per innovazione e visionarietà. È vero, lo smartphone ha cambiato la vita di ogni essere umano, ma è stato grazie anche allo sforzo di fantasia di decine di altre persone se oggi esistono dei programmi che ci forzano a tenere la testa china sullo schermo. Mentre l’aspirapolvere, il purificatore d’aria, il phon o la piastra per capelli sono arnesi che si sono imposti autonomamente, per le loro qualità, creando desideri che non c’erano, e diventando oggetti del desiderio, status symbol e icone. Per poi essere copiati, venire trasformati in giocattoli per bambini, anche solo essere esposti in bella mostra su un mobile o attaccati al muro accanto al divano. Chi avrebbe mai immaginato che un giorno avremmo esposto in sala più in vista di un quadro, mica dentro uno sgabuzzino, un’aspirapolvere? E chi avrebbe mai immaginato che lo sporco aspirato sarebbe rimasto lì, in bella vista, nel contenitore di plastica trasparente: polvere, molliche, batuffoli di polline, e che le persone avrebbero preferito guardare soddisfatte quello sporco raccolto, invece di gettarlo ben chiuso nei sacchetti, invisibile agli occhi, com’era sempre stato prima che Dyson distruggesse il mercato dei sacchetti di ricambio e rendesse disoccupati tutti quei signori che suonavano ai citofoni di mezzo mondo per venderci il loro prodotto all’ultimo grido?. Evidentemente James Dyson sì, lui sapeva, e infatti lo racconta nella sua autobiografia, Invention, uscita il 19 aprile per Rizzoli.
Cosa avrà capito James Dyson del genere umano prima che se ne accorgessero gli altri? Non sarà uno scrittore o un filosofo o uno psicologo, non ti costringe ad annuire durante la lettura, ma è stato un grande inventore, quello sì. E i grandi inventori e imprenditori, quelli visionari – per quanto l’abuso di questa parola possa farci orrore – possono davvero aver visto qualcosa del futuro prima degli altri. O, in alternativa, senza scomodare il futuro, possono semplicemente aver colto un aspetto degli altri esseri umani che prima non era stato esplorato. A volte perfino un aspetto negativo, molto spesso perfino un aspetto negativo, ma – è ciò che affascina e ciò che conta – lo hanno fatto prima. Il signor Dyson ha capito, per esempio, prima degli altri che il pubblico non avrebbe rinunciato a un prodotto solo perché era il più costoso della sua categoria. Anzi. Forse l’avrebbe scelto proprio per quello. E non solo chi poteva permetterselo avrebbe cominciato a scegliere così. Ma anche, e soprattutto, chi non poteva permetterselo. (Forse sapeva anche che le persone avrebbero cominciato a usare il tremendo “top di gamma” nel linguaggio comune, come capita adesso? Chissà).
Nel libro ci sono anche l’amore per il design industriale, tante riflessioni su quali prodotti abbiano cambiato il gusto delle persone (il walkman o certi modelli di Citroën, per esempio), poi ci sono commenti sul declino dell’industria nei Paesi europei (Dyson ha sostenuto ripetutamente la Brexit e critica moltissimo la cerimonia di inaugurazione dei giochi Olimpici di Londra, colpevole di aver sottovalutato l’importanza della Rivoluzione industriale nel paese) e anche i racconti delle prime invenzioni di James Dyson: un mezzo anfibio e una carriola che non sprofondasse nel fango.
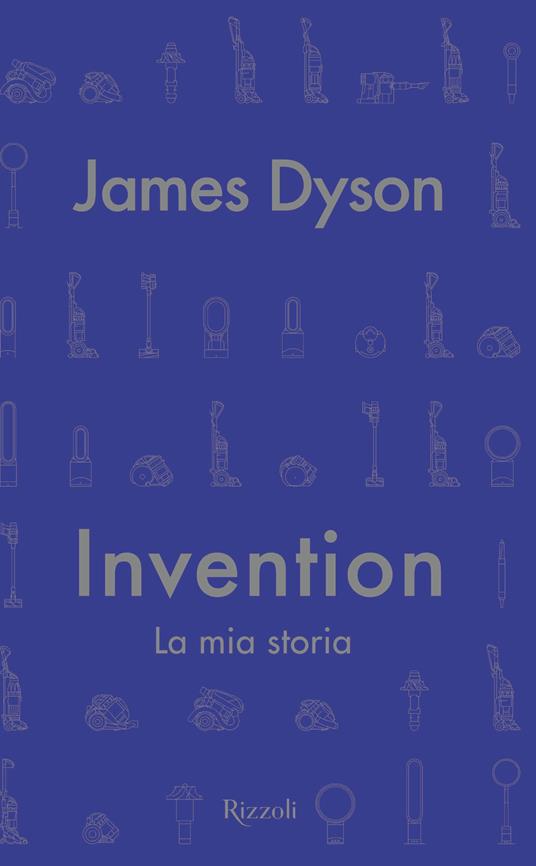
C’è, naturalmente, nelle quasi quattrocento pagine del libro, anche ciò che il signor Dyson non ha capito, una costante, ma ci arriviamo presto, anche a giudicare alla luce di dibattiti analoghi dall’Italia, che si ripetono serialmente. Da anni ormai, un certo tipo di biografia ambisce a essere “di ispirazione”. Persone di diverso tipo, accomunate forse dall’unica caratteristica di aver avuto successo nel proprio mestiere, decidono a un certo punto della propria vita di raccontarla. E di spiegare come sono arrivati in cima, e magari anche perché. E celebrano la propria determinazione o il proprio coraggio o il proprio talento (ma il talento da solo non basta mai, dicono tutti, attenzione, serve la costanza!) augurandosi di essere di ispirazione per gli altri. (Per questo molte persone di solito intelligenti non hanno apprezzato Il lupo di Wall Street, perché temono possa essere “di ispirazione” pure quello).
Insomma, che siano imprenditori o sportivi o musicisti ci tengono a chiarire che scrivono e si raccontano non tanto per vanità, ma perché altri siano ispirati. E pure il signor Dyson racconta che il suo Dyson aspirapolvere non è mica frutto di un’eureka che una mattina l’ha colto mentre raccoglieva fiori di bosco, ma ci sono stati 5126 prove sbagliate, prima del 5127esimo tentativo, quello giusto, da commercializzare. Questo 5126 è un numero chiave del libro, non mi stupirebbe fosse stato in passato anche il codice segreto di qualcosa, perché è la testimonianza che solo la tenacia paga, che non bisogna arrendersi, che tutti hanno da qualche parte dentro di sé un Dyson o uno Steve Jobs o un Ibrahimovic nascosto, e che questo è pronto a sbocciare se impariamo a coltivarlo. Ciò che Dyson (o Alessandro Borghese, in questi giorni protagonista di un dibattito sui giovani incapaci di investire sulla propria carriera) sembrano non comprendere è che, invece, non tutti ambiscono a scommettere su sé stessi o a diventare inventori o imprenditori, e a lasciare una grande impronta di sé attraverso il lavoro. E non per stupidità o accidia, ma proprio perché non chiunque delega al lavoro il fine della propria vita e non solo un mezzo per viverla decentemente.
Nei giorni scorsi, Concita de Gregorio ha esposto una teoria molto stimolante: «i genitori sono diventati la rovina dei figli, i maggiori talenti del secolo difatti sono orfani. Li colleziono, ne ho un bouquet. (Lei, nell’articolo, si augura di evitare sterili polemiche social pubblicandola in un sabato pre-pasquale. Qui si conta molto sul fatto che non sarà certo questo pezzo a rinfocolarle). Ho calcolato che circa la metà dei recenti premi Nobel ha perso i genitori da bambino». Curiosamente Dyson scrive qualcosa di simile – facendo un passaggio in più e di troppo – dopo aver raccontato della prematura scomparsa del padre: «Sentivo la mancanza di mio padre. Molti anni dopo mi stupii quando, in un libro di Virginia Ironside, lessi che l’ottantacinque per cento dei primi ministri britannici, da Robert Walpole a John Major, e dodici presidenti americani, da George Washington a Barack Obama, avevano perso il padre da piccoli. Sarebbe sbagliato dire che la perdita del padre è una sorta di macabro biglietto per il successo, ma un lutto prematuro stimola forse alcuni individui a fare grandi conquiste?».
Arriva l’età – capita a molti che fanno mestieri che hanno poco a che fare con le mani – in cui ci si dice “vorrei aver imparato a fare davvero qualcosa”. Qualcuno si mette a fare ceramica, altri giardinaggio, altri reprimono la voce e basta. Pazienza. Nella prossima vita. L’esaltazione del fallimento come modo di progredire ha sicuramente importanza e, forse, andrebbe davvero spiegato meglio anche ai ragazzi come fallire. Ma neanche il fallimento può diventare un feticcio o un passaggio obbligato verso il successo, altrimenti pure il fallimento diventa caricaturale, esattamente come i genitori che ti dicono “bravissimo, amore” pure se hai disegnato uno sgorbio a tre occhi.

Il regista inglese torna alla saga che lo ha reso famoso e decide di stravolgerla: il risultato è un film d'autore, horror ma anche politico e sentimentale, che disattende tutte le aspettative e che ha diviso i fan.





