Se avete la carnagione molto chiara o siete amanti di videogiochi, potrebbe essere la grande occasione per esordire al cinema.
I libri del mese
Cosa abbiamo letto a settembre in redazione.

Michael Pollan, Piante che cambiano la mente (Adelphi)
Traduzione di Milena Zemira Ciccimarra
 Michael Pollan si porta dietro un taccuino dappertutto. In praticamente ogni suo libro lo nomina: mentre è pieno di Lsd prende appunti sul taccuino. Mentre è in astinenza da caffeina prende appunti sul taccuino. Mentre è tra le splendide braccia dell’oppio prende appunti sul taccuino. Come ormai si sa, il successo della sua opera è merito di questo coraggio nel provare in prima persona le cose di cui parla, e anche la sua straordinarietà, se non unicità. Piante che cambiano la mente ha un titolo che può sembrare già sentito – richiama il precedente Come cambiare la tua mente – ma non è un sequel, né un’opera minore. Dopotutto Pollan si è sempre occupato di quello spazio (culturale, scientifico, alimentare) in cui natura ed esseri umani vengono a contatto. Piante che cambiano la mente (in inglese: This Is Your Mind On Plants) è un viaggio negli effetti e nella storia di tre piante fondamentali per la specie umana: l’oppio (i papaveri da oppio), la caffeina e la mescalina. È Pollan al cento per cento, e i molti che già lo amano sanno cosa significa questa semplice frase. Per chi ancora non lo conosce, spiegherò così: la divulgazione scientifica più romanzesca, acuta, divertente e appassionante che vi capiterà di leggere su argomenti che non vi erano probabilmente mai sembrati così degni di attenzione. La condizione ideale per consumare questo libro sarebbe dopo aver letto Come cambiare la tua mente, perché l’indagine psicologico-antropologica che Pollan aveva iniziato là con gli psichedelici qui, in un certo senso, continua. Questo non lo rende però un libro secondario: anzi è la bellezza degli autori che hanno raggiunto lo status di cult questa capacità di produrre opere che fanno parte di una costellazione e non sono pietruzze isolate l’una dall’altra. Come i libri sul cibo (tutti straordinari) hanno spinto immagino moltissime persone a mettersi a cucinare e quelli sull’Lsd hanno spinto migliaia di lettori a provare o considerare di provare un trip (fatelo!), anche qui verrà voglia di diventare produttori d’oppio, viaggiare e “guarire” cullati dalla mescalina, o semplicemente bere un caffè in più. (Davide Coppo)
Michael Pollan si porta dietro un taccuino dappertutto. In praticamente ogni suo libro lo nomina: mentre è pieno di Lsd prende appunti sul taccuino. Mentre è in astinenza da caffeina prende appunti sul taccuino. Mentre è tra le splendide braccia dell’oppio prende appunti sul taccuino. Come ormai si sa, il successo della sua opera è merito di questo coraggio nel provare in prima persona le cose di cui parla, e anche la sua straordinarietà, se non unicità. Piante che cambiano la mente ha un titolo che può sembrare già sentito – richiama il precedente Come cambiare la tua mente – ma non è un sequel, né un’opera minore. Dopotutto Pollan si è sempre occupato di quello spazio (culturale, scientifico, alimentare) in cui natura ed esseri umani vengono a contatto. Piante che cambiano la mente (in inglese: This Is Your Mind On Plants) è un viaggio negli effetti e nella storia di tre piante fondamentali per la specie umana: l’oppio (i papaveri da oppio), la caffeina e la mescalina. È Pollan al cento per cento, e i molti che già lo amano sanno cosa significa questa semplice frase. Per chi ancora non lo conosce, spiegherò così: la divulgazione scientifica più romanzesca, acuta, divertente e appassionante che vi capiterà di leggere su argomenti che non vi erano probabilmente mai sembrati così degni di attenzione. La condizione ideale per consumare questo libro sarebbe dopo aver letto Come cambiare la tua mente, perché l’indagine psicologico-antropologica che Pollan aveva iniziato là con gli psichedelici qui, in un certo senso, continua. Questo non lo rende però un libro secondario: anzi è la bellezza degli autori che hanno raggiunto lo status di cult questa capacità di produrre opere che fanno parte di una costellazione e non sono pietruzze isolate l’una dall’altra. Come i libri sul cibo (tutti straordinari) hanno spinto immagino moltissime persone a mettersi a cucinare e quelli sull’Lsd hanno spinto migliaia di lettori a provare o considerare di provare un trip (fatelo!), anche qui verrà voglia di diventare produttori d’oppio, viaggiare e “guarire” cullati dalla mescalina, o semplicemente bere un caffè in più. (Davide Coppo)
Michele Masneri, Dinastie (Rizzoli)
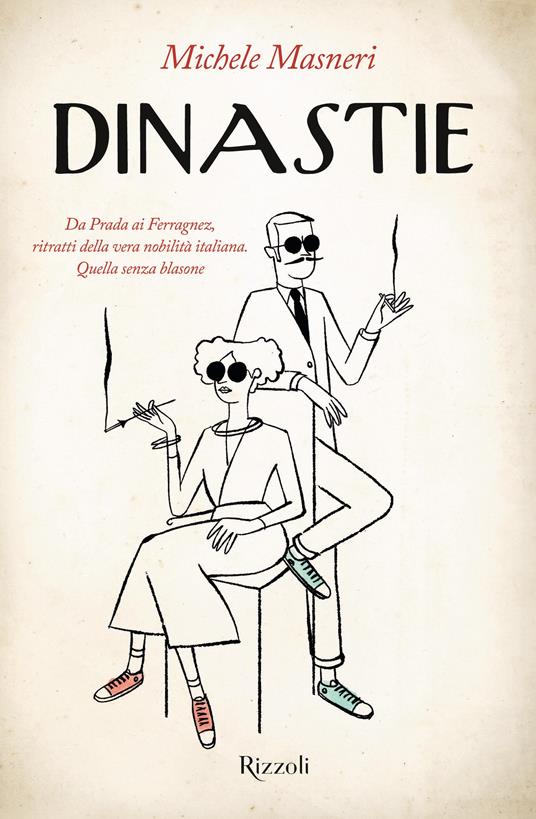 La prossima volta che scatta un caso prepotente di invidia sociale su una delle tante piattaforme dove raccontiamo la nostra vita, che sia Twitter o Instagram o TikTok per i più giovani, sarebbe utile che i naviganti avessero già letto, in via di preparazione, Dinastie di Michele Masneri, snella raccolta di saggi dedicati a coloro che in Italia le polemiche le fanno scoppiare, ma raramente vi prendono parte (l’eccezione è Carlo Calenda, ma quella è un’altra storia). Parliamo dei ricchi, e dei ricchi italiani che il giornalista del Foglio ha documentato negli ultimi anni sul suo giornale: gente cittadina e cosmopolita come i Prada, ahimè i Ferragnez, che a Milano si scrutano senza mai incontrarsi (tranne che alla sfilata, che è un po’ un’ Olimpiade e si va tutti d’accordo) dall’austera Torre al finto minimalista CityLife, oppure i Moratti per chi se li ricordasse (e chi ci aveva mai pensato a quanto fosse tragico il personaggio di Letizia, che il Covid ha resuscitato); quindi gli strani ricchi romani come i Malagò e i Calenda appunto (che sì, vanno annoverati tra i ricchi), e poi quelli della provincia, i Trussardi, i Beretta, i Panini tra gli altri, e naturalmente gli ovvi Agnelli e De Benedetti, ultimi baluardi del Novecento del Belpaese finiti oggi a discrezione massima e conglomerate internazionali da una parte e – di questo li si dovrebbe ringraziare pubblicamente – a una guerra di successione dall’altra, guerra che fa invidia a quella serie lì di Hbo ma dimenticatevi le cose cool di New York. I ricchi italiani, ci spiega Masneri, sono una specie curiosa, ti assicurano assunzioni che non avverranno mai, hanno sempre avuto il cruccio del mancato titolo nobiliare, sempre guardato oltreoceano per costruire le loro mitologie (non è il caso della Signora, che invece si è costruita da sola) e quando non sono gagliardi e arruffoni in vecchie e nuove versioni influencer, vorrebbero sparire in un lago svizzero. Tante volte lo fanno, così non pagano le tasse. (Silvia Schirinzi)
La prossima volta che scatta un caso prepotente di invidia sociale su una delle tante piattaforme dove raccontiamo la nostra vita, che sia Twitter o Instagram o TikTok per i più giovani, sarebbe utile che i naviganti avessero già letto, in via di preparazione, Dinastie di Michele Masneri, snella raccolta di saggi dedicati a coloro che in Italia le polemiche le fanno scoppiare, ma raramente vi prendono parte (l’eccezione è Carlo Calenda, ma quella è un’altra storia). Parliamo dei ricchi, e dei ricchi italiani che il giornalista del Foglio ha documentato negli ultimi anni sul suo giornale: gente cittadina e cosmopolita come i Prada, ahimè i Ferragnez, che a Milano si scrutano senza mai incontrarsi (tranne che alla sfilata, che è un po’ un’ Olimpiade e si va tutti d’accordo) dall’austera Torre al finto minimalista CityLife, oppure i Moratti per chi se li ricordasse (e chi ci aveva mai pensato a quanto fosse tragico il personaggio di Letizia, che il Covid ha resuscitato); quindi gli strani ricchi romani come i Malagò e i Calenda appunto (che sì, vanno annoverati tra i ricchi), e poi quelli della provincia, i Trussardi, i Beretta, i Panini tra gli altri, e naturalmente gli ovvi Agnelli e De Benedetti, ultimi baluardi del Novecento del Belpaese finiti oggi a discrezione massima e conglomerate internazionali da una parte e – di questo li si dovrebbe ringraziare pubblicamente – a una guerra di successione dall’altra, guerra che fa invidia a quella serie lì di Hbo ma dimenticatevi le cose cool di New York. I ricchi italiani, ci spiega Masneri, sono una specie curiosa, ti assicurano assunzioni che non avverranno mai, hanno sempre avuto il cruccio del mancato titolo nobiliare, sempre guardato oltreoceano per costruire le loro mitologie (non è il caso della Signora, che invece si è costruita da sola) e quando non sono gagliardi e arruffoni in vecchie e nuove versioni influencer, vorrebbero sparire in un lago svizzero. Tante volte lo fanno, così non pagano le tasse. (Silvia Schirinzi)
Lidia Yuknavitch, La cronologia dell’acqua (nottetempo)
Traduzione di Alessandra Castellazzi

Pubblicato nel 2011, nel 2013 questo libro stava ancora vendendo decine di migliaia di copie su Amazon e continuava a ricevere recensioni sulle riviste: «The Chronology of Water di Lidia Yuknavitch è il tipo di libro che le persone non solo leggono, ma a cui si convertono» era uno dei commenti che si leggevano. La cronologia dell’acqua è un memoir impressionante non tanto per via di quello che racconta della vita dell’autrice (aborti, abusi da parte del padre, tentativi di suicidio della madre, matrimoni falliti, dipendenza, alcolismo, insuccesso) ma per come lo fa: Yuknavitch cresce (e fallisce) come nuotatrice professionista, ma la consistenza dell’acqua – la fluidità e la trasparenza – accompagna per sempre i suoi pensieri e la sua scrittura. Una scrittura che in inglese funziona molto meglio, ma la copertina di nottetempo, che l’ha pubblicato a maggio di quest’anno (rubo le parole di una recensione: «perché cazzo ho aspettato così tanto a leggere questo libro?»), è troppo troppo bella (bella anche quella della prima edizione). La cronologia dell’acqua è stato definito un body memoir, perché il corpo della donna è sempre al centro, sofferente ma anche fortissimo, già dalle prime terribili pagine. Al tempo stesso è un libro molto spirituale, «un libro sacro», come ha scritto qualcuno. Mi ha ricordato come per certi autori la scrittura non sia soltanto una passione o una professione, ma un modo per provare a dare un senso alla propria vita. Quando è uscito Yuknavitch aveva già 48 anni (è nata nel 1963), mi chiedo quanto abbia impiegato a scriverlo e a dare forma alla sua voce, così rabbiosa e precisa, capace di essere sia sporchissima che limpidissima, sia bollente che freddissima. Attenzione: si piange spesso. Mi sono segnata quando: il primo pianto arriva già a pagina 17. (Clara Mazzoleni)
Kader Abdolah, Il faraone d’Olanda (Iperborea)
Traduzione di Elisabetta Svaluto Moreolo
Tutti i libri di Kader Abdolah parlano dell’Iran, anche quelli che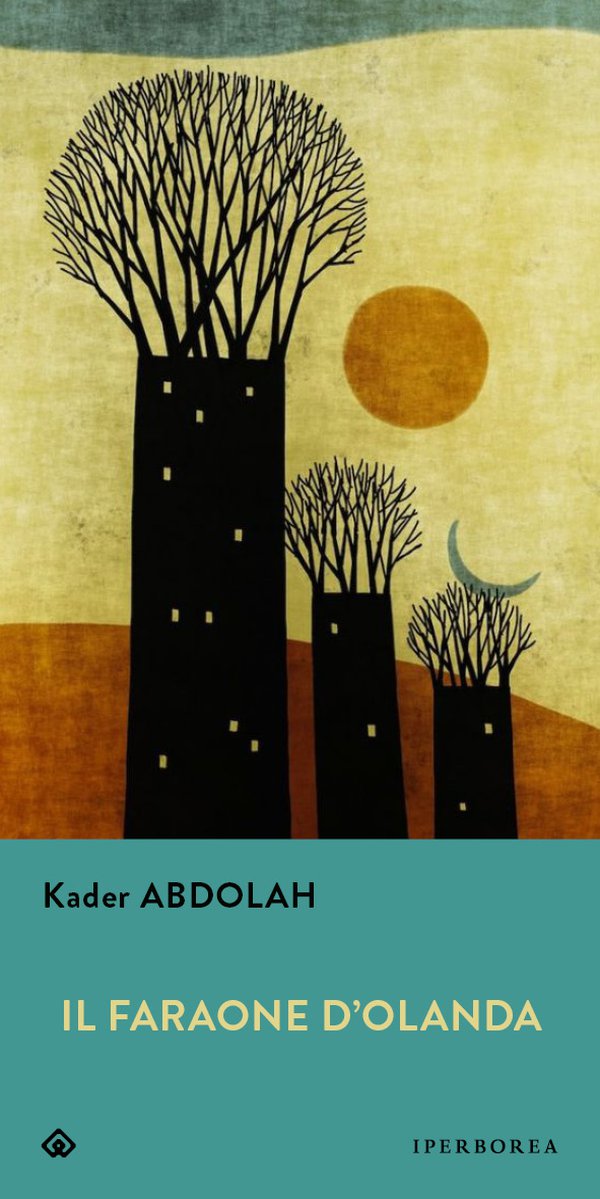 parlano dell’Egitto come Il faraone d’Olanda. E quindi tutti i libri di Kader Abdolah parlando di Kader Abdolah, un «piccolo scrittore» che nella sua vita ha desiderato due cose soltanto: lasciare l’Iran, le persecuzioni dello scià e dell’ayatollah, e tornare in Iran, perché anche gli esuli invecchiano fino a sentire la mancanza «del sole, delle persone, di essere insultato». Nelle sue intenzioni Il faraone d’Olanda doveva essere il romanzo più distante, la storia più diversa dalla sua: nei fatti è l’autobiografia che Abdolah non potrà mai scrivere («Non ci sono le condizioni. Assolutamente non posso tornare e non potrei scrivere in Iran. Anche se non mi mettessero in prigione sarei in una galera forzata»). Il co-protagonista del romanzo è Abdolkarim, egiziano emigrato in Olanda, che aiuta l’amico Herman Raven, egittologo a cui l’età sta cancellando la memoria – proprio come la madre di Abdolah, affetta da morbo di Alzheimer – a prendersi cura di un tesoro segreto: la mummia della regina Merneith, che i due custodiscono in una cantina adattata a tomba regale. In vita, Merneith era la prediletta di Thot, il dio egizio che protegge chi scrive e chi sa: proprio come Abdolkarim, proprio come Abdolah. Ormai vecchio, Abdolkarim decide che la missione della sua vita è riportare in Egitto quel tesoro trafugato e assieme a Herman intraprende il viaggio di Ulisse, quello per tornare a casa. Un viaggio da cui emerge l’eredità letteraria mista di Abdolah, che è diventato scrittore due volte: una nella sua lingua madre e un’altra in quella dell’esilio, che nel suo caso è l’olandese (lingua che oggi Abdolah definisce «la mia casa»). Nel Faraone d’Olanda c’è l’autoanalisi ossessiva del vecchio nostalgico, abbellita da inserti magici presi dalla tradizione narrativa persiana: a sfidare Abdolkarim durante il suo viaggio saranno persone – chi lo accusa di essere un falsario e chi gli dice che è un pazzo, chi vuole derubarlo e chi imprigionarlo – che però potrebbero essere benissimo dei jinn, spiriti coranici talvolta benevoli e talvolta maligni, certe volte ingannatori e altre protettori, le forze che si oppongono al movimento unico e naturale dell’esistenza: quello per fare «tornare tutto al luogo da dove è venuto». (Francesco Gerardi)
parlano dell’Egitto come Il faraone d’Olanda. E quindi tutti i libri di Kader Abdolah parlando di Kader Abdolah, un «piccolo scrittore» che nella sua vita ha desiderato due cose soltanto: lasciare l’Iran, le persecuzioni dello scià e dell’ayatollah, e tornare in Iran, perché anche gli esuli invecchiano fino a sentire la mancanza «del sole, delle persone, di essere insultato». Nelle sue intenzioni Il faraone d’Olanda doveva essere il romanzo più distante, la storia più diversa dalla sua: nei fatti è l’autobiografia che Abdolah non potrà mai scrivere («Non ci sono le condizioni. Assolutamente non posso tornare e non potrei scrivere in Iran. Anche se non mi mettessero in prigione sarei in una galera forzata»). Il co-protagonista del romanzo è Abdolkarim, egiziano emigrato in Olanda, che aiuta l’amico Herman Raven, egittologo a cui l’età sta cancellando la memoria – proprio come la madre di Abdolah, affetta da morbo di Alzheimer – a prendersi cura di un tesoro segreto: la mummia della regina Merneith, che i due custodiscono in una cantina adattata a tomba regale. In vita, Merneith era la prediletta di Thot, il dio egizio che protegge chi scrive e chi sa: proprio come Abdolkarim, proprio come Abdolah. Ormai vecchio, Abdolkarim decide che la missione della sua vita è riportare in Egitto quel tesoro trafugato e assieme a Herman intraprende il viaggio di Ulisse, quello per tornare a casa. Un viaggio da cui emerge l’eredità letteraria mista di Abdolah, che è diventato scrittore due volte: una nella sua lingua madre e un’altra in quella dell’esilio, che nel suo caso è l’olandese (lingua che oggi Abdolah definisce «la mia casa»). Nel Faraone d’Olanda c’è l’autoanalisi ossessiva del vecchio nostalgico, abbellita da inserti magici presi dalla tradizione narrativa persiana: a sfidare Abdolkarim durante il suo viaggio saranno persone – chi lo accusa di essere un falsario e chi gli dice che è un pazzo, chi vuole derubarlo e chi imprigionarlo – che però potrebbero essere benissimo dei jinn, spiriti coranici talvolta benevoli e talvolta maligni, certe volte ingannatori e altre protettori, le forze che si oppongono al movimento unico e naturale dell’esistenza: quello per fare «tornare tutto al luogo da dove è venuto». (Francesco Gerardi)
 Kapka Kassabova, Il lago (Crocetti)
Kapka Kassabova, Il lago (Crocetti)
Traduzione di Anna Lovisolo
Nell’affollatissimo panorama delle scritture personali e auto-qualcosa, una piccola perla scoperta da Crocetti nella sua collana Mediterranea, uscita in estate e un po’ scomparsa, è Il lago di Kapka Kassabova, poetessa, scrittrice di viaggio, romanziera, poco o per nulla conosciuta in Italia. Il lago, come spesso fanno questi libri, sovrappone storia personale, – quella di una famiglia macedone, vissuta sempre ai confini di qualcosa – con quella collettiva – la tragica ma anche affascinante e incasinata vicenda della Macedonia, e più in grande quella dei Balcani e del Mediterraneo orientale – ma la qualità più importante della scrittura di Kassabova è nel racconto dei luoghi. Luoghi che sembrano un altrove esotico sebbene siano a noi vicini e quasi familiari. Questo scenario è il lago di Ocrida, uno dei più antichi del mondo, posto ai confini tra l’attuale Repubblica macedone, l’Albania e la Grecia, e di conseguenza luogo dai mille influssi culturali, così come di rovesci storici, guerre, repressioni, fughe; «uno di quei luoghi sulla terra», scrive Kassabova, «che ti danno in serbo l’impressione di avere qualcosa di fatidico». Un lago dalle acque trasparenti sulle cui sponde sorgono villaggi, chiesette e un qualche centro di maggiore importanza, come Ocrida, città insieme levantina e balcanica, di orti e di viuzze, che Kassabova ha la capacità di farci vedere e sentire con una vividezza che appartiene solo agli scrittori veri. Leggendo Il lago la certezza di vivere in tempi in cui abbiamo visto tutto e in cui l’altrove non esiste più, inizia felicemente a vacillare. (Cristiano de Majo)






