Intervista al regista Joshua Oppenheimer, autore di uno dei film più strani ed "estetici" di quest'anno, la storia di una famiglia che canta, chiusa dentro un bunker in una miniera di sale, mentre il mondo finisce.
I libri del mese
Cosa abbiamo letto a settembre in redazione.


Uno dei libri più instagrammabili dell’anno è anche uno dei più belli (è stato finalista al Pulitzer: dell’autrice Elif Batuman, collaboratrice del New Yorker con il vizio di rubare i titoli dei suoi libri a Dostoevskij, avevamo già parlato nel numero 34 di Studio). Come a volte accade nei libri migliori, la trama non è un granché. C’è questa diciottenne di origini turche che inizia a studiare a Harvard. Vive nel campus con due coinquiline, d’inverno indossa un cappotto lungo fino ai piedi perché le ricorda quello del racconto di Gogol, è goffa (altissima, 43 di piede), studia russo, intrattiene dialoghi assurdi con i suoi nuovi amici genialoidi, si innamora di Ivan, uno studente di matematica con cui si scambia centinaia di e-mail deliranti. Due cose rendono questo libro fresco e luminoso: la personalità della protagonista, che è ciò di meno borderline e maledetto che possa esistere (non iniziamo ad averne abbastanza di personaggi femminili tormentati e dei loro traumatici ricordi?) e il modo in cui è scritto. Selin ha un buon rapporto con sua madre, non ha mai bevuto un bicchiere di vino (quando Ivan la convince a bere 2 birre, si ritrova completamente ubriaca), non ha mai fatto sesso né ha mai provato il desiderio di farlo. È buona, umile, gentile, ossessionata dalle parole (l’esplorazione del linguaggio, e in un certo senso il suo fallimento, è uno dei temi principali del libro). Non fa che leggere, scrivere, studiare, frequentare i corsi, porsi domande, condurre ricerche. Ogni tanto insegna inglese come volontaria. Niente di che insomma. Ma la voce con cui racconta la sua piccola vita di studente in una delle più prestigiose università del mondo è così tenera e buffa, e potentemente triste, a volte, e diversa da tutte le altre voci, da rendere L’Idiota un importante romanzo sulla giovinezza e sulla scrittura. Selin/Batuman ha la necessità di scrivere per elaborare il mondo, i micro-eventi della sua vita, gli altri e sé stessa, che altrimenti risulterebbero incomprensibili e vuoti (e spesso, continuano a sembrarlo). Un libro di formazione soave eppure pesante (proprio come la copertina), che non è “generazionale” o “attuale”, ma che funzionerà nello stesso modo – e cioè perfettamente – anche tra dieci anni. (Clara Mazzoleni)
Murata Sayaka, La ragazza del convenience store
Edizioni e/o, traduzione di Gianluca Coci

Capita di cominciare una lettura con il piede sbagliato e di finirla con un: wow. Ho iniziato a leggere La ragazza del convenience store per i motivi sbagliati: il libro era lì sulla mia scrivania e ne stavano parlando i miei contatti sui social, che in genere non è una buona premessa. Un’altra premessa discutibile era che l’autrice veniva paragonata a Banana Yoshimoto: non mi ha fatto nulla di male, Banana Yoshimoto, anzi, ma il limite per le letture adolescenziali l’ho passato da un po’. Peraltro, dovendo scegliere un’altra scrittrice giapponese a cui paragonare Sayaka, io sceglierei Natsuo Kirino. Comunque. Nonostante le premesse, bisogna ammettere che, se l’ultimo romanzo della 39enne Murata Sayaka è stato un caso letterario – in Giappone ha venduto più di mezzo milione di copie, negli Usa ha ricevuto recensioni entusiaste da New Yorker e New York Times, e da quel che vedo anche in Italia se ne sta parlando – se questo libro sta attirando l’attenzione, un motivo c’è. È, scusate se è poco, una storia accattivante e ben raccontata. Di cosa parla? Di una 35enne che lavora in un “kombini”, o convenience store, uno di quei minimarket giapponesi aperti 7 giorni su 7, 24 ore su 24 (se lo sapesse Di Maio!) e dove trovano impiego due categorie di persone, gli impiegati che fanno carriera interna e gli studenti alla ricerca di qualche spicciolo: per i primi è un lavoro, per i secondi un lavoretto. A queste due categorie socially adjusted, si aggiunge ogni tanto una terza: i disadattati, eternamente ancorati alla fase “lavoretto”. La protagonista, che si chiama Keiko come l’orca di Free Willy, è appunto una disadattata e una buona parte del libro è dedicata all’indagare cosa significhi esserlo. Keiko vive nel kombini, per il kombini ed è una scelta consapevole: «Non voglio fare niente per il resto della mia vita. Voglio solo continuare a respirare, fino al giorno della mia morte, senza intromissioni». (Anna Momigliano)
John Jeremiah Sullivan, Cavalli di razza
66thand2nd, traduzione di Gabriella Tonoli
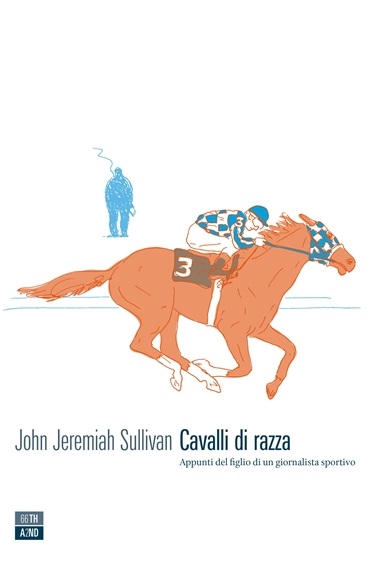 Con gli animali che popolano ancora la Terra possiamo riempire, pressapoco, due grandi diagrammi di Eulero Venn: quelli che siamo abituati a vedere intorno a noi, come cani, gatti, tartarughe domestiche, pesci rossi, e quelli che conosciamo solo per rappresentazione, diciamo la maggior parte di noi, ovvero tigri, leoni, camosci, elefanti, varani, perfino mucche e tori (chi ha mai visto una mucca trottare libera in un prato? Io fortunatamente sì). I diagrammi di Eulero Venn si intersecano, a volte, per dare vita a un sottoinsieme che ha caratteristiche comuni a entrambi i macro diagrammi (insomma, più o meno). Ecco, i cavalli stanno qui. Non li conosciamo davvero, noi comuni uomini e donne cittadini, ma ci siamo imbattuti in loro. Sono in un certo senso domestici, ma mantengono un’aura selvaggia che non riusciamo a spiegarci, o almeno non ci sono mai riuscito io, bambino atterrito davanti a quelle bestie nel recinto dello zio Paolo, che poi zio davvero non era, grandi come una casa, altere e stipate di una violenza in potenza sottolineata da ogni pelo, ogni ombreggiatura del velluto della pelle e del chiaroscuro dei muscoli. John Jeremiah Sullivan, in Cavalli di razza, esplora questo delicato rapporto tra uomo e cavallo, questa fascinazione e questo strano addomesticamento. Parte dalle corse, e gira sempre intorno alle corse – il pretesto della narrazione, d’altronde, è capire perché il padre, stimato e scomparso giornalista sportivo, avesse il pallino dell’ippica – ma in realtà crea una storia naturale e culturale del rapporto tra uomo e cavallo. Che è anche la storia del rapporto sempre molto contraddittorio tra uomo e natura – e per questo ricorda certi saggi di Michael Pollan, considerato che l’America e la colonizzazione della sua natura sono protagonisti assoluti – e la storia del rapporto tra uomo e gioco – e qui ricorda, ancora più insistente, quel capolavoro che è L’ombra del massaggiatore nero di Charles Sprawson, uno strano libro aneddotico e magico sull’invenzione e la cultura del nuoto. È il memoir di un figlio che ricostruisce a posteriori la figura del padre e allo stesso tempo un’indagine antropologica della civilizzazione umana, ma è anche un saggio in un certo senso sportivo, un piccolo trattato di storia, e un pezzo di letteratura pura grazie alla scrittura di Sullivan, quando dice cose (che riecheggiano sia Berger che i romantici) come: «Oggi quando osserviamo il corso di un fiume regolato da una diga, o un animale nella foresta che sarebbe già estinto se un legislatore di qualche paese venisse a sapere l’esatta somma di denaro che costa, o un puledro con i finimenti, ciò che proviamo, più che il sublime, è una curiosa, vaga tristesse. Abbiamo sempre creduto che quel che stavamo cercando di dominare fosse in fondo indomabile. Jefferson pensava che ci sarebbero voluti mille anni per popolare la frontiera. Non eravamo consapevoli della nostra forza». (Davide Coppo)
Con gli animali che popolano ancora la Terra possiamo riempire, pressapoco, due grandi diagrammi di Eulero Venn: quelli che siamo abituati a vedere intorno a noi, come cani, gatti, tartarughe domestiche, pesci rossi, e quelli che conosciamo solo per rappresentazione, diciamo la maggior parte di noi, ovvero tigri, leoni, camosci, elefanti, varani, perfino mucche e tori (chi ha mai visto una mucca trottare libera in un prato? Io fortunatamente sì). I diagrammi di Eulero Venn si intersecano, a volte, per dare vita a un sottoinsieme che ha caratteristiche comuni a entrambi i macro diagrammi (insomma, più o meno). Ecco, i cavalli stanno qui. Non li conosciamo davvero, noi comuni uomini e donne cittadini, ma ci siamo imbattuti in loro. Sono in un certo senso domestici, ma mantengono un’aura selvaggia che non riusciamo a spiegarci, o almeno non ci sono mai riuscito io, bambino atterrito davanti a quelle bestie nel recinto dello zio Paolo, che poi zio davvero non era, grandi come una casa, altere e stipate di una violenza in potenza sottolineata da ogni pelo, ogni ombreggiatura del velluto della pelle e del chiaroscuro dei muscoli. John Jeremiah Sullivan, in Cavalli di razza, esplora questo delicato rapporto tra uomo e cavallo, questa fascinazione e questo strano addomesticamento. Parte dalle corse, e gira sempre intorno alle corse – il pretesto della narrazione, d’altronde, è capire perché il padre, stimato e scomparso giornalista sportivo, avesse il pallino dell’ippica – ma in realtà crea una storia naturale e culturale del rapporto tra uomo e cavallo. Che è anche la storia del rapporto sempre molto contraddittorio tra uomo e natura – e per questo ricorda certi saggi di Michael Pollan, considerato che l’America e la colonizzazione della sua natura sono protagonisti assoluti – e la storia del rapporto tra uomo e gioco – e qui ricorda, ancora più insistente, quel capolavoro che è L’ombra del massaggiatore nero di Charles Sprawson, uno strano libro aneddotico e magico sull’invenzione e la cultura del nuoto. È il memoir di un figlio che ricostruisce a posteriori la figura del padre e allo stesso tempo un’indagine antropologica della civilizzazione umana, ma è anche un saggio in un certo senso sportivo, un piccolo trattato di storia, e un pezzo di letteratura pura grazie alla scrittura di Sullivan, quando dice cose (che riecheggiano sia Berger che i romantici) come: «Oggi quando osserviamo il corso di un fiume regolato da una diga, o un animale nella foresta che sarebbe già estinto se un legislatore di qualche paese venisse a sapere l’esatta somma di denaro che costa, o un puledro con i finimenti, ciò che proviamo, più che il sublime, è una curiosa, vaga tristesse. Abbiamo sempre creduto che quel che stavamo cercando di dominare fosse in fondo indomabile. Jefferson pensava che ci sarebbero voluti mille anni per popolare la frontiera. Non eravamo consapevoli della nostra forza». (Davide Coppo)







