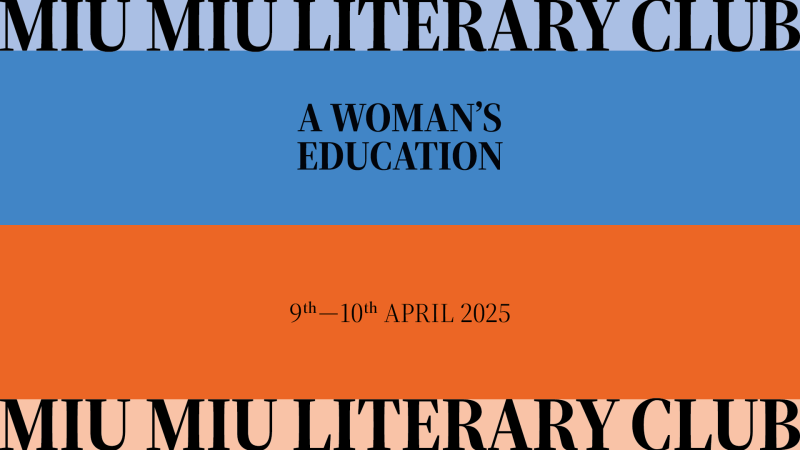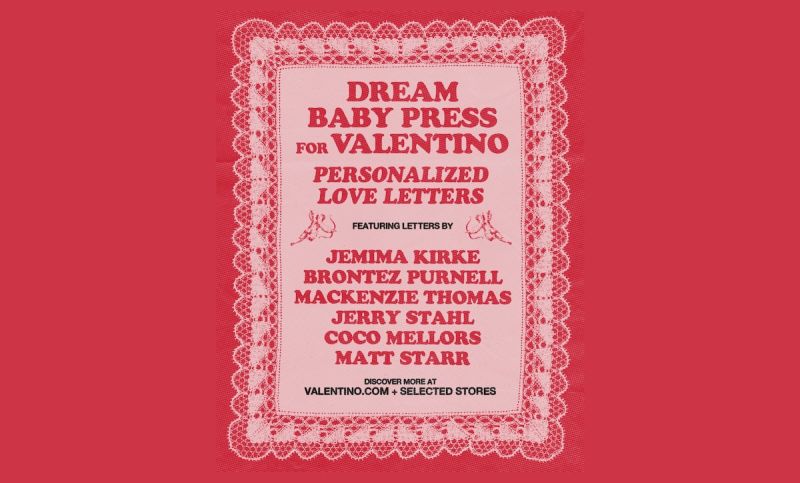Marco Bizzarri e la rivoluzione Gucci
La creatività da proteggere, il saper rischiare, le persone al centro: cosa c’è dietro al successo della celebre casa di moda italiana, raccontato in esclusiva a Studio dal suo presidente.

L’appuntamento con Marco Bizzarri, presidente e amministratore delegato di Gucci dal dicembre del 2014, è al Gucci Hub, 35.000 metri quadrati di architettura post-industriale nella periferia est di Milano. È qui che dal 2016 la casa di moda italiana ha ricollocato il suo quartier generale milanese, dove fino a qualche tempo fa non te lo saresti aspettato, così lontano dal quadrilatero dello shopping tradizionale meneghino, così vicino all’aeroporto di Linate e quindi al mondo, non distante dalla stazione ferroviaria di Rogoredo, dalla quale l’Alta Velocità si lancia, senza fermate intermedie, verso Roma e Firenze, dove Gucci conserva e custodisce sede, personale, ma soprattutto storia e origini. C’è molto della nuova Gucci, quella voluta da Marco Bizzarri, in tutto questo: il mondo da una parte, le origini dall’altra, e in mezzo una cittadella Gucci indipendente, decentrata rispetto ai canonici luoghi del lusso, plasmata a immagine e somiglianza del gusto, dei valori e dei dogmi estetici della casa, una cittadella forte ma non fortificata, più rinascimentale che medievale, e per questo mai distonica rispetto alle facce e all’ambiente circostante, di cui in qualche modo si nutre. È la partita complessa della contemporaneità, e Gucci non ha mai nascosto di volerla giocare da protagonista.
Lo scopo della chiacchierata è capire il perché di un successo, quello di Gucci negli ultimi tre anni, che ha pochi pari nella storia del lusso e della moda e che è frutto di una rivoluzione a tutto tondo: estetica, comunicativa, di modelli. Indagare, insomma, cosa c’è dietro a numeri oggettivamente impressionanti: 6,2 miliardi di euro di ricavi nel 2017, più 44,6% sull’anno precedente, con le vendite online cresciute dell’80% (fonte Repubblica, febbraio 2018). Il dato più visibile è senza alcun dubbio un lavoro creativo, quello di Alessandro Michele, che ha contribuito non poco a mappare, attraverso un raffinato e molto discusso gioco di citazioni, di riflessi e di sovrapposizioni, buona parte del bagaglio estetico contemporaneo. Se oggi i media, dal New York Times in giù, e i social media, dai quattordicenni in su, sono arrivati a sdoganare nel loro linguaggio corrente il termine “guccification”, guccificazione, l’intuizione da premiare è senz’altro quella di Alessandro Michele, celebratissimo con merito. Ma è altresì vero che se Michele è arrivato ad assumere il ruolo che ha, quello di direttore creativo unico della casa, l’intuizione da premiare è invece quella di Marco Bizzarri da Reggio Emilia, colui che l’ha fortemente voluto al suo fianco da subito, sorprendendo e spiazzando la totalità degli addetti ai lavori. La vicenda è nota: in seguito alla nomina di Bizzarri, inizia a girare una serie di nomi per la direzione creativa del marchio, una rosa di cui faceva parte praticamente la totalità dell’élite globale dei designer della moda. La scelta cade invece su Alessandro Michele, dal 2002 in Gucci con diversi ruoli nell’ufficio stile, con il quale la scintilla scatta in seguito a un colloquio richiesto da Bizzarri per meglio comprendere alcune dinamiche della parte stile e prodotto dell’azienda. Il resto, come si dice in questi casi, è storia.

Ritratti di Alessandro Furchino Capria
Dopo aver diligentemente posato per gli scatti fotografici che vedete in queste pagine, Bizzarri fa strada verso il suo ufficio, all’ultimo piano della palazzina centrale, dove iniziamo la nostra conversazione proprio dall’incontro con Michele e dall’inizio della loro avventura. Classe 1962, una colonna del gruppo Kering, cui Gucci appartiene e per il quale era già stato Ceo del settore Luxury e presidente e amministratore delegato di Bottega Veneta, Marco Bizzarri torna con la memoria a quell’inverno del 2014: «Quando sono arrivato in Gucci e mi sono incontrato con Alessandro, l’idea è stata fin da subito quella di costruire un progetto a cui tenevamo veramente, non siamo partiti dai numeri o dagli aspetti di marketing. Ci siamo detti: “Come vorremmo che fosse l’azienda in cui lavoreremo per i prossimi anni? Perché siamo nel mondo del lusso? Perché la moda ci ha interessato fin dall’inizio?”, e ci siamo risposti che la ragione era perché la moda aveva sempre anticipato le tendenze, mentre quello che avevamo sperimentato nel nostro recente passato era un mondo del fashion e del lusso un po’ troppo orientato al marketing. I prodotti erano sempre più commerciali, le campagne pubblicitarie sempre più o meno le stesse, c’erano le solite celebrity, un film trito e ritrito. E tutto questo in un’epoca in cui fuori le cose cambiavano a una velocità pazzesca! Abbiamo pensato toccasse a noi proporre qualcosa che rompesse un po’ gli schemi; il che non voleva dire essere per forza disruptive, termine di cui si abusa oggi, ma fare qualcosa che riportasse la moda alle proprie origini di anticipatore di tendenze e di veicolo primario di creatività. L’aspetto di business sarebbe nato di conseguenza. E poi ci siamo detti che volevamo vivere e lavorare in un’azienda dove alcuni valori venivano prima: il rispetto, la gioia, la passione per il lavoro che facciamo, dove le persone venivano considerate come tali. Se pensiamo, come pensiamo, che la creatività debba essere al centro di tutto il processo moda, ci siamo detti, allora le persone devono essere al centro di tutto il nostro progetto. Perché solo con le persone più brave, ma felici di lavorare qui, possiamo avere il massimo della creatività».
«È nato tutto così. Dal paradigma di un ritorno agli albori, a quello che la moda significava all’inizio: supporto e protezione al lavoro del direttore creativo, comunicazione inclusa, e poi provare a replicare questo modello e questi valori anche all’interno della parte business. La scelta di Alessandro è sicuramente dovuta al fatto di aver visto in lui un talento – che poi ovviamente è esploso in modo cento volte superiore alle più rosee aspettative –ma anche al fatto che fosse una persona con cui mi sarebbe piaciuto andare a cena, una persona normale, con dei bei valori. Tutto il resto è arrivato di conseguenza». Il paradigma del ritorno a una moda creativa e anticipatrice di tendenze, d’avanguardia, un ambiente in cui si lavora bene perché ci si diverte, queste sembrano essere le basi del patto fondante fra Michele e Bizzarri. Chiedo a Bizzarri se avanguardia è un termine in cui si ritrova; ci riflette, e dice che sì, può essere, «dipende cosa si intende per avanguardia». Fra le altre cose, per lui significa soprattutto «accettare la logica di non accontentarsi mai di quello che si fa, di non replicare sempre le stesse cose, perché poi diventa noioso. Questo deve toccare tutta l’azienda: se ci riesci, immetti creatività ovunque, ti spingi fino a realizzare idee che prima non pensavi di avere. Questo modo di fare attrae i migliori talenti dell’industria, come ci sta succedendo adesso, mentre quando sono arrivato uno dei problemi più importanti era proprio quello di acquisire eccellenza, perché l’azienda era percepita come un luogo dove non si stava proprio benissimo».
Non ci siamo fatti influenzare dai feedback esterni; proteggere la creatività fin dall’inizio è stato fondamentale per pianificare il futuro
Stressa molto l’aspetto creativo, Marco Bizzarri. Il che è comprensibile, visto il percorso della nuova Gucci. Ma un manager è un manager e il suo compito primario, alla fine, è costruire un business solido attorno a tutta questa creatività. E soprattutto capire come si trasforma un boom inatteso in un modello sostenibile sulla lunga distanza. Il pilastro, secondo Bizzarri, è saper mantenere fede alla promessa iniziale, la protezione costante della scelta creativa, giorno dopo giorno, nel quotidiano, indipendentemente dai feedback del momento. «Tre mesi dopo il mio arrivo», racconta a questo proposito, «il Financial Times scrisse che il nuovo modello di business di Gucci non funzionava perché avevamo fatto meno 9% sul trimestre. Una percezione che, secondo la vecchia logica, avrebbe dovuto compromettere la spinta forte verso la creatività che avevamo deciso di imprimere. Non ci siamo fatti influenzare, ed è stato fondamentale soprattutto nei primi dodici mesi, dove difendere le tue scelte, esternamente e internamente, senza avere ancora il prodotto nuovo visibile nei negozi, diventa molto difficile. Mi ripeto: proteggere la creatività fin dall’inizio è stato fondamentale per pianificare il futuro. Quando poi la visione si consolida, quando l’estetica viene percepita, per il consumatore diventa tutto più chiaro, come lo diventa per le persone interne a Gucci, che a quel punto si sentono più titolate a fare qualcosa di diverso. Così si crea un circolo virtuoso. Paradossalmente, quando la strategia diventa più definita e visibile, poi ti puoi permettere di scartare, di cambiare. Penso, per fare un esempio, alle sorprendenti campagne pubblicitarie che Alessandro ha fatto sugli alieni o quella sui moti del ’68. Sono un esempio per chi lavora da Gucci».

«Vale per l’estetica ma vale anche per il business: abbiamo attuato un cambio organizzativo fortissimo un paio di mesi fa, mettendo insieme le funzioni marketing, merchandising e mercati – una cosa mai successa nella storia della moda – per di più in un momento in cui l’azienda fa più 45% di ricavi sull’anno precedente. Uno dall’esterno potrebbe pensare che siamo matti a cambiare una macchina che funziona così bene, ma ci siamo resi conto che se volevamo continuare a crescere in maniera organica e genuina, tenendo alta la passione, era necessario ridurre la possibilità che all’interno dell’organizzazione ci fosse troppo controllo; bisognava lasciar correre i cavalli. Il che vuol dire, ad esempio, prendere le decisioni con un numero limitato di informazioni, anche se oggi ne abbiamo a disposizione una quantità incredibile, guardando pochi numeri, quelli giusti. E se è vero che il nostro futuro sarà la creatività, questa allora non la valuti con i Kpi (l’unità che nel marketing misura le performance dei prodotti sul mercato, ndr) ma con qualcosa di molto più intangibile. Questo vuol dire anche – e per me è la cosa più importante – accettare il fatto di non comprendere tutto. Io guardo certe campagne che fa Alessandro e mi dico “mah…”, ma lui si è meritato la mia fiducia e la mia stima, e quindi devo accettare il fatto di non capire tutto quello che fa fino in fondo. L’errore più grosso sarebbe mettersi di traverso. A questo concetto tengo molto: oggi il mondo va molto veloce, i comportamenti dei consumatori sono completamente diversi da quelli a cui eravamo abituati, ci sono certi meccanismi e certe dinamiche che non sono così facili da comprendere; è vitale ammettere di essere ignoranti, nel senso più puro del termine».
Da fuori, si fa notare a Bizzarri, non solo viene da chiedersi chi glielo fa fare di mettersi a cambiare quando le cose vanno così bene, ma come sia possibile basare un business sul cambiamento continuo in un’azienda delle dimensioni di Gucci, per cui oggi lavorano nel mondo più di tredicimila dipendenti diretti. Tutta la retorica delle start up e del mito della Silicon Valley, in fondo, è basata proprio sulla capacità delle realtà, nuove e piccole, di essere più veloci e dirompenti rispetto ai dinosauri del passato. Il tema di come si genera innovazione nei grossi conglomerati industriali è più che mai all’ordine del giorno. «Per fortuna o per sfortuna», racconta Bizzarri, «mi annoio molto velocemente e tutto quello che magari ieri mi piaceva, se lo vedo oggi fatto nello stesso modo, mi annoia. Poi bisogna anche partire dal presupposto che, se è vero che può essere uno svantaggio il fatto di essere così grandi, è anche vero che se riesci ad attivare tredicimila teste pensanti, non c’è start up che tenga. È chiaro che per farlo devi avere una struttura organizzativa veloce nel decidere, per questo credo che il nostro modello sia molto più sostenibile di certe aziende francesi, senza fare nomi: la coerenza del messaggio di Alessandro o di quello che porto avanti io a livello di business, si riversa fino nei negozi, nel prodotto, nella comunicazione, nelle vetrine. Questo avviene fondamentalmente perché c’è una persona che ha la responsabilità su tutto, mentre i modelli applicati altrove, più conservativi e più prudenti, prevedono quasi sempre due direttori creativi, uno per le collezioni uomo e uno per le collezioni donna, una società di comunicazione esterna che lavora per più brand contemporaneamente, un dipartimento marketing che decide il prodotto che va in negozio. È un meccanismo che ti tutela dal rischio, ma oggi il punto è proprio capire che chi non rischia è fregato. Essere più rapidi nelle decisioni rende più coerente il messaggio: è molto chiaro cos’ha in testa Gucci, mentre quello che stanno cercando di fare altri brand è da una parte mantenere l’esistente, preservare il consolidato, e dall’altra lavorare su una strategia pop-up, buttando fuori i prodotti nuovi e testandone il lancio su scala ridotta per paura che non funzionino. Questo fa il paio con alcune assunzioni recenti di persone, nel mondo della moda, che per concetto estetico si avvicinano molto al modo di lavorare di Alessandro, il cosiddetto mirroring; ma se poi il cambiamento non viene portato veramente all’interno del network aziendale, anche il più originale dei messaggi risulterà diluito».
Una volta dicevi: io sono Gucci, e nessuno può parlarne in modo diverso. Oggi, aprire il brand a letture esterne e libere è per noi un elemento unico
Decidere velocemente per rimanere coerenti. E qui si apre un altro fronte: come si fa a rimanerlo e contemporaneamente piacere un po’ a tutti, dai teenager europei alle star americane, dai manager asiatici all’aristocrazia mediorientale, con un coinvolgimento incredibile soprattutto dei consumatori più giovani. Il fenomeno Gucci, oggi, colpisce soprattutto per questo, «pensa», interrompe Bizzarri, «che due mesi fa sono stato invitato a parlare in una scuola e ho trovato bambini di nove anni che sapevano tutto di Gucci». A maggior ragione, non può essere solo una questione di estetica e di prodotto. «Secondo me la questione vera è la comunicazione. Il segreto è il lavoro di attivazione digitale fatto da Alessandro e dal suo team, tutte le collaborazioni avviate, più di centocinquanta nei primi tre anni, anche con artisti semisconosciuti. Penso a personalità, influenti presso alcune nicchie del mondo digitale, cui è stato permesso di interpretare in maniera totalmente libera il brand Gucci. Hai un gran da fare oggi a cercare di proteggere il tuo marchio e a fare in modo che nessuno parli di te in un modo diverso da come vorresti. Una volta si faceva così: tu dicevi io sono Gucci, questa è Gucci e nessuno può parlarne in modo diverso. Il fatto, oggi, di poter aprire la lettura del brand a persone che Alessandro trova in qualche modo coerenti con noi, ma permettendo loro veramente di dare libero sfogo e libero spazio alla propria creatività, di postare la propria visione di Gucci sui social e avere il feedback dei consumatori, è un elemento unico, distintivo. Il modo in cui Alessandro gioca con il logo o mette insieme segni iconici che prima erano separati, per esempio, credo parli in modo passionale e diretto alle nuove generazioni. Alcuni dicono “quanto siete stati intelligenti, avete ricreato Gucci”, ma in realtà non è stato così. Noi i millennial non sapevamo neppure cosa fossero, con Alessandro non abbiamo mai discusso di età di riferimento, di segmenti di consumatori. È venuto tutto di conseguenza, perché i valori che abbiamo messo in campo parlavano esattamente al pubblico presso il quale è poi esploso il brand. Non lo abbiamo fatto con un punto di vista di marketing, era semplicemente quello che volevamo fare».
La sensazione, proiettando per un attimo la rivoluzione di Gucci fuori dal settore della moda, è che Michele e Bizzarri siano in qualche modo riusciti a vincere la battaglia più importante oggi, quella del tempo e della qualità dell’attenzione che le persone, le più giovani in particolare, dedicano a questa o a quella storia, a questo o a quel marchio, in mezzo al sovraccarico informativo in cui viviamo immersi. Una battaglia che coinvolge tutti, i player tecnologici, i media, l’industria culturale e dell’intrattenimento, e che stanno vincendo in pochi. Un articolo uscito nel 2017 su la Repubblica, a commento dei risultati economici positivi, cominciava così: «La Gucci dei record aumenta ricavi e profitti come la Apple dell’era di Steve Jobs». Il paragone è ovviamente azzardato, ma è interessante sapere da Bizzarri se pensa mai, dato tutto questo, a un futuro di Gucci oltre la moda. «Onestamente non lo so», riflette il presidente.

Proprio nel giorno dell’intervista, racconta, sarà coinvolto in una riunione con il suo board per ragionare sugli scenari futuri: «Può darsi. Dipende un po’ da come evolverà tutto. È chiaro che c’è sempre più commistione tra settori che prima erano confinanti ma non sovrapposti, il mondo dello spettacolo, il mondo della tv, dello streaming, di Hollywood, tutto quanto. Non so se in futuro scatteranno meccanismi di aggregazione, può darsi: ormai la comunicazione spazia su un fronte talmente largo che non può più essere limitata a un singolo prodotto. Non so, non ne stiamo ancora parlando, ma è chiaro che siamo molto attenti».
Tornando alla moda in senso più stretto, resta da capire cosa intende Bizzarri quando sostiene che l’approccio creativo vada applicato anche al modello di business. Cosa significa all’atto pratico. «Come sappiamo, il discorso delle stagioni nella moda è finito ormai da molto: nonostante ci siano dei momenti in cui vengono presentate le collezioni, noi già oggi consegniamo i capi con tempi molto diversi. Ovviamente creiamo la novità in negozio in un certo momento dell’anno, ma non è che mettiamo tutta la collezione all’inizio della stagione e poi per sei mesi non facciamo più niente. Quando parlo di creatività nel business, intendo questo. Abbiamo ripensato completamente la catena di distribuzione; abbiamo investito pesantemente sugli artigiani, sui laboratori. Abbiamo creato l’ArtLab, 37.000 metri quadrati a Scandicci, dove abbiamo riunito tutto lo sviluppo prodotto delle scarpe e delle borse, dando vita a nuove commistioni. Stiamo comprando fabbriche e investendo sui laboratori perché crediamo che, oltre alla parte tecnologica, il saper fare rimarrà sempre un aspetto estremamente importante. Questa vitalità produttiva ci permette di mantenere la curiosità e l’eccitazione alte nel corso di tutta la stagione, pianificando con grande attenzione quando vogliamo mettere nei negozi qualcosa di nuovo, che tipo di vetrine avremo e che comunicazione ci costruiremo attorno. È tutto molto integrato».
Proviamo a chiudere il cerchio. Lui e Alessandro Michele, Alessandro Michele e lui. Alla fine, la tanto celebrata rivoluzione Gucci passa soprattutto dal loro rapporto e dal racconto che se ne fa. Il manager e il creativo. C’è una copertina del magazine System di un paio d’anni fa, diventata celebre nella moda, in cui posano insieme sorridenti, fotografati da Jurgen Teller, con uno strillo che recita «We smile, we say hello to everybody, we enjoy ourselves». È naturale chiedergli, per concludere, a che punto è il loro rapporto, se in qualche modo questi tre anni insieme l’abbiano cambiato, e come. E quanto questa voglia di entrambi di far crescere Gucci e le persone che ci lavorano abbia finito per far crescere anche loro. Bizzarri sorride (lo fa spesso, di gusto): «Sì, io sono cambiato. Alessandro, per me, è stata un’esplosione e una sorpresa continua. Lui è un ragazzo straordinario, con cui hai proprio piacere a chiacchierare. Fra di noi non parliamo mai di lavoro. Se abbiamo un problema tutti e due, o se vediamo che c’è un problema in azienda, prendiamo il telefono e ci confrontiamo. Il nostro rapporto si è evoluto in modo non conflittuale, come ho sempre sperato avvenisse fra un Ceo e il direttore creativo. Non è un problema di chi riporta a chi, abbiamo due ruoli completamente diversi. Io ho grande rispetto della sua competenza, lui di quello che faccio io, e nei momenti di intersezione ci confrontiamo. Gucci mi ha fatto crescere ovviamente: il successo che sto avendo qui non è paragonabile alle tante cose belle che ho fatto prima. Per me è stata una sorpresa, se penso che quando François Pinault mi ha offerto questo lavoro non volevo accettare, stavo benissimo dov’ero. Ma alla fine è il brand che più mi somiglia. Anche in termini di codici estetici, mi piace molto tutto questo massimalismo di Alessandro. Danno molta gioia questi colori, questa voglia di lavorare che riflette il mio credo, il grande rispetto che entrambi abbiamo delle persone e verso le persone. Poi è chiaro che non siamo perfetti, un giorno le cose vanno bene, un giorno vanno male. Ma quello che cerchiamo di dire a chi lavora con noi è: se c’è qualcosa che non funziona in azienda, alzate la mano e dite voglio cambiarlo. Come facciamo noi».
Ritratti di Alessandro Furchino Capria
Questo articolo è tratto dal numero 35 di Rivista Studio, Estate 2018