Le storie, le interviste, i personaggi del nuovo numero di Rivista Studio.
Diario da Wimbledon
In cinque capitoli, l'avventura del torneo inglese dall'inizio alla fine, raccontata sui campi ma soprattutto dietro le quinte e sugli spalti, dal nostro scrittore-inviato.
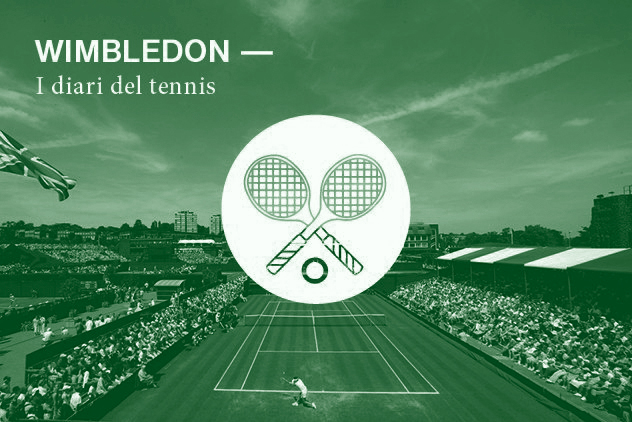
I • You’re at Wimbledon
Bisogna cominciare dalla fine di questi primi due giorni a Wimbledon, perché non era mai successo che Rafael Nadal perdesse all’esordio in un torneo del Grande Slam, e invece dopo 35 partecipazioni si è trovato sconfitto tre set a zero dal numero 135 del mondo, il belga Steve Darcis. Lui che qui ha vinto due volte, sfatando ormai da tempo il mito dell’essere solo un terraiolo, lui che quest’anno sinora quasi non aveva mai perso e invece, dopo aver strappato l’ottavo Roland Garros, calca un prato verde e si trova senza armi per affrontare la battaglia. Bisogna cominciare dalla fine anche perché era nell’aria sin da subito, da quando la mattina della vigilia del torneo ho percorso Wimbledon Park Road, e bandiere di colore verde e blu mi segnalavano che dopo dodici minuti di cammino sarei arrivato ai cancelli dell’All England Lawn and Tennis Club. Lungo la strada, persone con in mano sacchi a pelo, zaini e buste di vario tipo mi suggeriscono l’avvicinarsi della meta: i coraggiosi e gli entusiasti che si apprestano a fare la lunga fila per acquistare qualche biglietto. O meglio “La Fila”, come qui la chiamano, la pratica regolamentata di passare una notte accampati in ordine di arrivo nella speranza di poter acquistare gli ingressi che vengono messi in vendita il giorno stesso degli incontri. Passato il viale imbocco Church Road, dove i gate del Club si presentano come i bastioni di un segreto ben custodito, mentre mi vengono offerte salviette rinfrescanti e leggo le indicazioni per raggiungere un posto che si chiama Gatsby Club.
Quando esco dalla sala stampa, l’atmosfera solenne dell’incontro mi ha condizionato al punto di avere la netta sensazione di sentire profumo d’incenso
Che un Nadal potesse cadere all’esordio si poteva intuire anche solo vedendo lo staff del Club che spolvera e spruzza su lampade, maniglie, vasi e qualsiasi altro orpello, come se ogni viale e spiazzo di quel posto fosse da curare come l’interno di un’abitazione elegante. Ma soprattutto per l’atmosfera della sala stampa, illuminata da una luce soffusa e da eleganti elaborazioni grafiche dei trofei maschile e femminile, luogo che visito nel giorno in cui mette a disposizione i defending champions, ben separati dagli altri contendenti che sono stati offerti alla stampa il giorno prima. Pochi minuti dopo il mio ingresso arriva dunque Federer, che l’anno scorso vincendo Wimbledon ha generato un ingorgo di primati, conquistando il settimo titolo, tornando numero 1 e automaticamente ottenendo il record assoluto di settimane complessive al comando della classifica, il tutto in un solo momento, quando dopo un passante fuori di Andy Murray al secondo match point si è lasciato cadere a terra, mentre il manico della racchetta abbandonata per portarsi le mani al viso gli ha delicatamente lambito la punta di una scarpa, prima di adagiarsi al suolo. Federer entra in sala stampa e nel torneo come un condannato a morte, perché si presume dovrà incontrare Nadal nei quarti di finale e nessuno lo ritiene in grado di batterlo. Visto che ormai lo considerano un senatore a vita piuttosto che un giocatore, gli chiedono dell’evoluzione del gioco, e lui dichiara di provare «regret» perché «i tornei hanno rallentato le superfici», e «il serve & volley è troppo difficile contro i più forti». Mentre i giornalisti sembrano fare a gara a chi sussurra più piano le domande, Federer dichiara «preferisco sempre guardare il gesto di un rovescio a una mano piuttosto che uno a due mani»; quando esco dalla sala stampa, l’atmosfera solenne dell’incontro mi ha condizionato al punto di avere la netta sensazione di sentire profumo d’incenso, di cui non riesco a capire la provenienza.
Come se avesse avuto in mano una bambola da riempire di spilli, Federer si è poi trovato un Nadal crocifisso dal modesto rovescio a una mano del peón Darcis, un paio di ore dopo che lo svizzero aveva calcato per primo il nuovo manto erboso del centrale, dove con un piglio più sicuro e gioioso di quello mostrato nei giorni del Roland Garros aveva demolito il rumeno Victor Hanescu in un’ora e otto minuti, esattamente il tempo in cui Nadal ha ingloriosamente perso il primo set al tie-break contro Darcis. Quando gioca male Nadal manifesta tutta la farraginosità della sua tecnica: il movimento a lazo del dritto che gira attorno alla testa e la rotazione folle che dà al colpo diventano inutile dispendio di energia, con la palla che muore a rete o carambola fuori, ricordando la sensazione che si prova lanciando con tutta la forza un pezzo di carta appallottolato. Infine la spasmodica ricerca del dritto e gli ampi spostamenti laterali fatti per girare attorno alla palla, che somigliano alle manovre di un granchio impazzito.
Poi vedo ovunque briefing all’aperto degli addetti alla sicurezza del torneo, capannelli di persone tutte vestite come dei simpatici capotreni in completi blu scuro, il cappello con la visiera larga ben calcato, e mi sembra di scorgere i segni di una cospirazione contro chi, come lo spagnolo, osa anteporre la vittoria allo stile. Me ne rendo conto appieno quando chiedo di visitare l’area dedicata agli allenamenti: poiché i campi in erba si usurano, va da sé che le practice session debbano svolgersi su altri court, per non danneggiare quelli in uso per il torneo. Il luogo in questione si chiama Aorangi Park, e si trova dietro il Court n. 1. L’Aorangi è il non plus ultra dell’esclusività, pochi eletti che circolano attorno a campi dove a un metro da te si allenano tutti i più grandi. Li ascolti mentre chiacchierano nelle lingue native con i loro entourage, ne vedi alcuni con occhi cisposi forse dovuti a stanchezza, guardi il loro fare dinoccolato, quella noncuranza particolare che hanno gli sportivi mentre si allenano. Soprattutto quelli che passano il loro tempo su un manto erboso, cosa che ho imparato a riconoscere quando ho visto per la prima volta dei calciatori fare ginnastica e dare qualche calcio al pallone: ho scoperto che sono solo ragazzi immersi in un ambiente pieno di vibrazioni positive, ingiustamente tutte indirizzate verso di loro. La prossimità con l’erba è la chiave di quest’aria sublime, e nel tennis si traduce in una serie di visioni commoventi: il rimbalzo morbido ma teso della palla, i fili verdi cortissimi e fittissimi che sembrano piegarsi sotto l’impatto, lasciando come un immagine latente della piccola sfera, e poi l’odore del prato, un odore di pace, di armonia, la natura addomesticata al servizio di un leisure profondamente gentilizio.
Guardare una distesa di campi in erba è un’esperienza che smuove ricordi d’infanzia, emozioni private che vengono da lontano, pomeriggi al parco in compagnia di qualcuno a cui si tiene
Intossicato da un benessere che in realtà non mi appartiene all’improvviso mi trovo a sorridermi con Flavia Pennetta, dopo che il suo allenatore passandomi accanto fa una battuta in spagnolo su Nicolas Almagro, che palleggia poco più giù; io la battuta non l’ho neanche sentita, ma quando lei mi ha guardato leggermente imbarazzata è stato bello fare finta di capirci. Guardare una distesa di campi in erba è un’esperienza che smuove ricordi d’infanzia, emozioni private che vengono da lontano, pomeriggi al parco in compagnia di qualcuno a cui si tiene, con il vociare distante, il vento leggero, e tutti come assorti in un costante stato di piacere fisico. Se distogli lo sguardo dalle uniformi e gli auricolari degli agenti a controllo dei varchi puoi anche dimenticare di essere stato ammesso per soli 40 minuti in un luogo di eccellenza sportiva, perché neanche i tennisti tutti attorno sembrano dei professionisti, li vedi che ridono e sudano come faresti tu, e ti chiedi se come te anche loro pensano “ma guarda dove sono”, mentre ciondolano assorti sul campo, dando la sensazione di soppesare l’erba che si abbassa sotto i loro passi, come quando si schiaccia la neve sotto le scarpe.
Vedi gli orari delle sessioni di allenamento che si sovrappongono, e allora coppie di giocatori si dividono lo stesso campo, palleggiando lungo i corridoi a due a due, la palla che a volte schizza via dopo essere rimbalzata su un’altra a terra, come capita alle persone comuni. C’è anche l’americano Ryan Harrison ad allenarsi, quest’anno sta faticando molto, lui che vive con il fardello di dover essere la nuova promessa americana, un impegno che sta cominciando a non mantenere. In Australia dopo una batosta presa contro Djokovic aveva detto «So come dovrei giocare, il problema è riuscire a farlo».
Non è certo il problema di Serena Williams, per la quale oggi non sembra esserci ostacolo alla vittoria continua. Le chiedono della pressione di dover difendere il titolo, lei risponde «Non sono costretta a farlo, ma vorrei tanto riuscirci». A pochi è concesso di considerare la vittoria non una necessità, ma come un privilegio a portata di mano. Vincendo supererebbe la sorella Venus nel numero di vittorie a Londra, e Venus quest’anno non partecipa per problemi alla schiena. Serena racconta che la sorella le ha detto di non preoccuparsi, e di provare a superarla. «Snap out of it, it’s time for you to pass me», Serena ci ha riportato così le parole di Venus, e te le immagini mentre si dicono queste frasi da film con i loro sorrisi bianchissimi, inondate di endorsement e illuminate dal bagliore delle bacheche piene dei loro trofei.
«Please enjoy yourself and have a wonderful day, you’re at Wimbledon», viene detto dagli altoparlanti subito prima che entrino in campo i giocatori, il primo match dell’anno su qualsiasi court del Club. Molti ground qui hanno capienze a sedere di cinquanta-sessanta persone, giusto due file di panchine di legno ai due lati del campo. Gli arbitri e i giudici di linea sembrano i padroni del luogo, alteri ma ospitali nelle loro divise Ralph Lauren e la scoppola in testa. Poi vedi le palline agitate prima di essere usate per controllare che non abbiano difetti, i pali di legno chiaro agli estremi della rete, con le manopole per regolare l’altezza che brillano nel loro rivestimento ramato, la staffa di metallo verde scuro per verificare l’altezza della rete, ma non un metro qualsiasi, una specie di unità di misura senza tacche che sembra venire da un museo della civiltà. Anche il palleggio di riscaldamento che osservo all’inizio del primo turno tra Benoit Paire e Adrian Ungur comincia in modo molto delicato, come a far abituare l’erba alla loro presenza. Difficile non pensare al fondocampo che già comincia a guastarsi sotto agli occhi, ancora lussureggiante ma già segnato dai passi nervosi dei giocatori. Pochi punti e già Paire guarda il verde sotto di lui, come per chiedergli ragione dei suoi errori.
Il Centre Court che attende Federer in realtà è il primo campo che vedo davvero immacolato, tutti gli altri sembrano portare dei leggeri segni di usura sin da prima di essere inaugurati. Si applaude educatamente all’ingresso di raccattapalle e giudici, nella foto sul tabellone l’avversario Hanescu è ritratto con la classica fototessera usata nel suo profilo ufficiale, mentre di Federer usano un ritaglio di un’immagine di quando ha vinto l’anno scorso, sorridente e sudato, si intuisce il trofeo alzato dalla posizione delle braccia. Qui sono proprio affezionati all’idea dell’atleta dandy, non resistono.

II • Il mercoledì nero
C’è altro a cui pensare oltremanica in questi giorni, con la spending review che sta gelando il sangue dei britannici e di alcuni persino le case, visto che si è deciso di tagliare addirittura il bonus riscaldamento dei residenti all’estero (ma solo in paesi con temperature medie superiori al Regno Unito). Ci si mette anche la Regina, il cui stipendio è stato aumentato del 5%, e poi George Osborne, il Cancelliere dello Scacchiere altrimenti detto Ministro delle Finanze, che per mostrarsi uomo del popolo twitta una sua foto mentre prepara l’ultimo discorso seduto di fronte a un hamburger; ma il Sun lo smaschera, perché quello non è un triviale Big Mac da un pound o poco più ma un panino gourmet che costa l’esagerato prezzo di 9 sterline e 70 (“Shamburger”, titola il tabloid). Insomma presi da quest’estensione incontrollata della lotta di classe cosa vuoi che gliene importi agli inglesi che il terzo giorno di Wimbledon è stato ribattezzato per i posteri il Black Wednesday, il giorno in cui sono caduti, letteralmente e figurativamente, quasi tutti i padroni del torneo. Proprio come il mercoledì nero del settembre 1992 quando, e sono fatti di cui non comprendo minimamente la natura, la sterlina in svalutazione a picco uscì dal Sistema Monetario Europeo, e George Soros guadagnò un miliardo e passa di dollari in un solo giorno alla faccia del governo britannico. Dopo aver letto diversi bignamini sull’argomento ho rinunciato a sperare di comprendere, un po’ come ho fatto all’All England Club dopo aver assistito a troppi eventi per cui non posso trovare spiegazione.
Se il mondo fosse un luogo più spiritoso Dustin Brown sarebbe il numero 1 del mondo, e vincerebbe tutti i suoi trofei solo dopo aver salvato match point con volée o colpi dietro la schiena.
La giornata era iniziata dirigendomi a passo svelto verso il campo numero 2, uno di quegli impianti di media taglia che poi sono i court migliori di ogni torneo, capienti a sufficienza da creare la sensazione di una folla, piccoli tanto da permettere di leggere le espressioni sui volti dei giocatori da qualunque posto. In programma il secondo turno tra ‘Rusty’ Lleyton Hewitt e un tale Dustin Brown: leggenda tra gli appassionati psicotici che passano il tempo su streaming monocamera di tornei minori, non solo Brown ha un nome da stand-up comedy o da eroe dei fumetti, in più è metà tedesco e metà giamaicano, porta dei lunghi dreadlock e di solito, almeno per qualche minuto a match, è in grado di praticare un tennis eccezionale, tra servizi missile, badilate in risposta che prendono righe a ripetizione, e soprattutto un gioco a rete da circo. Vince il primo set con una volée in tuffo che ricorda le acrobazie in porta nelle partitelle in spiaggia, con quella stessa nonchalance incoraggiata dalla morbidezza della sabbia. Se il mondo fosse un luogo più spiritoso lui sarebbe il numero 1 del mondo, e vincerebbe tutti i suoi trofei solo dopo aver salvato match point con analoghe volée o colpi dietro la schiena. Ma poiché la ripetizione conta sempre più della differenza, Dustin è numero 189 del mondo, best ranking in carriera n. 89 e nessun torneo vinto nel circuito maggiore. Per quanto Hewitt sia un trentaduenne rattoppato è pur sempre un ex numero 1 che ha vinto Wimbledon e U.S. Open, quindi vado a vedere l’incontro sperando giusto di assistere a qualche sprazzo da entertainer, e invece Brown finisce per vincere in quattro set, mettendo insieme una quantità irragionevole di ricami acrobatici con cui giunge per la prima volta al terzo turno di uno Slam.
Lascio il campo soddisfatto delle piccole concessioni che l’inesorabile darwinismo atletico a volte concede, e non sono il solo a pensare che possa essere la storia della giornata. Quando Dustin appare in conferenza stampa con i dreadlock raccolti in un cappellone rigorosamente bianco, Clerici (sempre lui) gli chiede se abbia mai pensato di dedicarsi alla pittura, vista la mano delicata che ha mostrato nelle demi-volée. Nessuno può ancora immaginare che la sua vittoria è solo il primo segnale di un’onda anomala che sta per portarsi via tutte le certezze di questi Championships. Mentre pasteggio di fronte alla vetrata del ristorante dei giornalisti, aristocraticamente affacciata su una serie di campi offerti allo sguardo come immagino un villaggio si presenti al signorotto dal suo castello, scopro che in un paio d’ore si sono già ritirati cinque giocatori, mentre molti altri scivolano e si lamentano del prato insidioso. I ritiri saliranno a sette (un record), le scivolate a decine, ma sono solo altri presagi delle detronizzazioni che seguiranno. Entro al campo n. 2 giusto in tempo per vedere Maria Sharapova perdere contro la n. 131 Michelle Larcher de Brito, mentre due ore prima Victoria Azarenka si era già ritirata prima ancora di scendere in campo contro Flavia Pennetta. In mezza giornata il tabellone femminile ha perso la seconda e la terza giocatrice, dopo che Nadal era uscito subito a inizio settimana, anche lui per mano di un avversario ben sotto la centesima posizione.
Con una certa apprensione dunque si è cominciato a seguire il match di secondo turno di Federer contro Sergiy Stakhovsky, che essendo classificato n. 116 viene ormai considerato da tutti un pericolo, l’ignoto di chi non ha nulla da perdere, che si abbandona al verde imprevedibile contro la razionalità e le false sicurezze dei campioni, infastiditi da un manto che sembra avere vita propria. E così è stato. Stakhovsky, conscio di non poter combattere a armi pari da fondocampo, non ha fatto altro che attaccare su ogni punto, mettendo in pratica quello che tutti si affannano a dire sia ormai morto: il serve & volley. Durante la prima ora, quanto tutto appare ancora sotto controllo, certo il match è un po’ troppo tirato per essere un secondo turno di Federer ma tant’è, osservo un giornalista seduto accanto a me, completo di lino chiaro, capelli grigi lunghi raccolti in una coda e un foulard leopardato al collo, che prende appunti in un’elaborata grafia illegibile che ricorda gli antichi caratteri di un codex benedettino. Solo quando Stakhovsky ormai si sta impossessando anche del tie-break del quarto e ultimo set, e contro ogni opinione sul tennis moderno continua a attaccare, a togliere il tempo, a seguire prima e seconda di servizio a rete – e lui lo sta facendo contro il sette volte campione del torneo che più nella storia ha celebrato quello stile di gioco – solo all’ennesimo colpo sotto rete coraggiosissimo e delicatissimo che questo semisconosciuto piazza ben lontano dalla superbia e dal broncio del Maestro ormai detronizzato, solo a quel punto allora il mio distinto collega perde un po’ del suo fare aristocratico e riesco a leggere per la prima volta una delle sue note, resa forse elementare dalla confusione che tutti stiamo provando di fronte agli accadimenti: “Volley!”, scrive il giornalista, come se quel punto esclamativo lo aiuterà a ricordarsi quali emozioni ha generato quel preciso momento dell’incontro.
«Contro Connors e Borg è come venire colpiti da una mazza, ma con McEnroe, lui usa il pugnale. Un colpo di striscio qui, un taglio lì, e in poco tempo ti trovi coperto di sangue».
Lo diceva anche Arthur Ashe, quando provava a spiegare la differenza tra giocare contro Borg o Connors rispetto a McEnroe: «Contro Connors e Borg è come venire colpiti da una mazza, ma con McEnroe, lui usa il pugnale. Un colpo di striscio qui, un taglio lì, e in poco tempo ti trovi coperto di sangue». Sarà questo che ha provato Federer, dopo tre ore passate a combattere con un rivale che non gli ha concesso ritmo, che ha sempre cercato di prendere possesso dello scambio, che non ha avuto paura di fallire? In fondo è questa la grossa differenza, il tennis su terra è uno sport d’attrito, quello su erba è uno sport di iniziativa, si agisce per accorciare lo scambio, mettere l’altro in una situazione in cui non può più gestire il colpo. Si cerca di sfuggire alla stessa superficie di gioco, perché il campo non tollera indugi e temporeggiamenti, avvelena la palla a ogni rimbalzo, non permettendo quelle lente trame che si compongono giocando sull’argilla. Era sanguinante Federer quando ha lasciato il campo dopo la sconfitta? Dopo 36 quarti di finale consecutivi esce da un torneo dello Slam al secondo turno, come non gli capitava dal 2003, da ben dieci anni. A rete i due avversari si parlano a lungo, quasi si abbracciano, chissà se Stakhovsky si rende conto di quello che ha fatto.
Lo scoramento di Federer era talmente tracimante che anche di spalle il suo saluto uscendo dal campo mi è parso carico di dramma. Neanche ha aspettato l’avversario per andar via, come il protocollo imporrebbe, e tante sono state le ferite subite che non sembrava neanche più vestito di bianco, come se fosse avvolto in un nero frutto del suo lutto regale. Subito dopo con i giornalisti è apparso di nuovo composto, parlando di tornare a lavorare presto e del fatto che intende giocare ancora per “many more years“, con quell’indefinito temporale tipico delle dinastie, infastidite dal doversi misurare su una durata oggettiva.
A fine giornata torno sulla mia terrazza signorile per riflettere sugli eventi trascorsi, mentre osservo i campi sotto di me che vengono messi a dormire. Si tratta di una procedura elaborata, che inizia con una copiosa annaffiata con getti d’acqua vaporizzati nell’aria, seguita dalla distesa del telo sopra il terreno di gioco. Dopo poco il telo, al centro un grande logo del Club con le racchette incrociate, comincia lentamente a gonfiarsi grazie a un getto d’aria liberato da sotto, che in una decina di minuti lo trasforma in una collina vibrante che veglia sopra il fragile verde naturale. Sarebbe bello se tutto il torneo venisse scandito da simili sorprese, una sequela di sconosciuti che riescono a compiere col poco che hanno le grandi imprese che i campioni fanno avendo a disposizione tutto ciò che desiderano. Ma la paura è che le sorprese siano già finite, bruciate nel fuoco troppo intenso di una sola giornata, troppo presto. Difficile immaginare chi altro tra i sopravvissuti possa inventarsi una storia diversa ormai. Serena Williams appare ormai sola che passeggia con calma verso la difesa del titolo, Djokovic e Murray, su parti opposte del tabellone, non hanno né l’età né le idiosincrasie tradite in questi giorni da Federer e Nadal, ed è difficile pensare che qualcuno possa sbarrargli la strada verso lo scontro diretto in finale. Non resta che continuare a scrutare quei teli gonfi sui campi che sembrano un po’ come delle pance, e sperare che siano davvero in dolce attesa di altri colpi di scena.

III • Manic Monday
Per cogliere lo spirito dell’All England Club non è necessario passare le due settimane del torneo tra l’edera che ricopre dolcemente i muri dei campi, basterebbe procurarsi una copia del Wimbledon Compendium che viene fornito quando si ritira l’accredito. Dietro la copertina patinata che ritrae i campioni in carica del singolare maschile e femminile si cela un tesoro di informazioni più o meno improbabili, elencate in uno stile senza tempo. Il tutto stampato su una carta inutilmente lucida, in un carattere tipografico vecchio di decenni. In realtà già lo shot glamour della copertina tradisce un attaccamento a rituali così codificati e impolverati da suscitare un’immediata simpatia: i due vincitori, ingessati negli abiti della circostanza e nella posa obbligata, sono resi ancora più buffi dall’essere obbligati a indossare un tondino appuntato sul vestito, con su stampato in oro il nome del Club, l’anno, e poi con una striscia bianca su cui si leggono i loro nomi, scritti a penna. Come un paio di reclute che hanno superato un esame, i vincitori del torneo di tennis più importante del mondo si agghindano per bene – e fino a qualche anno fa dovevano anche fare un ballo insieme, – per poi vedersi attaccata addosso una spilletta usa e getta col proprio nome scribacchiato, come un marchio a ricordare quanto transitorio sia il trionfo, quanto facilmente ci si dimenticherà di loro per passare oltre come se nulla fosse accaduto.
Dentro il volume si fornisce l’elenco di coloro che hanno giocato una finale indossando occhiali da vista, oppure chi indossava una fascia in testa o un cappello.
Dentro il volume poi viene riportata ogni sorta di amenità con estrema serietà e scrupolo: ogni edizione del torneo utilizza circa 54250 palline, non la solita media piena di zeri tanto per dare un’idea, ma una stima di decine di migliaia, spalmata su decenni e decenni, valutata in un’approssimazione di poche unità, perché qui i fatti sono importanti. Come è importante fornire l’elenco di coloro che hanno giocato una finale indossando occhiali da vista (con liste diverse tra vincitori e finalisti), oppure chi indossava una fascia in testa o un cappello, con la specifica del tipo di accessorio, marca e modello; poi c’è la lista dei giocatori ambidestri, le variazioni del costo del noleggio di cuscini per gli spettatori, gli anni in cui i diversi campi sono stati muniti di teloni di copertura, la cronologia delle invasioni di campo. La prima documentata, nel 1949: «La sfida tra A.C. van Swol e R. Abdessalam era da poco iniziata quando uno scoiattolo ha fatto la sua comparsa sul Centre Court. I giocatori si sono concessi un attimo di relax mentre i raccattapalle scacciavano l’animale». Oppure il 1998: «Un topo ha interrotto il gioco durante l’incontro tra Y.A. Kafelnikov e M.A. Philippoussis». Quasi tutti i giocatori hanno anche l’iniziale del secondo nome, di cui ovviamente non si trova traccia da nessun’altra parte. La storia delle invasioni sembra lo specchio delle epoche che hanno attraversato il XX secolo. Ecco il 1981: «L’incontro tra Miss S.D. Barker e Miss A.K. Kiyomura e Miss J.C. Russell e Miss V. Ruzici fu interrotto per oscurità alle 9:35 p.m., sul punteggio di 5 pari nell’ultimo set. Tra urla e fischi diversi cuscini, programmi ufficiali e altri oggetti furono lanciati in campo». Poteva succedere solo negli anni ’80. Si prosegue con le descrizioni delle condizioni metereologiche delle varie edizioni, che spesso assumono i toni delle massime elusive de I Ching: «1976. Il torneo più caldo di sempre. Nessun sollievo in una calura rovente dall’inizio alla fine. Niente pioggia per tutto il torneo». Oppure: «1984. Tempo eccellente – Solo due giornate momentaneamente guastate da pioggia.»
Residui di questa adorabile assenza di ironia si trovano tutt’oggi anche nei materiali prodotti a getto continuo per la stampa, come l’elenco delle presenze nel Royal Box del Centrale, di cui viene fornito un aggiornamento quotidiano: una lista di personalità riportata con il cognome sulla sinistra e poi un «Mr & Mrs» scritto accanto, seguito dal solo nome di battesimo dell’uomo, con quello della donna tra parentesi, così: «Mr & Mrs Harry (Judy)». Immagino che questo tipo di identificazione sia riservato alle coppie sposate, perché in altri casi figurano entrambi i nomi, a volte con il Mr o la Mrs sostituiti da un «Dr», probabilmente un marchio di carenza nobiliare mascherato da titolo professionale, a rimarcare i segni della gretta borghesia. Che poi il pubblico di Wimbledon ce lo immaginiamo tutto così, ed è vero che qui si incontrano costantemente creature che sembrano galleggiare sopra le banali faccende della vita. L’alta società la noti da tante piccole cose: i sorrisi inespressivi, i capelli e gli abiti ben tagliati, oppure dei pantaloni bianchi attillati portati su tacchi alti in un giorno di pioggia, lasciati serenamente a picchiettarsi di macchie di fango sui polpacci. Vanno in giro contenti con le loro caraffe di Pimm’s, il bibitone alcolico nazionale che sa di zenzero, dolciastro, servito pieno di ghiaccio e limone e che dopo pochi sorsi dà subito uno stordimento iperglicemico, ideale per assistere distrattamente a tutto il circo che si svolge attorno al proprio privilegio.
Ma non ci sono solo loro, c’è anche la società civile che per qualche giorno all’anno è irretita dall’armonia campestre del lawn tennis, e si accampa e fa notte per ottenere un biglietto. La vado a trovare nella domenica di mezzo, quando non si gioca, unico Slam che si prende il lusso di non prevedere incontri nel potenziale giorno di maggiore incasso. Arrivo su un pratone invaso da tende, rigorosamente disposte in un labirinto corrispondente all’ordine di arrivo e che si tradurrà in un’ordinata fila al botteghino l’indomani (o dopo due o tre giorni, a seconda di quando e cosa si vuole acquistare). Si gioca a racchettoni, a pallone, badminton e persino a rubgy usando i sacchi a pelo come ovale. Si mangia cibo in scatola, si beve birra, non si possono fare barbecue e alle 10 di sera scatta la consegna del silenzio, pena espulsione dalla Fila per i molesti. Fa bel tempo, sarebbe stato interessante venire a vedere cosa facevano queste migliaia di poveri cristi se avesse piovuto. Gli ultimi quattro giorni del torneo la Fila però non ci sarà più, a quel punto la scala sociale interviene per annunciare che i giochi sono finiti, e solo un’indistinta massoneria può entrare per assistere a semifinali e finali.
Vado a parlare con i primi della Fila, sono arrivati di venerdì mattina, quasi 72 ore prima della messa in vendita dei biglietti per il Manic Monday.
Vado a parlare con i primi della Fila, sono arrivati di venerdì mattina, quasi 72 ore prima della messa in vendita dei biglietti per il Manic Monday, il leggendario lunedì della seconda settimana dove si giocano tutti gli ottavi di finale, bruciandoli in un sol giorno in una sorta di potlatchtennistico, il rito dei Nativi Americani in cui vengono distrutti beni di valore per cementare le relazioni nella comunità. Il primo della fila si chiama Chris, è basso, pelato e muscoloso e quindi fortemente anti-tennistico, ma viene qui a campeggiare dal 1983, fino a oggi ha mancato solo sei edizioni. Seconda in ordine di arrivo c’è una distinta signora che viene da una decina d’anni, da quando ancora la Fila si faceva solo sui marciapiedi che portano ai gate e non sul pratone come adesso, dopo che finalmente il city council si è deciso a concederne l’uso. Wanda Thornburrow, così si chiama, con quel cognome deliziosamente astruso come fosse l’invitata di una cena degli equivoci scritta da P.G. Wodehouse. Nei primi anni ’60 giocava a tennis e una volta a Wimbledon, da junior, si è tolta lo sfizio di battere Virginia Wade, l’ultima britannica a aver vinto uno Slam. Ma non me l’ha detto lei, l’hanno spifferato i vicini di tenda, perché lei non ne vuole molto parlare, dice che non si ricorda neanche l’anno, e che poi all’epoca era diverso, lo facevano solo per divertirsi. Wanda mi dice anche che sull’asfalto l’attesa era comunque molto divertente, con i poliziotti che a sera si univano ai pellegrini del tennis per tirare due calci al pallone.
Poco dopo, mentre mangio una pizza in un locale nei dintorni, ascolto le chiacchiere di un quartetto di italiani che si prendono una pausa dal campeggio forzato. Parlano a alta voce con l’eccitazione di chi si conosce da poco e si sta simpatico, con la solidarietà istintiva dei connazionali all’estero. Afflitto da un’inattesa solitudine vorrei unirmi a loro, per partecipare alle chiacchiere alcoliche su trasferte improbabili da un torneo all’altro. Ma qualcosa mi trattiene, sento la conversazione virare verso temi più personali, il gruppo è già consolidato. Due sono di Roma, gli altri due hanno un accento veneto; uno dei romani lavora in un centro estetico, l’amico accenna a un suo aneddoto speciale, lo incoraggia a raccontare la vicenda. Ma con un avvertimento: «Nun te la brucia’ sta storia, stamo a Londra, nun te capita più».
Anche il lunedì degli ottavi è bruciato in fretta come un cerino, ed è vero che ci sarebbe da parlare di Serena Williams che ha perso, ma è storia già passata. Che cadano favoriti ormai quest’anno è diventato normale, e il torneo femminile, ormai delineati i quarti di finale, presenta un’incertezza su chi potrà essere la vincitrice come non capitava da anni. Diverso il discorso per il singolare maschile, ormai poche o nulle le incognite sulla via della finale Murray-Djokovic, quasi tutti i giovani di buone speranze sono stati mandati a casa un’altra volta. Però è rimasto un polacco alto più due metri che si chiama Jerzy Janowicz: un anno fa non lo conosceva nessuno, oggi lo guardano tutti un po’ preoccupati. Serve a 240 all’ora ma sa dare anche qualche carezza alla palla, in più l’anno scorso ha persino battuto Murray salvando un match point. Qui dopo aver vinto il suo ottavo di finale si è inginocchiato, perché mai era arrivato ai quarti di uno Slam. Subito dopo si è messo a firmare autografi a decine di persone, con una foga che tradiva l’estrema voglia di farlo, come se li firmasse per se stesso e non per i fan. È affascinante osservare gli atleti in quel momento magico in cui sono ancora tra di noi, ci parlano e ci sorridono, ma sono già oggetto di profonda ammirazione. È una finestra breve, poi impareranno a essere cordiali e disponibili, ma firmeranno gli autografi con un altro sguardo, con una forma di assenza che è necessaria a difendere la propria persona dal loro personaggio pubblico. Jerzy ancora non è arrivato a quel punto, e oggi ha autografato persino le sue scarpe e le ha lanciate tra il pubblico; poi gli hanno chiesto che taglia ha di piede e lui ha risposto, dice che porta il 49.

IV • Che la festa abbia inizio
“Signore e signori, come cortesia verso i giocatori, possiamo per favore tornare a seguire quest’incontro?”
Questa l’aria che tira nel quarto di finale dei poveri, mentre a neanche cento metri di distanza l’eroe di casa Andy Murray sta recuperando uno svantaggio di due set a zero contro Fernando Verdasco. Le esultanze lontane che accompagnano la lunga ma inesorabile risalita di Murray fino alla vittoria per 7-5 al quinto contagiano gli spalti mezzi vuoti del Court n. 1, dove si sta disputando il derby che garantirà per la prima volta nella storia alla Polonia un semifinalista in un torneo dello Slam. I connazionali in lotta sono Lukasz Kubot, 31 anni e numero 130 miracolosamente scivolato tra le larghe maglie del tabellone decimato, e la rising star Jerzy Janowicz, che alla fine vince facile in tre set. Dopo si scambiano le maglie, si abbracciano a lungo, piange uno, forse un po’ anche l’altro. In un’atmosfera a metà tra l’ultima domenica di campionato e l’ascolto di una trasmissione clandestina di Radio Londra, il pubblico rimasto dentro aspetta i cambi campo solo per leggere sui tabelloni gli aggiornamenti sul punteggio dell’altro incontro.
Henman Hill, così chiamata d’après Tim Henman, il tennista britannico più vincente. Ma il record è svaporato con l’ascesa di Murray, assieme all’esagerato soprannome di Timbledon, quindi la collinetta non sanno più come chiamarla.
Molti spettatori hanno invece optato direttamente per disertare il match e arrampicarsi sulla collina con lo schermo che mostra Murray-Verdasco, nota come Henman Hill. Nome oggi dibattuto perché a suo tempo coniato d’après Tim Henman, il tennista britannico più vincente degli ultimi decenni con le sue quattro semifinali a Wimbledon, ma il cui record è ormai svaporato con l’ascesa di Murray, assieme all’esagerato soprannome di Timbledon, quindi la collinetta non sanno più come chiamarla. Per quanto si tratti di semplice bivacco di fronte a uno schermo, anche l’accesso al praticello si svolge con le modalità da collegio militare proprie di qualsiasi altra attività del luogo, e basta arrivare leggermente in ritardo per non trovare neanche un fazzoletto di terra per stare in piedi e si finisce cacciati via anche da lì, poiché ogni centimetro è presidiato e non appena si sosta dove non è permesso si viene immediatamente invitati a circolare. Resta l’opzione di seguire brandelli di match in costante movimento, salendo e scendendo dalla collina e passando di continuo sotto lo schermo, ma non appena ci si ferma è questione di secondi prima di venire prontamente rimossi.
Il fermento attorno a Murray, per quanto in fondo sia scozzese e non un Englishman puro come Henman, è comprensibile poiché sono 77 anni che un britannico non vince Wimbledon, da quando Fred Perry nel 1936 conquistò il suo terzo titolo consecutivo. Perry che poi ha sempre bisticciato con l’All England Club, che lo vedeva male per le sue origini working class e le sue maniere sul campo non da perfetto gentiluomo. Perry ha raccontato nelle sue memorie di quando nel 1934, dopo aver vinto il titolo contro l’australiano Crawford, dagli spogliatoi sentì un membro del Club commentare con dispiacere che la vittoria non era andata al migliore tra i due uomini. Insomma ai sudditi di Sua Maestà poi ci sono voluti 50 anni per dedicargli una statua e rimangiarsi lo snobismo con cui gli avevano negato la gloria in patria.
Tra i giornalisti d’esperienza con l’arrivo dei quarti e delle semifinali cominciano a tirare fuori i completi buoni, forse perché invitati a riti e pratiche di cui a me non è dato di conoscerne l’esistenza.
Difatti piuttosto che di gloria sembrerebbe trattarsi del lungo cammino verso un’investitura, l’acquisizione di un titolo nobiliare conferito con la corte stretta attorno a sorridere e a celebrare il nuovo eletto: una grande cerimonia il cui significato appare noto ai più che circolano tra questi campi, ma non a tutti i parvenu che vengono ammessi tra queste mura per la prima volta. Lo noto anche perché mentre il mio abbigliamento con l’andare avanti del torneo non muta in alcun modo, molti tra i giornalisti d’esperienza con l’arrivo dei quarti e delle semifinali cominciano a tirare fuori i completi buoni, forse perché invitati a riti e pratiche di cui a me non è dato di conoscerne l’esistenza.
Un lieve senso d’inadeguatezza mi accompagna sempre nei miei giorni a Church Road: già il mio badge, della categoria più bassa tra le tre previste per la stampa, riporta la dicitura “Rover”, che poi significa girovago, vagabondo. Un’etichetta che sarebbe già sufficiente a minare la certezza del mio diritto di essere lì, ma che si somma alla quotidiana richiesta di badge supplementari a cui sono costretto per accedere ai due campi principali, il non avere una postazione di lavoro a mio nome, il ristorante dei giornalisti che, forse allo scopo di evitare adunate sediziose, non ha schermi che mostrano le partite. Poi tanti piccoli episodi, quelle sfumature che possono turbare se colte nel giorno sbagliato, come quando ai controlli sicurezza arrivo buttando lì uno scambio di parole di cortesia: «Good morning, how are you?», ma la risposta, essendo già le 12.30 passate, è «Good afternoon, maybe». Per non parlare degli innumerevoli colpi di sonno che mi sorprendono seduto tra gli spalti, gli occhiali da sole a proteggere la lotta contro la letargia, il disagio di ridestarsi non pensando serenamente “wow, sono proprio stanco”, ma facendo solo pensieri paranoici sul timore di essere stato visto appisolato, la speranza che le lenti scure abbiano celato la défaillance ai colleghi attorno.
Del Potro da quando a Roma ha regalato a papa Francesco la racchetta con cui ha vinto l’U.S. Open non ne ha più azzeccata una, e forse è giunta l’ora di incassare l’indulgenza del pontefice connazionale.
La ristretta capienza della tribuna stampa del Centre Court in questi ultimi giorni determina quindi selezioni e liste d’attesa, e io mi ritrovo non ammesso all’incontro di Murray e a quello tra Djokovic e Tomas Berdych. Li seguo da un desk miracolosamente libero, alla mia sinistra una giornalista indiana che picchia la tastiera del suo pc in modo disperato, forse perché inchiodata dentro quel cubicolo; a destra un collega molto più quieto, che segue gli incontri indossando le cuffie. Mi attrezzo anche io per godermi un assaggio di squisita telecronaca in puro stile tea time, solo che il mio vicino sta seguendo le partite sul circuito interno che è senza commento, mentre io voglio ascoltare la BBC. Il problema è che il segnale del canale televisivo è quasi dieci secondi in ritardo rispetto a quello interno che segue il collega, quindi se resto sulla telecronaca sono condannato a vedere i punti che sul suo schermo finiscono prima che sul mio, per cui tocca alla fine tocca anche a me ipnotizzarmi con il semplice audio ambiente della partita, il rumore secco della pallina, il silenzio, la voce annoiata dell’arbitro che annuncia il punteggio. Lentamente il mantra di quel paesaggio sonoro mi conquista e comincio a scoprire dettagli, la cosa più bella è il respiro continuo di un raccattapalle che deve avere un microfono molto vicino al suo posto a fondocampo, e quindi tutto il drammatico vittorioso quinto set di Murray finisce per essere accompagnato dal ritmo minimalista del suo affanno soffocato.
Il quarto di finale di Djokovic si risolve nella consueta demolizione (o autodistruzione) dell’avversario, e adesso il line-up delle semifinali maschili vede il serbo contro un Del Potro col ginocchio sofferente dopo essersi schiantato contro la sedia dell’arbitro un paio di match addietro, e poi Murray contro Janowicz. Due partite in apparenza chiuse, i cui esiti dovrebbero ripristinare l’ordine con una finale tra le prime due teste di serie. Ma i match di questi giorni, dove si vedono così tanti cadere a terra in lacrime e sgranare gli occhi travolti dai loro stessi successi, forse preludono a altri improbabili esiti. Janowicz non ha mai giocato un incontro di tale importanza, e questo potrebbe tanto voler dire un disastro come un’esaltazione agonistica dalle conseguenze ignote; Del Potro da quando a Roma ha regalato a papa Francesco la racchetta con cui ha vinto l’U.S. Open non ne ha più azzeccata una, e forse è giunta l’ora di incassare l’indulgenza del pontefice connazionale.
Le due semifinali femminili (Marion Bartoli che vince con Kirsten Flipkens e Sabine Lisicki che passa contro Agniewska Radwanska) hanno presentato la bizzarra situazione di quattro contendenti di cui nessuna ha mai vinto uno Slam in carriera, e non era mai successo nella storia. Quartetto anomalo, una sola top ten tra loro, tutte giocatrici europee (ma questo ormai è un fatto molto frequente), tre su quattro bionde, poche pose o idiosincrasie divistiche, molta dedizione. Una sobrietà sul campo la cui eccezione è stata ovviamente il turbine ossessivo compulsivo di Marion Bartoli, che ha terrorizzato pubblico e avversaria col suo agonismo venato di sindrome di Tourette. Mentre la vedevo in campo mi è dispiaciuto non ascoltare i telecronisti BBC e i giri di parole che avranno tentato per esprimere lo sconcerto di fronte alla furia cieca di Marion; posso solo immaginare un ampio uso di “odd” e “peculiar” per descrivere il suo portamento in campo. A questo punto sarebbe bello che vincesse lei il torneo, anche solo per vedere in che modo si troverebbe a celebrare, e con che facce la premierebbero.
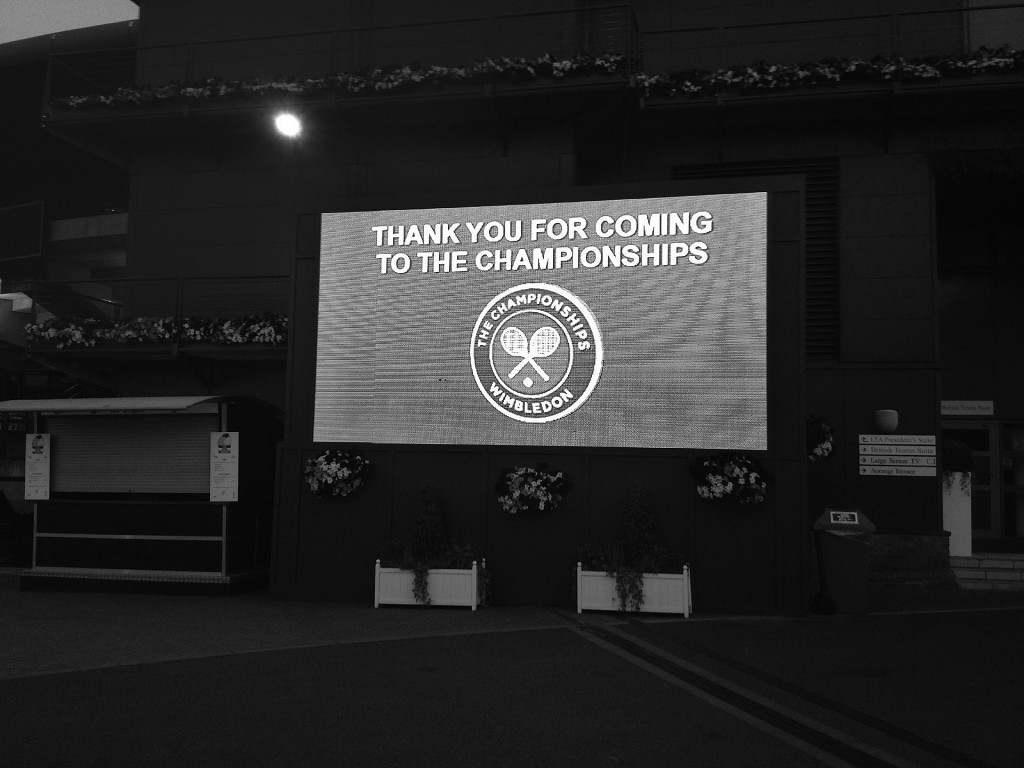
V • Fine dei giochi
«Customer service update: there is a good service on all lines.»
C’è bisogno a Londra di sentirsi dire cose del genere, aiuta a dare un senso al flusso ininterrotto di cose e persone, bilancia l’urgenza di dover sempre trovare il proprio posto, avere la reattività per muoversi nel modo giusto, per non arrestare il moto collettivo senza sosta. Tutti sembrano abituati al caos ordinato degli spostamenti, sgusciando l’uno accanto all’altro, come quando la sera dopo la finale del singolare maschile tornando verso casa ho urtato con un piede la ragazza che scendeva sulla scala mobile davanti a me, e istintivamente le ho toccato una spalla per scusarmi, ma lei non si è neanche voltata poiché conosce quel tipo di disturbo e quindi neanche si gira per verificarne l’origine, aspetta soltanto che passi per proseguire nel suo cammino predeterminato. Chissà se Andy Murray sulla strada verso il titolo abbia provato sensazioni analoghe, se gli ostacoli gli siano apparsi solo come mali necessari, semplicemente funzionali all’arrivo alla meta.
Molte cose sono accadute negli ultimi giorni di questo Wimbledon che ha visto la prima vittoria dopo 77 anni di un britannico nel singolare maschile: intanto Marion Bartoli ha vinto il torneo femminile, e nessuno all’inizio poteva immaginare che l’onore e la gloria sarebbero cadute su di lei. Sgraziata, vagamente pienotta e così poco diva da far perdere l’aplombe anche ai commentatori della BBC, di cui uno non si è trattenuto dal dire che Marion di certo non è una lookercome Maria Sharapova, solo per poi dover rilasciare scuse ufficiali, la ventottenne francese si è portata via a mani basse il titolo ricevendo anche la grazia di non aver incontrato neanche un’avversaria tra le prime quindici teste di serie.
Entro presto sul Centrale per seguire la finale, l’accesso alla fine si rivela uno scherzetto, forse anche a causa della poca nobiltà dello scontro tra la Bartoli e la tedesca Sabine Lisicki: al mio ingresso Marion sta già 4-1 nel primo set, il suo approccio alle cose normalmente esagitato forse le rende normale la pressione dell’evento, e poi qui aveva già giocato una finale nel 2007.
Lisicki sembra invece intrappolata nel più classico dei casi di stage fright, pretende di riuscire a giocare bene senza avere la tranquillità per farlo, e invece di trovare il modo di respirare a sufficienza da poter tirare un dritto come si deve, sembra chiedere ai suoi stessi gesti di darle per magia la serenità di cui ha disperato bisogno. Bartoli invece continua a cavalcare il delirio della situazione in modo assai sciolto, e le rifila un 6-1 in 29 minuti. Tutto le riesce, botte da fondocampo, risposte sulla riga, poco ortodosse volée e palle corte a due mani, con quei gesti che ricordano il lancio del martello. Lisicki, che dovrebbe avere nel servizio la sua arma migliore, fa doppi falli di continuo e serve molto debolmente, preda di un affascinante cupio dissolvi. Marion vince il torneo con un ace che alza uno sbuffo di gesso bianco dalla linea, e in men che non si dica il campo è pronto per la premiazione, il tempo di voltarmi per fare una foto al pubblico e sono tutti lì schierati, come se attendessero da tempo l’arrivo della campionessa.
Vince dunque Wimbledon una giocatrice che tre settimane fa a Parigi è stata schiantata dall’ormai crepuscolare Francesca Schiavone, che guarda caso gioca ancora con una varietà che non è più praticata. Taglio sotto la palla, taglio sopra, accelerare, rallentare, giocare profondo o corto, tutte quelle soluzioni che stanno cadendo in disuso a favore di uno stile improntato alla sola accumulazione cinetica, caricando la palla di sempre più potenza fino a che lo scambio non esplode in favore dell’una o dell’altra delle contendenti. Dopo la vittoria Marion abbraccia l’avversaria, posa velocemente per i fotografi, poi parte con i ringraziamenti a mitraglia come se li recitasse a memoria, forse presa dal timore di non ricordarsi tutti nell’ordine giusto.
Il giorno prima era stata la volta delle semifinali maschili: la prima Novak Djokovic contro Juan Martìn del Potro, e sin dai primi minuti l’incontro aveva il sapore delle grandi occasioni: il silenzio della folla, la complessità degli scambi, la sensazione di un confronto estremamente serrato, dove le aperture di gioco in cui tentare di prevalere sono minime, una manciata di punti a set. La mistica del tennis prevede la contrapposizione tra l’elogio del braccio e quello della tenacia e della resistenza, intesi come due poli opposti dell’idea di giocatore. Ma con Djokovic queste categorie saltano, all’opera non vediamo più né un’artista né un corridore martire, non apprezziamo il gesto ma piuttosto qualcosa di simile a un muro in costante movimento, fatto di una paurosa unione di potenza e elasticità muscolare.
Per questo poi di un suo match non si ricordano mai dei singoli colpi, ma la complessiva supremazia espressa, il suo lento prevalere. Ne è venuta fuori una partita di quasi cinque ore, dove Del Potro ha tirato fuori risorse inaspettate, ma in fondo mai se n’è andata la sensazione che lui avesse bisogno sia di dare il massimo che di sfruttare un calo dell’avversario, mentre Djokovic poteva tranquillamente gestire anche il meglio che l’argentino aveva da offrire. Così è stato, così si è deciso chi doveva andare avanti.
Dopo simile sbornia rientro a metà del primo set della seconda semifinale, quella tra Murray e Jerzy Janowicz; sono un po’ nauseato dal combattimento a cui ho appena assistito, ma immediatamente il modo di stare in campo di Janowicz mi risveglia, mentre lo ammiro tirare missili e accarezzare palle corte, perfetto nel ruolo del crudele invasore barbaro che vuole devastare il palazzo reale.
Il pubblico di Londra è sempre stato famoso per non cedere a derive partigiane, ma scopro che è solo perché per decenni non hanno mai avuto un giocatore per cui valesse la pena farlo.
Tira regolarmente seconde di servizio a 190 kmh, Murray accanto a lui sembra piccolo. Una hostess si lamenta con me del box degli ospiti di Janowicz: «È terribile, qualcuno dovrebbe dir loro che non si battono le mani in quel modo». Sono solo un po’ più agitati dei consueti ospiti miliardari che controllano il Blackberry ogni due punti, e soprattutto mentre loro applaudono le altre 15000 persone urlano all’unisono «Yeeessss!!!» anche per un doppio fallo di Janowicz. «Non ha grazia, non ha proprio maniere», continua la veterana dei cancelli del Centrale, mentre provo a spiegarle che sia Jerzy che i suoi amici sono nuovi a questo tipo di situazioni, e nel frattempo il pubblico è indemoniato. «He’s not playing a clean game, and THEY don’t like it», sentenzia in modo glaciale la mia vicina, mentre la folla lo fischia.
Il pubblico di Londra è sempre stato famoso per non cedere a derive partigiane, ma scopro che è solo perché per decenni non hanno mai avuto un giocatore per cui valesse la pena farlo. Finisce come doveva finire, Murray dopo aver perso il primo vince i successivi tre set: la folla ha atterrito anche me che stavo seduto a guardare la partita, figuriamoci un ragazzo che un anno fa ancora doveva giocare le qualificazioni per entrare nel tabellone principale.
Il pubblico rimarrà protagonista e, di fronte a un Djokovic chiaramente non recuperato dalla battaglia contro Del Potro, Murray avrà decine e decine di altri «Yeeessss!!!» urlati da una folla esaltata che lo spingerà a forza verso il suo destino. La finale maschile è stato un evento a cui ho assistito in diversi modi: prima in fila al desk della sala stampa attendendo che si liberassero posti in tribuna, poi facendo l’errore di accettare un posto in uno dei commentary box rimasti liberi, anche se avrei dovuto capire qualcosa dal fatto che non lo voleva nessuno. Arrivati lassù in cima è come stare a una plancia di comando di un’astronave, chiusi in un ambiente insonorizzato, un silenzio assoluto tranne che per il suono dei giornalisti che scrivono e dell’onnipresente commento della BBC sempre in ritardo sulla diretta, scandito dall’inglese crucco di Boris Becker. Riesco a fare tutto tranne che seguire la partita, dopo pochi minuti neanche so più il punteggio. Me ne vado, poi dopo un altro po’ finalmente entro in tribuna per l’ultima mezz’ora dell’incontro. Mi siedo che Murray è avanti di due set e di un break, l’atmosfera è brutale, penso a Djokovic e non riesco a capire come si faccia a tenere in mano una racchetta in quelle condizioni, sembra che lo stadio si sia ristretto, che gli spalti assedino il campo. Finisce in fretta, nonostante Murray si complichi la vita al momento di servire per il match, ma si capisce che solo lui può arrivare al traguardo, Djokovic è incerto e falloso come mai, nulla può contro la forza degli eventi, e della sua stanchezza.
Si è scritta dunque la storia, tanto improbabile vista da lontano quanto è apparsa inevitabile assistendovi fisicamente. Il trofeo sta lì poggiato su un tavolinetto, scintillante nel sole a 30 gradi di un’inaspettata giornata estiva, la cerimonia è breve e serrata, senza incertezze. Nessuno ringrazia gli sponsor, il direttore del torneo o i raccattapalle, qui si parla solo dell’esperienza di aver giocato la finale, del significato di aver vinto o perso.
Provo a riordinare le idee andando a visitare il museo del Club: in un percorso espositivo che dedica più spazio ai primi trenta anni di storia del torneo che ai successivi cento, scopro che la pratica del controllo delle borse degli spettatori è stata introdotta nel 1913 nella vecchia sede dei Championships a Worple Road, a seguito del blitz di un gruppo di suffragette. Apprendo poi che 22 secondi è il record di velocità nello stendere il telone sul prato del Centrale, anche perché d’altronde, viene riportato, un tempo inferiore non darebbe modo ai giocatori di lasciare il campo.
Passo accanto alla biblioteca, austera come se custodisse manoscritti inestimabili, incontro bacheche di trofei e cartoline dalla Riviera degli Anni Ruggenti. C’è anche una sezione sugli abiti dei tennisti di fine ’800: nel 1881 tale Walter Wingfield giocò contro un’avversaria donna di cui non è menzionato il nome, e su una targa viene riportato il fardello dei rispettivi abiti: 2.4 kg per lui, 4.9 kg per lei. Ci sono anche dei pesi da sollevare, corrispondenti alle rispettive tenute, per dare un’idea dell’ingombro dei capi indossati. Accanto ai pesi c’è il campionario dei vari indumenti femminili, così sotto a vari quadrati di stoffe e fibre mi trovo a saggiare anche la consistenza di un corsetto, con tanto di lacci di seta. Nella corsa veloce verso i giorni nostri il museo presenta a un certo punto un ologramma di John McEnroe che ci guida dentro una replica dello spogliatoio maschile, poi due statue con i volti dipinti e le bandiere sulle spalle, una versione assolutamente bugiarda dello spettatore tipo dell’All England Club, infine una serie di completi indossati da diversi campioni degli ultimi anni.
Allora da una fessura si spiava dentro il Centrale, una piccola feritoia da cui si intravedeva il sacro lawn, come a Roma si va a guardare San Pietro dal buco della serratura nascosto all’Aventino.
Al museo ci ero già stato quando avevo tredici anni, ma lo ricordavo completamente diverso, meno sofisticato, un’aria polverosa da museo delle cere. Chiedo spiegazione dei miei ricordi contrastanti e mi confermano che prima il museo si trovava sotto il Centre Court, per poi venire spostato accanto al Court n.1, dove si trova ancora oggi. Ma soprattutto la cosa che ricordo di più è che attraverso le sale di allora si arrivava in un punto in cui da una fessura si spiava dentro il Centrale, una piccola feritoia da cui si intravedeva il sacro lawn, come a Roma si va a guardare San Pietro dal buco della serratura nascosto all’Aventino. Mi dicono che la feritoia non c’è più, l’hanno sostituita con un percorso guidato che conduce i visitatori a ammirare il campo da una sorta di ampio bovindo di alluminio e vetro montato durante l’anno su una tribuna dello stadio. Un po’ come quando si guardano gli squali da dentro una gabbia in immersione, hanno deciso di togliere il brivido della fessura, della visione privata e diretta per sostituirla con la vista blindata dietro a una vetrata, che sta lì a ricordare quanto quel mondo non ci appartenga. Ed è un peccato, perché sono convinto che anche se si vedeva di meno, osservare da quella fessura fosse molto più bello, ancora lo ricordo come un momento soltanto mio, speciale, non come la tappa di una visita guidata.
Quella sensazione l’ho ritrovata spesso nelle due settimane del torneo, ogni volta che mi sono trovato in un campo secondario a seguire un incontro assieme a poche decine di persone, così vicino da riuscire a distinguere ogni filo d’erba del prato. Mi chiedo se la ragione per cui così tanti milioni di persone amino il calcio non sia segretamente il richiamo di quell’enorme distesa di erba verdissima, quella tabula rasa ancestrale che può regalare l’illusione di un centro attorno a cui far girare i propri pensieri, una superficie su cui far riposare le inquietudini, e ritrovare la certezza che tutto abbia un senso.
Tutte le fotografie sono di Fabio Severo
Come funziona Jigsaw, la divisione (poco conosciuta) di Google che sta cercando di mettere la potenza di calcolo digitale del motore di ricerca al servizio della democrazia, contro disinformazione, manipolazioni elettorali, radicalizzazioni e abusi.

Reportage dalla "capitale del sud" dell'Ucraina, città in cui la guerra ha imposto un dibattito difficile e conflittuale sul passato del Paese, tra il desiderio di liberarsi dai segni dell'imperialismo russo e la paura di abbandonare così una parte della propria storia.



