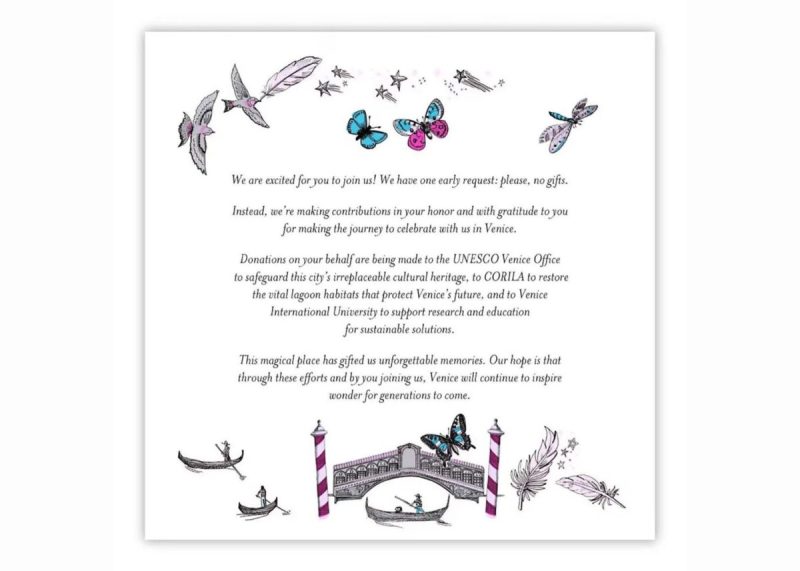E a Napoli un ospedale ha organizzato percorsi dedicati ai ricoveri per colpi di calore. La crisi climatica è una problema amministrativo e sanitario, ormai.
Scuola per aspiranti genitori
La scelta di adottare può essere vista come una forma di ecologismo genitoriale, come un gesto d'amore per bambini senza famiglia, ma il percorso da affrontare è lungo e fatto di passaggi kafkiani come corsi propedeutici, video su YouTube e parabole misteriose.

«Come immaginate il vostro bambino?». È un pomeriggio di febbraio, sta per fare buio, io e mia moglie siamo al decimo piano di un palazzo di non so quanti piani dietro la stazione centrale. Da quattro mesi veniamo qui ogni giovedì pomeriggio, quello di oggi è l’ultimo incontro per il rilascio del decreto di idoneità all’adozione. I termosifoni sono molto caldi, le finestre chiuse, nella stanza insieme a noi ci sono altre tre coppie di aspiranti genitori ma nonostante la temperatura abbiamo tutti il cappotto addosso, come se avessimo fretta di andarcene. Dev’essere per via di questi corridoi spogli, di questi uffici troppo grandi per i pochi dipendenti che ci lavorano, c’è una desolazione come quella che si avverte nelle scuole quando sono chiuse o nei cinema vuoti. Con le altre coppie ci scambiamo un’occhiata smarrita sperando che qualcuno risponda per primo ma nessuno sa cosa dire.
Ci eravamo lanciati in quest’avventura pieni di entusiasmo, senza nemmeno indagare troppo sui motivi per cui non riuscivamo ad avere figli. Di fronte allo scetticismo di amici e parenti, che ci invitavano perlomeno a riflettere sulle altre possibilità offerte dalla medicina, rispondevamo che adottare ci sembrava una sana forma di ecologismo genitoriale: perché fare un figlio quando ci sono già dei bambini senza famiglia? Al di là della battuta, però, è che davvero non lo vivevamo come un ripiego, al contrario, lo sentivamo un movimento naturale, coerente con un’idea di famiglia dove il sangue è tra le cose meno importanti. Nel giro di due mesi abbiamo prodotto tutti i documenti richiesti dal tribunale per i minorenni: devi fare analisi e visite specialistiche per dimostrare di essere in buona salute, consegnare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, il certificato di matrimonio, di residenza, l’atto di proprietà o il contratto di affitto dell’appartamento in cui vivi, e fin qui tutto bene, vogliono essere certi che tu abbia le risorse per adottare, ma fa sorridere che ti chiedano di presentare anche il consenso scritto dei tuoi genitori. E se uno di loro non fosse d’accordo perché magari non ha nessuna voglia di fare il nonno? A quarant’anni serve davvero l’approvazione di mamma e papà per adottare un bambino?
All’incontro successivo ci chiedono di disegnare prima un albero e poi una famiglia. Ogni foglia, ogni ramo che disegni ti domandi che significato avrà per quella gente che ti osserva seduta dall’altra parte della scrivania
Vorresti chiederlo a qualcuno ma negli uffici pubblici ci sono solo gli impiegati che si stringono nelle spalle e ti dicono che non dipende da loro, è la procedura. Ti convinci che dev’esserci per forza una logica, stiamo parlando di orfani, di minori abbandonati, abusati, sottratti a genitori tossicodipendenti, violenti, criminali, tutto dev’essere stato studiato in funzione della loro tutela e del loro benessere, non può essere altrimenti. Assolti gli obblighi formali, però, cominci i quattro mesi di corso preadottivo e anche lì c’è qualcosa che non torna: da una parte quegli incontri dovrebbero formarti in vista dell’adozione, ma allo stesso tempo servono a una commissione di psicologi e assistenti sociali per giudicarti idoneo o meno a diventare genitore. In altre parole non sai se affidarti a quelle persone o guardarti le spalle da loro.
Il primo incontro è un colloquio individuale, sentono prima me e poi mia moglie, vogliono sapere come ci siamo conosciuti, se andiamo d’accordo, che lavoro facciamo, come passiamo i fine settimana, le vacanze di Natale, se d’estate viaggiamo o andiamo sempre nello stesso posto, se facciamo sport, se abbiamo animali domestici. Sembra una chiacchierata informale per farsi un’idea di chi siamo, ma poi ci riascoltano insieme, come se volessero incrociare le informazioni e confrontare le risposte in cerca di incongruenze e contraddizioni. Anche se non hai niente da nascondere, l’ansia di dire la cosa sbagliata è inevitabile, soprattutto quando ti chiedono di parlare del tuo matrimonio: se cerchi di non edulcorarlo troppo rischi di sembrare freddo, distaccato, ma se ti sbilanci a metterci più enfasi del dovuto puoi sembrare finto e fare la figura del venditore.
All’incontro successivo ci chiedono di disegnare prima un albero e poi una famiglia. Ogni foglia, ogni ramo che disegni ti domandi che significato avrà per quella gente che ti osserva seduta dall’altra parte della scrivania. Lo stesso mentre disegni un padre, una madre, nonni, zii e bambini: pensi al tratto, ai dettagli, ai colori che usi, ti sforzi di riprodurre al meglio le immagini che hai nella testa, ma la mano non ti aiuta, sono anni che non disegni, forse non sei mai stato bravo a disegnare, vengono fuori espressioni malevole, sorrisi sinistri, corpi deformi, volevi rappresentare una famiglia felice e ti è venuto fuori un branco di mostri. Quando usciamo ci confrontiamo con le altre coppie e ci chiediamo cos’avremo involontariamente confessato con quei disegni, se non faranno emergere qualche aspetto marcio del nostro carattere di cui nemmeno noi siamo a conoscenza, ma troviamo la leggerezza per ridere degli scarabocchi che abbiamo consegnato ai nostri esaminatori e in uno slancio di fiducia verso di loro ci diciamo che in fondo è meglio così, se abbiamo dentro qualcosa di storto è bene che venga fuori subito e ci neghino la possibilità di adottare prima di fare danni.
La volta dopo dobbiamo dare la nostra interpretazione di una parabola, I ciechi e l’elefante, una storiella d’origine indiana che ricorre con leggere modifiche in diverse tradizioni religiose. La psicologa che si appresta a leggerla premette che si tratta di un testo di una bellezza e di un acume straordinari: «Al di là di Ghor si estendeva una città i cui abitanti erano tutti ciechi. Un giorno, un re arrivò da quelle parti, accompagnato dalla sua corte e da un intero esercito, e si accamparono nel deserto. Ora, questo monarca possedeva un possente elefante, che utilizzava sia in battaglia sia per accrescere la soggezione della gente. Il popolo era ansioso di sapere come fosse l’elefante, e alcuni dei membri di quella comunità di ciechi si precipitarono all’impazzata alla sua scoperta. Non conoscendo né la forma né i contorni dell’elefante, cominciarono a tastarlo alla cieca e a raccogliere informazioni toccando alcune sue parti. Ognuno di loro credette di sapere qualcosa dell’elefante per averne toccato una parte […]». La parte finale del testo racconta dei ciechi che tornano in città e finiscono per dare ognuno una descrizione diversa dell’elefante ai propri concittadini. Morale? Con le altre coppie ci guadiamo interdetti, la spiegazione corretta sarebbe che la realtà è diversa per ognuno di noi, in base alle nostre esperienze, al punto di osservazione e così via, ma nessuno vuole arrendersi all’idea che la risposta sia così ovvia. Per un attimo mi viene voglia di dire che mi ha fatto pena il sovrano, dopo la fatica di portarsi in viaggio un elefante quel poveretto dev’esserci rimasto proprio male quando si è ritrovato circondato da ciechi che non ne avevano nessuna paura, ma temo che mi prendano sul serio, lascio perdere e mi accodo alle altre coppie che tentano disperatamente qualcosa di brillante da dire. È uno spettacolo penoso, ci arrabattiamo tutti a dare interpretazioni cervellotiche, confuse, una coppia tira fuori perfino la traversata di Annibale sulle Alpi con gli elefanti al seguito, ma quel ricordo da scuole medie è così fuori fuoco che nemmeno loro sanno come riagganciarsi alla parabola appena ascoltata e portare a termine il discorso. Per non offendere i nostri esaminatori, in pratica, facciamo noi la figura dei fessi.
Il punto più basso lo tocchiamo verso la fine del corso, quando ci mettono davanti un computer e fanno partire un video su YouTube in cui si susseguono foto in dissolvenza di famiglie felici accompagnate da citazioni melense sull’amore tra genitori e figli»
Il punto più basso lo tocchiamo verso la fine del corso, quando ci mettono davanti un computer e fanno partire un video su YouTube in cui si susseguono foto in dissolvenza di famiglie felici accompagnate da citazioni melense sull’amore tra genitori e figli. Finito quello strazio, ci domandano come ci sentiamo, cosa ci hanno ispirato quelle immagini e le parole che abbiamo ascoltato. Siamo tutti imbarazzati, a disagio, ma facciamo di tutto per non darlo a vedere, ormai manca solo un altro incontro per ottenere il decreto di idoneità e le persone davanti a noi hanno il potere di farcelo avere o negarcelo. Ancora una volta ci barrichiamo dietro risposte false e disoneste, fingendo di aver apprezzato quel video sdolcinato e irreale.
«Come immaginate il vostro bambino?». L’ultimo incontro comincia con quella domanda. Siamo tutti riuniti intorno a un tavolo e non sappiamo cosa dire. Ma che domanda è? Se sei libero di immaginare un figlio non puoi che immaginarlo bello, simpatico, intelligente, ma è un gioco a perdere, sarà un essere umano imperfetto come tutti gli altri. Ho di nuovo la tentazione di defilarmi con una battuta, e stavolta cedo: «Spero che abbia senso del ritmo e impari a suonare la batteria», rispondo, «così magari suoniamo insieme visto che io strimpello un po’ la chitarra». La psicologa abbassa lo sguardo e insiste che vuole una risposta seria: «Quel bambino è già nato», precisa come se dovesse esserci d’aiuto, «è un bambino che già esiste, con una faccia, un corpo, un nome e una storia».
Siamo più confusi di prima, con le altre coppie ci scambiamo occhiate furtive senza sapere come uscirne finché uno degli aspiranti genitori dice apertamente che non capisce il senso di quella domanda: «Anche mia moglie esisteva prima che la conoscessi, ma non significa che immaginassi già di sposarla». Sosteniamo tutti quel ragionamento, ma la psicologa insiste nel metterci in guardia sulla consapevolezza necessaria per adottare e ci racconta la storia di un bambino che il giorno del compleanno della madre adottiva le ha regalato un pacchetto con tanto di fiocco colorato e dentro le proprie feci. «Ogni anno falliscono molte adozioni», ci dice, «non avete idea di quante coppie non reggono e riportano i bambini in casa famiglia. I minori si sentono responsabili di quello che hanno subìto» aggiunge, «e faranno di tutto per mettervi alla prova, cercheranno in ogni modo di trovare il vostro punto di rottura e dimostrare che prima o poi li abbandonerete anche voi». Finalmente qualcosa di concreto, niente disegni, parabole indiane e video su YouTube. È quello che abbiamo cercato per tutto il tempo, che ci aiutasse a capire cosa ci avrebbe aspettato, ma dopo quattro mesi che veniamo qui ogni giovedì pomeriggio non abbiamo idea di che cos’è un’adozione. L’ufficio deve chiudere, è tardi. Come al solito siamo rimasti tutti col cappotto addosso, non perdiamo tempo nemmeno a rivestirci. Ci augurano buona fortuna e dopo una stretta di mano ci accompagnano alla porta.