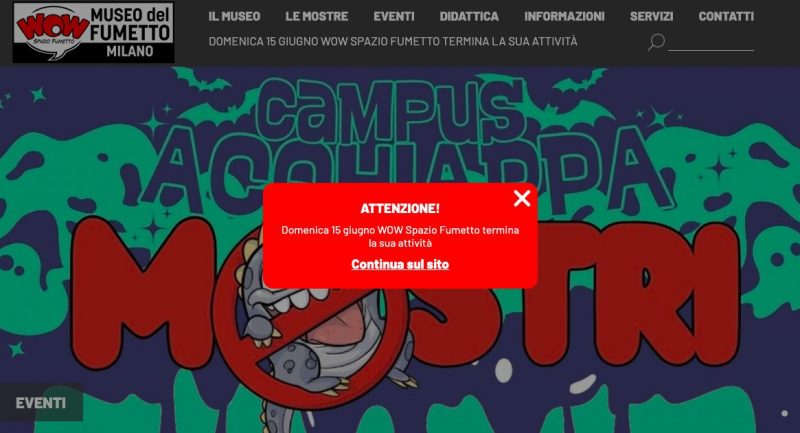Nei tre punti balneabili del fiume è già stata issata di nuovo la bandiera rossa. Stavolta, però, la colpa è della pioggia.
Una conversazione con Andrea Guerra
Aprire Milano per aprire l'Italia. Impresa, cultura, città, futuro: manifesto per il 2015.


- Andrea Guerra a un incontro di AltaGamma (Getty Images)
Nei giorni in cui mi concede quest’intervista, Andrea Guerra, stando alle indiscrezioni delle pagine politiche dei giornali, è candidato a tutto. C’è da sostituire il Ministro della Infrastrutture? «A Renzi non dispiacerebbe Andrea Guerra». Si parla di riforma della Rai e della nuova figura manageriale che dovrebbe guidarla? «Palazzo Chigi pensa anche ad Andrea Guerra». Pisapia annuncia che non si ricandiderà a sindaco di Milano? «La carta segreta dei renziani per il 2016 sarebbe Andrea Guerra». Bastano pochi minuti di conversazione, il tempo di ordinare un cappuccino e una macedonia di frutta nella lobby di un hotel del centro, per capire che la realtà, allo stato attuale, dice una cosa molto diversa: Andrea Guerra non è candidato a nulla di tutto ciò. È lui stesso a raccontarci, in apertura di conversazione, come abbia già preso la decisione di tornare a fare il suo mestiere, il manager, nell’autunno inoltrato del 2015. Lo farà per un’azienda italiana.
Mestiere, quello del dirigente d’azienda, che Andrea Guerra ha smesso di fare nell’agosto del 2014, quando ha lasciato il posto di amministratore delegato di Luxottica, ruolo che ricopriva da dieci anni. Cos’ha fatto Guerra per buona parte del tempo da allora a oggi? Quello a cui ha deciso di dedicare un anno della sua vita, ovvero il consigliere strategico di Matteo Renzi, per il quale si occupa di politiche industriali e del rapporto con la business community. Il fatto che abbia deciso di dedicare un periodo limitato di tempo all’impegno con Palazzo Chigi è stata una scelta dichiarata fin dall’inizio. Intendiamoci, non si tira indietro quando c’è da notare che riuscire a incidere sulla messa a punto della cosa pubblica sia infinitamente più complicato di un analogo esercizio in un’impresa privata.
Ma non è questo il punto. E lo si capisce quando Andrea Guerra inizia a raccontare del suo rapporto con Renzi, un feeling personale che continua, nato spontaneamente da un confronto di idee, e mai vissuto sull’asse rigido primo ministro-amministratore delegato. «Passiamo molto tempo a confrontarci, oltre che sulle cose da fare, sul perché sia giusto farle e come». È un uomo di metodo e di visione Andrea Guerra. È questo, mi pare di capire ma potrei sbagliarmi, che l’ha portato a chinarsi con passione per qualche tempo sui faldoni complicati della cosa pubblica. Un manager che ha deciso, per un periodo circoscritto di tempo, di mettere nome, esperienza e idee a servizio del proprio paese, restando ben cosciente di quale sia il proprio ruolo. Nulla più. Un uomo fondamentalmente libero. Per questo limitarsi a usarlo come figurina nei vari toto-candidature, misurarne quotidianamente col righello vicinanza e lontananza dall’azione di governo, registrarne ogni presunto movimento, aiuta poco a a cogliere quella che pare essere una sua caratteristica di rilievo: la linearità. Ho un’idea, la formulo, la testo, ne verifico la fattibilità e poi lavoro perché abbia gambe. Il resto sono orpelli. E lo faccio per l’azienda che dirigo, per il mio paese, per i miei figli, per la mia comunità, per la città in cui vivo.
Città che già da qualche anno è Milano. Spostiamo la discussione su questo: sul capoluogo lombardo e sulla sua distanza vera o presunta dalle grandi capitali della contemporaneità. «Io penso che se Milano avesse voglia un giorno di abbattere il muro… È una città con un’energia pazzesca», attacca Guerra, «però i giardini più belli sono dietro dei muraglioni, la finanza è dentro a dei muraglioni, la moda è dentro alle mura. Per cui se un giorno decideremo finalmente di andare a viverci Milano per strada, allora la distanza si farà breve. Se uno pensa alla cultura, all’intelligenza, alle intuizioni, all’imprenditorialità, alla volontà di lavoro che c’è a Milano, le condizioni base ci sono tutte. Ci sono le università, ci sono i laboratori accanto alle università, ci sono delle associazioni incredibili nel terzo settore. C’è un tessuto straordinario».
Chiedo a Guerra da quale di questi ingredienti partirebbe lui e per sviluppare cosa. Non ha dubbi: «Io avrei lavorato come un matto per trovare dei terreni in comune fra le università di Milano, che sono delle vere e proprie eccellenze. Il Politecnico è un’eccellenza mondiale; la Bocconi è un’eccellenza europea; la Cattolica ha al suo interno delle facoltà straordinarie. Architettura, le scuole di design, la nuova accademia delle Bella Arti: stiamo parlando del network post scolastico più ricco al mondo. Ma vogliamo metterle insieme? Ma non insieme perché dobbiamo arrivare ad averne una, insieme per cominciare a far sì che ci sia fertilizzazione incrociata. Chiunque oggi faccia azienda sa che le persone migliori che puoi assumere hanno un mix di cultura umanistica e scientifica, tecnologica e sociale, psicologica e razionale che non si apprende da un libro, ma da esperienze diverse. E allora valorizziamole queste esperienze: è un tesoro straordinario che abbiamo».
«Usiamola questa porta d’ingresso che è Milano. Vogliamo provarci? Generosità da parte di tutti e andiamole dietro»
Tesoro che spesso, diciamocelo, non siamo bravissimi a valorizzare. «No. A me sorprende leggere sui giornali, con toni stupiti, che da quando il New York Times ha detto che Milano è una meta, le prenotazioni in città durante l’Expo sono cresciute del trecento percento. Ancora non capiamo i meccanismi che regolano il mondo, ancora dobbiamo sorprenderci che se un media dall’altra parte dell’oceano parla bene di noi, quella cosa una qualche influenza ce l’ha. E allora, chiediamoci: noi cosa facciamo perché si parli bene di noi nel resto del mondo? Troppo poco. In occasione di Expo, ci sono musei che hanno chiesto un prestito da altri musei per far sì che Milano davvero diventasse l’epicentro italiano in questi prossimi sei mesi, incontrando difficoltà. Quant’egoismo, quanto poco altruismo, quanta miopia rispetto all’occasione di rendere in questo momento questa città davvero la vetrina dell’Italia. Che poi, se ci si pensa bene, qui succedono già delle cose straordinarie: abbiamo una Frecciarossa che in un’ora e mezza collega Milano e Firenze, in meno di tre ore Milano e Roma. Un’infrastruttura incredibile: vai a Napoli velocemente, a Torino in un attimo. E allora usiamola questa porta d’ingresso che è Milano. Vogliamo provarci? Forza. Generosità da parte di tutti e andiamole dietro. È evidente che Firenze, Roma, Venezia hanno poli di attrazione turistica maggiore, ma portiamo un pezzo di Roma qua in questi sei mesi, portiamoci un pezzo di Firenze, portiamo un pezzo di Venezia. A Milano in qualche modo si è riusciti nel tempo a creare delle infrastrutture interessanti anche dal punto di vista architettonico, dal punto di vista culturale. Il punto è che non c’è mai niente di organico. Vogliamo aprirle, per esempio, queste settimane della moda? Vogliamo far sì che la moda sia un tassello attorno cui mettiamo tante altre cose?».
Di moda che non si apre al resto della città si è parlato e si parla spesso: molti addetti ai lavori sostengono che siano le istituzioni a non essere aperte e ricettive nei confronti del nostro fashion system. Il manager prestato alla cosa pubblica la pensa così: «Non si può costantemente sostenere che sia colpa delle istituzioni, piove governo ladro; e questo lo dicevo anche prima di aver deciso di contribuire per dodici mesi all’attività di governo. E il settore della moda e del lusso lo sta capendo: fare un minimo di squadra fra Pitti a Firenze e le sfilate a Milano ha portato in Italia il venticinque percento di compratori in più. È stato utilissimo riuscire a fissare un calendario di fiere intorno alla settimana della moda che avesse un senso: la fiera degli occhiali, dei gioielli, della pelle. Serve un lavoro comune coordinato. Quanto costa questa cosa qui? Zero. E allora, che c’entrano le istituzioni? Il punto è riuscire, di nuovo, a essere tutti un po’ meno egoisti. Ci stiamo arrivando, anche perché è il mercato che ce lo sta ponendo come tema: se qui ogni azienda va per sé, mentre abbiamo di fronte i francesi con gruppi che hanno ognuno dieci marchi, o i nostri “per sé” fanno sistema fra di loro, o è proprio da un punto di vista di business che diventa difficile».
Tema ampio quello del nostro sistema imprenditoriale che fa fatica a stare al passo con le innovazioni globali. Guerra su questo ha un punto di vista preciso: «Noi siamo in una fase delicatissima della vita imprenditoriale italiana, perché siamo in tanti casi alla fine di gloriose prime generazioni fatte di grandi imprenditori che però si portano dietro una cultura molto particolare, molto individualistica, molto familiare, molto “io faccio cinque ruoli in azienda”; spesso poco curiosi, poco aperti al mondo. Ma perché poco aperti al mondo? Perché il mondo a sua volta si è aperto mentre la loro generazione si avviava verso una fase calante. Il momento è delicato: è necessario accompagnare questi passaggi generazionali con una spinta fortissima a far sì che le nostre aziende siano più aperte, che gli imprenditori nel tempo facciano sempre più gli imprenditori e che chi deve gestire l’azienda sappia sempre di più gestire l’azienda. È necessario che queste aziende siano aperte globalmente, aperte alla tecnologia, aperte da un punto di vista patrimoniale. Che non siano più legate a un sistema di credito basato sulla linea bancaria sotto casa, ma che sappiano dotarsi di strumenti finanziari contemporanei e che abbiano la possibilità e la capacità di capire che il confine della propria industria è molto più labile rispetto a prima. Quanti, ad esempio, hanno capito che le emozioni oggi sono quasi tutto, che il racconto di esse è fondamentale, che non è più la funzionalità del prodotto che vendi, quella la diamo per scontata, ma la tua capacità di smuovere il mio cuore e far sì che la mia mano vada al portafoglio. E allora è lì che ce la giochiamo oggi: questo momento delicato dev’essere accompagnato da un’apertura e da una spinta culturali fortissime».
«Siamo in un nuovo mondo che ci impone delle nuove regole, delle grandi opportunità e delle nuove sfide»
A questo punto chiedo a Guerra se non pensa che il vero problema sia quello di far percepire a queste gloriose generazioni imprenditoriali che non ci troviamo di fronte solo all’ennesimo aggiornamento da fare in vista del mondo che verrà, ma che piuttosto negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a una rivoluzione tecnologica e il mondo di conseguenza è già incredibilmente cambiato.
«Un paese vecchio ha paura di dirsi che il mondo è radicalmente cambiato – racconta Guerra – e che non si tratta solo di una crisi. Io comincio ogni mio discorso pubblico dicendo che la nostra generazione di manager e imprenditori è la più fortunata della storia. Per queste ragioni. Primo: il mondo d’improvviso, dieci anni fa, è diventato molto più grande. Non c’è nessuna generazione prima della nostra che possa dire di aver avuto di fronte due, tre, quattro miliardi di nuovi consumatori. Secondo: quella cui abbiamo assistito è stata una rivoluzione industriale. Digitale sì, certo, ma anche di informatica e di conseguenza di produttività industriale. Siamo in un nuovo mondo e questo nuovo mondo ci impone delle nuove regole, delle grandi opportunità e delle nuove sfide. Le opportunità sono ovvie: mercati più grandi, una tecnologia diversa per cui puoi essere molto più produttivo, molto più veloce, molto più flessibile; puoi essere molto più vicino a tutti consumatori del pianeta, sapere cosa vogliono. Dall’altra parte è tutto più difficile, più instabile; capire cosa succederà fra una settimana è molto più complicato rispetto a prima. E quindi viviamo con maggiore instabilità, con molto più stress, in maniera più usurante. Un nuovo mondo, appunto. Che alle aziende impone una nuova vita: devi essere più grande, devi avere le spalle patrimonialmente più forti. Devi avere persone native digitali, più giovani, nuovi cittadini globali vicino a te in grado di vivere e capire quest’epoca. Queste sono le regole e non puoi pensare che siccome hai avuto successo negli anni ‘80 e ‘90 continuerai ad averlo oggi e domani. E sai cos’è successo negli ultimi vent’anni? Che non solo noi abbiamo rallentato, non solo noi proprio da un punto di vista demografico siamo diventati più vecchi, ma gli altri hanno accelerato. Può essere che ancora oggi uno dei cinque Paesi fondamentali per la bilancia commerciale italiana sia la Svizzera? No. Dall’altra parte il paradosso meraviglioso è che però siamo dopo la Germania il Paese che ha l’avanzo commerciale più grande del mondo. E allora dobbiamo veramente far sì che ci siano un respiro e un’evoluzione culturali più ampie possibili nel nostro sistema imprenditoriale».
Allora, ragiono con Guerra ad alta voce, forse il tema adesso è capire come si diffonde e come si forniscono gli strumenti per stimolare questa cultura di impresa. Cosa non facile in un momento di incertezza: i molti che hanno voglia di lanciarsi in progetti nuovi, e hanno idee, spesso poi si pongono problemi pratici, il credito per esempio. «Più che di credito parlerei di mercato di capitali. Lo dicevamo prima: ancora oggi i nostri imprenditori spesso preferiscono avere la linea di credito sotto casa all’uno percento a tre mesi, piuttosto che andare a fare un’obbligazione presso i fondi pensione americani. Il risultato è che abbiamo imprenditori ricchi e aziende povere, così come abbiamo uno stato povero e persone ricche. Gli strumenti per dare capitale alle nostre aziende sono tanti: l’apertura alla borsa, al private equity, a fondi più pazienti, alle obbligazioni: quelli sono tutti sistemi per. È un mercato di capitali che si è trasformato in maniera colossale nel mondo, e qui in Italia siamo ancora un po’ indietro. Di nuovo, è un problema culturale, di chiusura».
Un mondo nuovo, un processo di cambiamento totale, un Paese che deve colmare un ritardo. Visto il ruolo di Andrea Guerra, ha senso chiedergli quanto pensa che il governo attuale stia accompagnando tutto ciò e con quanta efficacia: «La cosa che credo sia più rilevante è che finalmente ci sia posti un tema: l’urgenza. Poi se si vanno a vedere i tanti provvedimenti intrapresi, iniziati o conclusi, posso dire di essere d’accordo con novantasette, novanta, novantacinque su cento, non è quello il problema. Il punto è aver compreso l’urgenza di cambiamento. Il Jobs Act, ad esempio. È una cosa facile da far comprendere alle nuove generazioni. Mi è capitato di doverlo fare recentemente con mia nipote che dev’essere assunta. Guarda il contratto è così: i primi tre anni son fatti in questo modo, poi succede questo e quest’altro. Ah, come in Australia, mi ha risposto, avendo fatto precedentemente un’esperienza lì. Poi c’è il tema di quando non si è occupati, e secondo me lì c’è ancora un bel po’ da fare».
Prima di salutarci – avverrà pochi minuti dopo sotto una tettoia mentre piove, ci stringiamo la mano mentre cerco l’ombrello e non lo trovo e Guerra mi suggerisce di prenderne uno caso, «sempre stato per l’ombrello socialista» mi confessa – gli chiedo un’ultima battuta su Expo e su questo 2015: «È evidente che per l’Italia è un anno che non si può sprecare e che quindi bisogna essere martellanti in questa volontà di stimolo. Le condizioni che si stanno verificando non ricapiteranno, quindi è ovvio che Expo è uno di quegli eventi da cui dovremo riuscire a ottenere tanto. Il tema, di nuovo, è riuscire ad aprirlo, a farlo uscire dalla dimensione evento in sé. Perché sì, magari vedremo che il Pil di Milano nel 2015 sarà cresciuto del quattro percento. Ma la nostra sfida vera sono il 2016, il 2017 e così via: saremo riusciti a seminare qualcosa oggi per il futuro?»
Questa intervista è stata pubblicata, insieme a molto altro, sul nuovo numero di Studio, disponibile in edicola e su iPad

I movimenti che vogliono rovinare il matrimonio di mr. Amazon non ce l'hanno solo, né tanto, con lui: il problema è ciò che Bezos rappresenta e il fatto che abbia deciso di venire a rappresentarlo proprio a Venezia.