La nuova serie della creatrice di Girls è piena di difetti ma ha un pregio che da solo quasi basta a redimerla: rende bene l'idea di che cosa terribile siano le relazioni oggi.
L’alfabeto Roth secondo Blake Bailey
La biografia del grande scrittore americano è piena di storie e aneddoti, dalla a alla z.
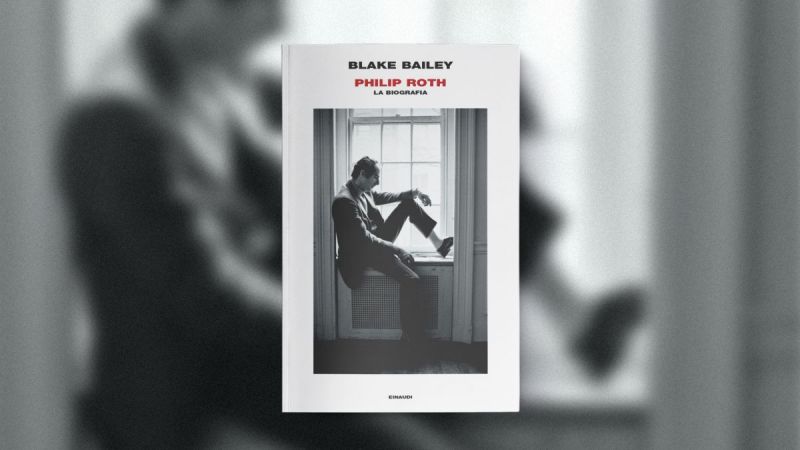
A come Aneddoti e Apparato
Cominciamo da qui. Il mastodontico e travagliato tomo di Blake Bailey (Philip Roth. La biografia, Einaudi, traduzione di Norman Gobetti, pp. 1045, € 26) è inutile, cioè no, è pieno di cose interessanti, curiose, buffe. Epperò è inutile, bellissimo e inutile: mi spiegherò alla fine. Intanto fioccano notizie e aneddoti. C’è la storia del romanzo morale alla Joseph Conrad che Roth non terminò mai su un ebreo americano che negli anni Cinquanta va in Germania per uccidere un tedesco a caso. Il b-movie di Roger Corman tratto da uno dei suoi primi racconti. La scena in cui il suo terapeuta interpreta un malessere fisico come psicosomatico, dovuto nello specifico all’invidia verso un libro dell’amico William Styron, e invece Roth rischia di lasciarci le penne perché aveva una peritonite. La stroncatura dell’esimio cabalista Gershom Sholem e la rivelazione che in realtà costui fu un avido consumatore di pornografia. Tutti i rapporti con gli pseudomentori: Bellow che gli soffia una ragazza; Malamud che si accomiata con compunzione dalla stanza dove chiacchierano e infila una porta che dà su uno sgabuzzino; Capote che, invidioso di Portnoy, lo accusa in tv di appartenere a una specie di mafia ebraica (la resa dei conti avverrà in un locale dove Roth lo ferma all’angolo per chiedergliene ragione e Capote sguscia via); le antipatie con Mailer (ma da vecchi si incontrano per caso e si confessano di pisciare spesso nelle cabine telefoniche per incontinenza: ridono). Ma non solo. Le foto sono bellissime. C’è il nonno Sender, il primo a partire verso gli Stati Uniti, con un vestito stazzonato e l’aria tanto felice quanto ingenua. C’è lo zio Milton, talentuosissimo, con gli stessi occhi scuri di Roth, che morì – appunto – di peritonite a diciannove anni, quasi un doppio sacrificale. C’è Roth in spiaggia da ragazzo che ostenta ridicolmente i muscoli per due amici. O Roth a ventisei anni, quando vince (più giovane nella storia) il National Book Award per Goodbye, Columbus e sembra un uomo di quaranta. O Roth a ottantacinque che mostra la foto di Joe DiMaggio regalatagli da Don DeLillo (in vecchiaia facevano insieme lunghe passeggiate periodiche, ma Roth trovava l’altro enigmaticamente taciturno). Sfilano i tanti amici meno talentuosi divorati dal tempo (un certo Alan Lelchuk, ad esempio, che ha provato a scimmiottarlo e adesso è una scarna voce su Wikipedia), le amanti (l’incantevole Ann Mudge, la famigerata Maggie, l’intraprendente Sproul, la tardiva Halliday). Soprattutto c’è una foto, che pure conoscevo già, e che mi ha sempre colpito: Roth e Primo Levi nello studio di quest’ultimo a Torino. Roth ha un goffo riporto (per un po’ fu una sua ossessione, la calvizie, e – strano! – ne parlò in un romanzo, senza risparmiarsi) e Levi ha quelle sue orecchie da elfo, tanto simili a quelle di Kafka. Non riesco a immaginare due uomini più diversi: Levi con quel pudore candido inarrivabile davanti al re dell’impudicizia e dello sberleffo. Eppure si amarono. «Non so quale di noi due sia il fratello minore e quale il maggiore», disse Levi.
B come Biografia
Certo, è ambigua. Bailey è ammaliato, sedotto come tutti, fin troppo intimo. Scrive: «Quella prima estate passai una settimana in Connecticut, intervistandolo per sei ore al giorno nel suo studio. Ogni tanto facevamo una pausa per andare in bagno, e sentivamo, attutito attraverso la porta, l’uno il fiotto dell’altro». (Questa è una cosa che avrebbe potuto scrivere Roth, seguace dell’intimità, del dettaglio corporeo più radicalmente umano, come quando in Patrimonio raccontò l’episodio increscioso in cui il padre si caga addosso in casa sua e il figlio, con gli amici che prendono il tè in giardino, lo pulisce nella doccia meticolosamente, per di più commentandone il cazzo. La pagina – per inciso, una delle più belle della memorialistica letteraria – venne criticata.) È interessante notare che il biografo precedente – come quello di Bellow – aveva finito con l’odiare Roth (si guadagnò un lungo scritto intitolato “Note su un maldicente calunniatore”). E quindi? «Non voglio che mi riabiliti. Solo che mi rendi interessante». La frase in esergo è una delle più grandi mani-avanti che abbia mai visto ed è perfettamente superflua. Leggendo c’è ben poco da riabilitare. Ne esce un personaggio sfaccettato, simpatico, libertino, sentimentalmente rigido: affettuoso ma dissoluto, generoso e geloso della propria libertà sessuale. Eppure singolarmente imprudente. Se di fidanzate carine e accudenti diffida, tagliando di netto dopo qualche tempo, ecco invece che si consegna masochisticamente a due donne manipolatrici, confuse, entrambe con una figlia problematica avuta da un precedente matrimonio. Dopo averlo intervistato, Joyce Carol Oates lo compatisce per la sua ossessione verso un «destino inevitabile», riguardo alle sofferenze dovute alla prima moglie (che, com’è noto, falsificò un test di gravidanza facendo orinare una donna incinta abbordata in stazione per costringerlo a sposarla), e commenta: «Ognuno di noi è in grado di reggere solo una certa quantità di virtù, di più non possiamo permettercene». Roth avrebbe introiettato questa informazione e scritto a Bellow: «Continuavo a essere virtuoso, virtuoso in modi per me distruttivi. Ma da quando ho lasciato entrare il repellente ho imparato a vivere finalmente alle mie condizioni». E il repellente, forse, gli prese anche la mano. E veniamo al dunque, per usare un eufemismo.
C come Cazzo
Quando Roth e l’amica Claudia Roth Pierpont si trovarono a commentare lo scandalo del governatore dello Stato di New York Eliot Spitzer, che s’era dimesso a causa di un debole per le prostitute d’alto bordo (ogni santa volta veniva evocato Portnoy, così anche nel 2013 per Anthony Weiner e il sexting), l’amica racconta: «Stavo cercando di elaborare una pretenziosa e complessa teoria sul perché [Spitzer] aveva voluto rovinarsi così, sul perché un uomo poteva agire in modo così stupido avendo così tanto da perdere. C’era di mezzo un impulso autodistruttivo?». Roth la guarda e le dice: «No, tesoro, è solo il cazzo». Questa risposta, che è puro stand-up e non manca mai di far ridacchiare, è anche un limite classico della generazione stroncata da David Foster Wallace in un celebre saggio, quella dei «peni [sic] con un dizionario dei sinonimi». Ossia una generazione vittima di sé stessa, impotente non sessualmente (per carità) ma emotivamente, incapace di controllare l’esuberanza. Diceva Kingsley Amis, altro illustre esponente in Italia poco letto, di avere passato gran parte della propria vita «incatenato a un madman» (non lo traduco perché sembra un refuso). Una generazione autoassolutoria, misticamente innamorata della fica, avanguardista nel territorio del desiderio («A volte penso alla mia generazione come alla prima ondata di arditi invasori sbarcati in Normandia, sulle cui carcasse sanguinolente i figli dei fiori sarebbero poi avanzati trionfanti verso la libidinosa Parigi»). «È solo il cazzo», perché il cazzo è tutto, perché è il cazzo a essere autodistruttivo: il piacere, ma anche la dannazione, tale e quale alla scrittura. Eppure c’è uno smarrimento – ad esempio nelle sue disperate lettere a Bellow: «Noi non siamo misogini!» – che fa tenerezza. Essere ostaggi di sé stessi e di un desiderio immaturo represso per anni, patire il senso di colpa di volere godere, giustificarsi di continuo (sebbene non vi sia traccia di violenza in queste pagine). Come elaborare? Mi resta in mente il fantastico personaggio di La mia vita di uomo che si infila le mutandine e il reggiseno della compagna dopo avere litigato e piange incorporando il femminile attraverso il travestitismo. Non badare a me che frigno: è solo il cazzo.
D come Derivazioni
Roth, che pure è stilisticamente identificato e bollato con una nettezza che nessuno della sua generazione ha trovato, in realtà è stato mutevole. L’apprendistato con i primi libri, con echi di Henry James da un lato e Mark Twain dall’altro. Prima di trovare la voce imita Capote, imita Salinger, imita Hemingway. Con Bellow e Malamud trova due modelli definitivi. Eppure Portnoy non viene da nessuno di questi ed è uno stile – irresistibile, comico, tracimante: una sorta di Kafka rielaborato alla Lenny Bruce – che non ritroverà mai (o forse solamente in Sabbath, il libro che forse ha amato di più). Da Portnoy in poi si assesta come scrittore satirico. Le prime incursioni erano già avvenute sul giornale universitario. Roth si definiva “Swiftberg”, all’epoca. Un’insegnante gli disse: “Se intendi essere uno scrittore satirico, preparati a essere frainteso per tutta la vita”. Uomo avvisato. Una volta scrisse: «Ero intelligente e la scuola mi piaceva, e andavo bene, ma l’istruzione che ricordo veniva soprattutto dai fumetti, dai programmi radiofonici, dai film, dai cinegiornali, dal baseball e dai quotidiani della sera. Non ricordo nessuno dei libri che ho letto da bambino». Mentiva, eppure c’era in questa dichiarazione una grande verità: la vocazione saldamente popolare, l’attenzione per la cultura di ogni giorno, la passione per l’uomo comune e per la sua innocenza. Solo quando riuscì a coniugare entrambe le cose, James e Twain, Isabel Archer e Huck Finn, trovò una voce. Il libro decisivo è Le avventure di Augie March, lo dice chiarissimo parlando di «tono ampollosamente colloquiale», che si attaglia decenni dopo anche a Pastorale americana.
E come Ebrei
Sì, veniva da una comunità soffocante, ma non così osservante. Quando un produttore della Bbc fece un documentario su di lui, Roth gli scrisse: «Con quella tua musichetta coi violini trasmetti l’idea sbagliata». E spiegò che aveva sentito la musica klezmer per la prima volta a sessant’anni.
F come Fine
Non sembrava mai arrivare per questo infaticabile artigiano. Quando a pochi importava più nulla di lui, tirò fuori una trilogia capolavoro e poi, anno dopo anno, una serie di libri impressionanti. Infine si arrese. Prima di decidere di smettere di scrivere, ancora si aggrappava agli amici: «Datemi qualche argomento. Pensiamo a qualche catastrofe». Poi si rilassò. Gironzolava per New York, chiacchierava, si rileggeva, si faceva prendere bonariamente in giro (battuta che girava: «Ormai Roth passa anche all’inaugurazione di una profumeria»). Quando faceva il sonnellino, seguiva ancora il consiglio del padre. Si toglieva i vestiti e dormiva in mutande e canottiera. «Farai un sonno più profondo». Ci sono, finalmente, cose patetiche. Quando manda a un’amante decisa a lasciarlo una rendita mensile anonima di duemila dollari, purché non si sposi (non funziona). Quando vezzeggia l’ultima amante: coccolata in modo paternalistico fino alla stucchevolezza, adulata come un pigmalione qualsiasi, implorata fino a concederle la disponibilità di sposarsi e fare un figlio (non funziona manco qui). Ci volevano gli ottant’anni, Phil, per diventare come noialtri.
Prima di decidere di smettere di scrivere, ancora si aggrappava agli amici: «Datemi qualche argomento. Pensiamo a qualche catastrofe». Poi si rilassò
G come Giornali
In realtà le bordate che si prende Roth ancora nell’ultimo periodo sono impressionanti, in parte per l’abitudine soft del nostro giornalismo (quale giornale direbbe male del nuovo libro, che so, di Sandro Veronesi?). Kakutani sul New York Times lo demolisce non so quante volte (quando comincia a essere riverito come venerato maestro scrive a un amico che gli manca solo l’ironicamente ambito Kakutani Prize). Hitchens – che, certo, era Hitchens – distrugge Exit Ghost. Una quantità di critici ne biasima, censura, irride l’opera per lunghissimo tempo, senza cogliere il work in progress che sta diventando (tra le memorabili eccezioni, Martin Amis sulla Controvita). Solo con Pastorale, che per me non è nemmeno il suo capolavoro, si quietano (e lui commenta: «Mi amano, dove ho sbagliato?»), per poi riaccendersi successivamente contro L’animale morente. C’è però una vicenda emblematica. Quando un critico stronca un libro di Roth, un amico gli fa notare che presto lui romanzerà la cosa in una scenetta vendicativa. E così, puntualmente, avviene. Eppure nella scenetta in questione Roth ridicolizza prima di tutto sé stesso ed è così che a quarant’anni di distanza noi riusciamo a ridere del protagonista senza dover sapere niente del critico che ha ispirato la pagina.
H come Herman Roth
Spedito in crociera dal figlio, per proteggerlo dal delirio suscitato da Portnoy, il padre invece si porta dietro uno scatolone di libri, attacca bottone con i passeggeri vantandosi del figlio e regala copie con dedica: «Da Herman Roth, il padre di Philip Roth».
I come Internet
Fin quando ha scritto, non l’ha mai usato.
J come Jerusalem
La sua Gerusalemme era Weequahic, Newark. Non c’è niente nella vita, non l’amore o il sesso o il successo, che abbia mai equiparato un ritorno a casa da sua madre sotto la neve alla fine della scuola. Il senso di pienezza, di accudimento, di felicità che gli diede la sua famiglia non l’avrebbe più ritrovato, andando a stanarlo nelle pieghe dei libri – pieni di amore verso un Eden irraggiungibile e forse immaginario – e alla fine nei ricordi delle persone che aveva conosciuto da giovane. Negli ultimi mesi si ritrovava con antichi flirt, entrambi decrepiti, a guardare album di fotografie e a tenersi per mano, con gli occhi lucidi. Nonna Roth.
K come Kafka
Difficile immaginare personaggio più distante (per quanto fosse un discreto frequentatore di postriboli) e insieme più pertinente. Il senso di colpa – atavico, continuo – tormenta tutta l’opera di Roth. La pressione della comunità, dell’estrema correttezza genitoriale, del puritanesimo cui risponde oscenamente, così sbagliando e alimentando nuovo senso di colpa e nuova benzina narrativa. In termini pratici Kafka è un modello di ossessione tematica, di paura commovente, di inermità potentissima data semplicemente dall’alfabeto (per tutta la vita, nello studio dove lavora, Roth tiene appese le semplici lettere del sillabario: ricordati che è quello che hai: un paragrafo, anzi no una frase, anzi no una parola, via via fino alle lettere: di lì verrà tutto). Quando gli dicono che ha scritto un romanzo tipo stand-up, risponde: «Sono stato molto più influenzato da un sit-down comic di nome Franz Kafka». L’amore per Kafka si traduce anche in diversi viaggi a Praga e poi, dopo avere familiarizzato con l’ambiente letterario, in una costante e generosissima attività di sostegno e divulgazione degli scrittori dissidenti cecoslovacchi prima della caduta del Muro. Anche qui non manca il risvolto esilarante: quando le autorità ceche cominciano ad accorgersi dei movimenti di Roth nel paese e dell’attività all’estero, interrogano i vari Kundera, Klíma, eccetera, e quelli, più o meno: «Roth? Che diamine, ma viene qui per le ragazze!». È solo il cazzo che ti salva dai regimi.
L come Lamento
Il romanzo più venduto nella storia di Random House. Tanto per dire: contribuì alla fine della censura letteraria in Australia. Forse tra i più clamorosi errori di traduzione, fatto dal primo editore (Bompiani, se non erro) e ormai ingovernabile, perché quello di Portnoy non è un lamento, ma un disturbo. Non a caso gli arguti francesi lo intitolarono Portnoy et son complexe.
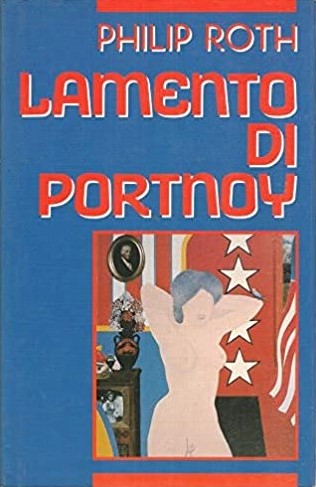
La copertina della prima edizione italiana di Lamento di Portnoy (Bompiani, 1970)
M come Masochismo
Scenetta. Dopo un’osservazione rivolta alla seconda moglie, l’attrice Claire Bloom, lei lo rimbrotta chiedendogli se c’è davvero bisogno di essere così sarcastici e lui risponde che si nasce per essere insultati. Anzi sulla sua tomba vorrebbe vedere scritto: «Philip Roth, nato per essere insultato». E per un certo periodo vorrebbe intitolare la sua opera finale Contro sé stessa. L’autobiografia di un’antitesi. Un’eco in fondo della dichiarazione di poetica più sincera: «Ho scelto di fare arte con i miei vizi invece che con quelle che ritengo essere le mie virtù».
N come Nobel
Inevitabilmente. Nel 1956, dopo la pubblicazione del suo primo racconto, Roth esultò: «Mi sento sparato a razzo verso la celebrità, come il vincitore di un premio Nobel». Che nemesi. Se lo giocò molto probabilmente nel 2014 quando disse a un quotidiano di Stoccolma: «Se Lamento di Portnoy si fosse intitolato L’orgasmo sotto il capitalismo rapace, allora forse mi sarei guadagnato il favore dell’Accademia svedese». Ma è opinabile: Coetzee è uno scrittore che ha molto in comune con lui e l’ha vinto. Ad ogni modo non è vero che se ne stava nell’ufficio dell’agente ad aspettare la telefonata, per un semplice motivo, a quell’ora negli Stati Uniti è l’alba e lui dormiva. Piuttosto un amico lo chiamava sempre in mattinata e con finto accento svedese gli diceva: «Ci duole informarla che, ancora una volta, lei non ha vinto il premio».
O come ombelico
Probabilmente Roth dovrebbe venire e verrà ricordato non per il tormento intorno la prostata (mi cito: «Quando la prostata indica la condizione umana, lo stolto guarda la prostata»), ma per l’esplorazione più profonda delle innumerevoli possibilità metanarrative (parola che odiava: sorry, Phil, ma sei morto) dell’io ombelicale, mettendo ostinatamente al centro sé stesso e la molteplicità dell’identità. Ci gioca di continuo. Addirittura, quando concepisce un doppio in Operazione Shylock lo chiama Moishe Pipik, e cioè Mosè Ombelico. Altro titolo che avrebbe voluto (evitato, per fortuna, ma indicativo): «La terribile ambiguità dell’io». In una delle migliaia di scatole cinesi, decide di far pubblicare Operazione Shylock come fiction su insistenza, come scrive a Simon & Schuster, «del Mossad». Per poi raccontare in ogni intervista che è tutto vero e mandare in confusione la casa editrice, costretta a ri-rubricarlo come nonfiction. E chissà come si divertiva. Per anni Roth-Zuckerman tiene lo specchio davanti a sé, lo scruta a lungo con quegli occhietti fondi, per indagare ogni piega contraddittoria del volto in reazione al mondo esterno, finché dai e dai lo specchio non diventa trasparente e Zuckerman comincia a essere testimone di quarant’anni di storia americana: il Vietnam, il maccartismo, il politically correct si ritrovano sulla pagina del fallocrate egoriferito con una potenza che tanti romanzi impegnati non avevano mai avuto.
P come Patrimonio
Il dato più ovvio eppure di continuo sconcertante è il mondo da cui veniva questo scrittore così moderno e cioè un mondo di ebrei fuggitivi e terrorizzati, affranti dal lavoro e dalla minaccia della realtà esterna. Anzi, non è nemmeno così sconvolgente. I nonni di Roth arrivavano dalla Galizia, la regione oggi tra Polonia e Ucraina. Erano scappati da un mondo in fiamme: prima i pogrom, poi i campi di concentramento, in mezzo la fame. Alla spicciolata. Prima gli uomini, poi le mogli con i figli. Il padre di Roth è il primo a nascere negli Stati Uniti. Il nonno era un aspirante rabbino, diventato un vaporizzatore di cappelli. È una grande comunità famigliare che si sparpaglia e divide per il New Jersey. Restando al nucleo famigliare in questione, non può ogni volta non restare impressa la sensazione di assedio – essersi lasciati dietro un mondo dove non potrai mai più tornare – e di conseguenza l’operosità sfiancante, mai vacillante, dolcissima. Lavorare di continuo, tenere insieme la famiglia, dare un tetto e un’istruzione ai due figli, anche a costo di non tirare mai il fiato. Amare, assistere, venerare. Da tutto questo mondo umile e disgraziato nel giro di pochi anni emerge uno degli scrittori più irridenti e iconoclasti della storia delle lettere. Nel giro di un fiato, una tribù di ometti emersa dallo shtetl si ritrova parodiata e ridicolizzata da un ragazzetto che, davanti agli sguardi attoniti di madri e padri e rabbini, non trova di meglio che fare oscillare il cazzo nudo con un ghigno osceno stampato in viso. Ecco la vostra sofferenza, ecco la vostra fuga, ecco il vostro nuovo mondo. L’avete bramato con tutta l’anima? Bene, è così che si conquista. E dovete perfino perdonarmi.
Q come Quantità
Invidiava Updike – doppio goyim e rivale stimatissimo – che aveva scritto più di lui. «Come c’è riuscito?» si chiedeva. Dopo l’irrisione di sé e degli altri, il dato che traspare di più è l’abnegazione e l’ostinazione come uniche vere vocazioni possibili, eco inevitabile dell’etica degli avi. «L’idea che non si debba necessariamente lavorare per tutto il tempo mi giunge del tutto nuova», disse nel 1991. Alzarsi presto, lavorare fino a mezzogiorno, consumare un pasto frugale, tornare a lavorare, fare una nuotata, mangiare, leggere, andare dormire: la routine di una vita e tutto per produrre due cazzo di paginette al giorno. Eccoci qua. Non si riesce a capire come riuscisse a infilarci le innumerevoli copule, eppure ce la faceva. I resoconti delle amanti parlano però di uomo dall’intimità irraggiungibile, riservato al limite del paranoico, chiuso nel Castello della Letteratura e smanioso di tornarci il prima possibile, sposato – in sostanza – con una vocazione divorante che emergerà con ancora più forza e potenza proprio in età senile, quando le distrazioni femminili cominceranno a diradarsi e una delle più incredibili tarde fioriture della letteratura d’ogni tempo abbaglierà il mondo.
R come Rothiani
Lascia poco, molto, come epigoni? Zadie Smith ha confessato il suo debito con Portnoy. Nicole Krauss ha racconto di quanto la rassicurasse pensare che lassù in Connecticut ci fosse un vecchietto che ancora pestava sui tasti come un fabbro (tra l’altro Bellow, alla prima lettura di Roth: «Quand’ero bambino, in giro c’erano ancora i fabbri, e non ho mai dimenticato il rintocco di un vero martello su una vera incudine»). Nathan Englander, di sicuro (e non parliamo di Auslander, al limite della caricatura di sé stesso). Gary Shteyngart fa ridere ma provoca meno. Il punto forse è non cercare di scimmiottarlo, ma ricordarsi che per lui il rintocco a festa di un libro era prima di tutto la libertà, perfino verso sé stessi. Infatti dopo Portnoy sbagliò un libro dopo l’altro.
S come Semplicità
«Non era una cultura libresca, era una cultura con un enorme rispetto per i libri». C’è tutto in questa frase. Roth non è un intellettuale: scrive rare recensioni, pochi saggi critici, il suo portato teorico è relativo al testo: dentro le cose. Il libro saggistico lo chiama Chiacchiere di bottega. È un narratore pragmatico: tenere i piedi per terra, girare le frasi, far parlare i fatti (come intitola una sorta di autobiografica ambigua nel 1988). Una volta all’università, incalzato da un gruppo di studentesse polemiche, chiede se non hanno voglia parlare di quello che c’è nella sua opera, e non di quello che avrebbe potuto o dovuto esserci. «Dopo un po’ non diventa noioso?» domanda esausto. Un’insegnante gli scrive una lettera cordiale per dirgli che le sue studentesse stanno leggendo Pastorale in termini di «ideologia, mito, intertestualità, genere e ambivalenza». Risponde: «Mi duole comunicarle che le parole ‘ideologia, mito, intertestualità, genere e ambivalenza’ mi fanno venire l’orticaria». Sulla scrivania tiene sempre una palla da baseball: consistenza, semplicità. Anche per lapide, ne sceglie una austera come quella di Camus. («Quindi sopra ci sarà solo il tuo nome?» gli chiede Lisa Halliday, una delle ultime amanti e amiche. E lui, buffone fino all’ultimo: «No, ci sarà quello di Camus».)
Il punto forse è non cercare di scimmiottarlo, ma ricordarsi che per lui il rintocco a festa di un libro era prima di tutto la libertà, perfino verso sé stessi
T come Tormento
«Perché di me non si dovrebbe parlare con la stessa serietà che di Colette? Ha fatto un pompino a un certo tizio in una stazione ferroviaria. Chi se ne fotte! […] Come mai le piaceva tanto? Questo ha un senso!». Non gli passava mai. E aveva ragione. Allora chiediamoci: come mai piaceva a lui. Al di là del testosterone, credo che un suo amico l’abbia compreso bene, quando disse: «Philip è un tossico della segretezza. […] Perché la natura dell’erotismo consiste nel condividere qualcosa di clandestino, che gli altri non vedono. E questo per lui è molto importante». Clandestino e giocoso e salace: aveva un rapporto con l’erotismo molto infantile, divertito, curioso. Gli serviva per conoscere. Ma per certi versi rimase sempre chiuso in bagno con i genitori che picchiano sulla porta, solo che i genitori erano la società e solo che permise a tutti – allo stesso tempo – di guardare dal buco della serratura.
U come Umorismo
Per definirsi, una volta scrisse su un post-it: «Umorista poliamoroso». In parte sono convinto che Roth facesse incazzare il mondo solo perché faceva ridere. Questo è il vero peccato: non raccontare l’uccello, ma raccontare l’uccello e farti ghignare. Sfottere sé stesso, aprire un romanzo epocale dicendo d’essere un mammone e raccontando di sborrarsi in faccia tutti i pomeriggi. Di recente ho letto un brano di Portnoy in un teatro e una signora ha alzato il ditino per dire: «Non si può ridurre Roth alle pippe». Eppure è riuscito nel miracolo di ridurre tutte le pippe a sé stesso. E sono certo che qui riderebbe ancora.
V come Voce
Il padre di Roth andò a scuola fino a quattordici anni e per anni ebbe incertezze ortografiche. Il giovane figliolo si appuntò: «Tu sei la voce della famiglia. Non scalzerai questi uomini, ma darai voce ai loro balbettii». Precocemente agiografico. Eppure fu proprio così.
W come Woody
Non si può eludere. Roth lo detestava. Era convinto che la mammella gigante di Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso venisse dritta dritta dal Seno, e forse non si sbagliava. Comunque i due scrittori venivano dallo stesso brodo. In Allen, Roth vedeva uno che si atteggiava a shlemiel ma nascondeva «un coccodrillo», testuali parole. Dopo la separazione con Allen, Farrow forse ebbe un flirt con Roth. La reazione non tardò, visto che in Harry a pezzi uno scrittore di nome Harry Block si scopa tutto lo scopabile e Allen – sottilmente, perfidamente – lo fa interpretare da Richard Benjamin, che aveva incarnato Alexander Portnoy tanti anni prima nell’unico e disastroso adattamento cinematografico.
X come XXX
Ossia, di nuovo, il sesso. Nel 1957 scrive a un amico. «È la prima volta che scrivo un racconto con delle scene di sesso, e mi è piaciuto, ma non so se funziona». Tenerezza. Ma solo chi non l’ha letto bene può stupirsi di alcune sue ritrosie, come nel primo goffissimo rapporto a tre con la prima moglie e un’amica comune, o davanti alla proposta di utilizzare un vibratore da parte di un’amante più disinibita di lui. È terrorizzato. Tutto viene affrontato e accolto come un nuovo aspetto di quel pianeta che per lui non smette mai di essere affascinante: con stupore, candore, paura. Nei romanzi Roth non pare mai il bellimbusto sicuro di sé, ma al contrario un tormentato amante della fica che non smette di esserne sconvolto nel profondo, a tal punto da non averne mai abbastanza. Fa sorridere che un giorno abbia visto la madre cattolica di una fidanzata leggere Sabbath e si sia vergognato. Anche da quella saturazione feroce nasce Pastorale, dove non compare nemmeno una parolaccia per cento pagine e dove però, ed è una delle cose più emozionanti da leggere, Zuckerman ricompare come «intelligenza mediatrice».
Y come Yiddish
Sender, il nonno di Roth, il primo a emigrare, voleva diventare rabbino a Boston. Qualcosa, non si sa cosa, gli fa cambiare idea. Mi domando com’è che Roth non abbia impostato una delle tante controvite narrative su questo. Che cosa succede su quella nave?
Z come Zuckerman
Perché allora il libro è tanto bello quanto inutile? Accusato dalla moglie di amare la donna di un romanzo più della moglie in carne e ossa, Roth rispose in un delirio paradossale: «Certo che amo Maria, lei non esiste – se tu non esistessi, amerei anche te». Zuckerman come un Candyman ebraico goloso di realtà, un babau che – insieme agli altri doppi letterari – divora tutto. Leggendo questa biografia si prova un senso di dissoluzione. Tra le tante baggianate che ha raccontato Roth per confondere i lettori, c’è quella di non essere così autobiografico: “È letteratura!”. La scusa che usiamo tutti per vampirizzare. Invece tutta la biografia è una sequela di incisi a specificare: questa persona è stata il modello per, questa ha ispirato quella situazione lì, la frase è stata ripresa tale e quale vent’anni dopo in. Roth si appunta in continuazione espressioni, dialoghi, scene, come un cronista della quotidianità. Registra conversazioni al telefono, interroga gli altri, scava: era, questo monologante snervante (Aldo Busi, più o meno, qualche anno fa: «Ai personaggi di Roth viene voglia di mettere un cerotto sulla bocca»), un fantastico ascoltatore. Da vecchio gli viene in mente una cosa importante e fa per alzarsi allo scopo di segnarsela, ma finalmente si rende conto che la lotta è finita. In realtà Roth non negava di usare l’io, negava che la scrittura potesse essere autobiografica in generale. Che questo tema avesse un senso. Gli altri si dissolvono, l’io si dissolve a furia di insistervi, come quando il tecnico della Ibm viene a riparagli la macchina da scrivere e scopre che il tasto “I” è consumato. Perfino il paese da cui vengono i nonni, Tarnopol, diventa il nome di un suo alter ego. È stata una prosa così profondamente autobiografica da avere divorato tutto e così profondamente potente da avere sovrastato la realtà, non ultima questa stessa biografia, dove Roth usa Bailey per un’ultima confusione, una falsificazione veritiera, l’artificio degli artifici e cioè credere che si possa raccontare una vita, che della vita resti qualcosa. Philip Roth (il libro, non il personaggio: e già questa chiosa è tutto), per quanto interessantissimo (com’è ovvio), è un incubo rothiano in cui annaspiamo nel vuoto. La vita vera è inattingibile, è (stata) un’appendice inutile, un prologo fittizio all’unica vera realtà: la letteratura. Restano i libri: gli unici fatti.






