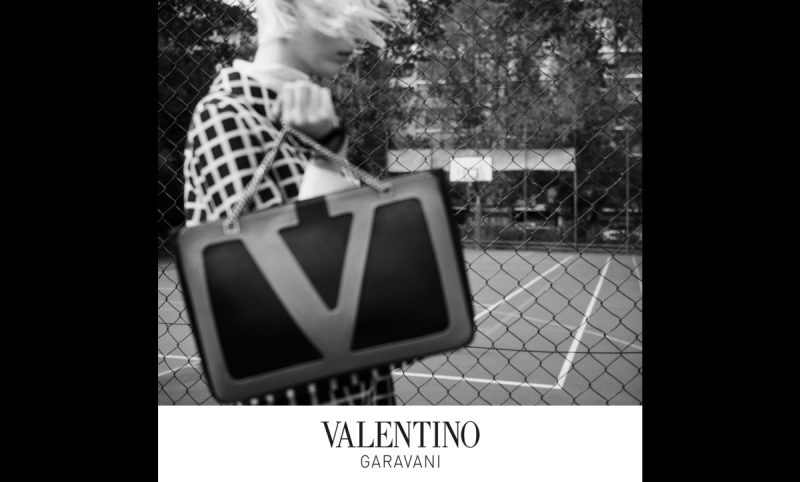L’ultima sfilata Couture di Balenciaga segna – questa volta in maniera definitiva – la fine dell’era Demna. Dieci anni in cui il Direttore creativo georgiano ha scritto la sua parte di storia della moda.
Le prime sfilate digitali di Parigi
Tra esperimenti video e nuove collaborazioni, le collezioni couture e maschili hanno cercato di riempire il vuoto creato dall’impossibilità di sfilare.

Dopo l’esperimento di Londra a giugno, piuttosto dimenticabile, di emozione per queste strane sfilate digitali ce n’era poca. Non che prima ce ne fosse tanta, visto che sono almeno cinque anni che se ne decreta la fine, ma immaginare la settimana della moda senza il solito corollario di eventi, rituali e ritrovi era quantomeno una sfida, un momento di reset tanto agognato quanto temuto, perché in qualche modo avrebbe potuto tradursi nella definitiva perdita di rilevanza culturale dell’intero sistema che sulle sfilate si basa. Questa sorta di timore misto a incertezza, allora, ha prodotto un’atmosfera da nessuna aspettativa, o di aspettative relativamente basse, perché in fondo c’è pur sempre una pandemia in corso, già c’erano problemi prima figuriamoci adesso, se anche sono così così bisogna capire, quasi non stessimo parlando di un’industria che fattura miliardi di euro, e che pure si era dovuta fermare. Come ogni relazione che inizia con questo livello di disincanto e distaccamento emotivo, alla fine il primo esperimento digitale di Parigi, che dal 9 al 13 luglio ha mandato online le sue collezioni couture e maschili, si è rivelato molto meglio di quanto non ce l’aspettassimo.
Sebbene certi ottusi riti siano inspiegabilmente rimasti – come l’RSVP o il calendario per orari più in generale, anche se è comprensibile la necessità di fornire una sorta di timeline degli eventi – le sfilate digitali si potevano “consumare” a qualsiasi orario, senza tutte quelle idiosincrasie che normalmente le caratterizzano (il posto a sedere, le fila all’ingresso, le attese) e si sono rivelate perciò estremamente liberatorie. Guardando i video che passano per i profili social dei marchi e dei direttori creativi, ci si può perciò immergere nel flusso di una collezione, che si dispiega tra le Stories di Instagram e le video performance su YouTube alternandosi ai normali contenuti che solitamente popolano i nostri account, e scandendo così un tempo diverso, che in certi casi riesce a trasformarsi in piccole esperienze immersive. Come per il backstage controllatissimo di Hermès, perfetto per riassumere l’eleganza misurata del marchio, o come la collezione poetica e spettrale, intesa nel senso migliore del termine, di Walter Van Beirendock, intitolata M!rorr. Ghost Whisper Loud, con i manichini che sembravano usciti da un videogioco e le musiche di Perfume Genius. Molti designer hanno scelto saggiamente di lavorare sui capi che hanno fatto la loro fortuna, quasi come se avessero fatto tesoro del ritorno all’essenzialità di cui tanto si è predicato in quarantena, ma anche di quella necessità virtù che la situazione ha imposto. Lo hanno fatto Rick Owens e Yohji Yamamoto, ad esempio, che per inciso sono poi quegli stilisti che sicuri di sé, e del proprio percorso, lo erano già da prima: ritrovarli fa sempre piacere, così come constatare che non hanno bisogno di cambiare e inseguire il nuovo a tutti i costi.
L’altra cosa curiosa dell’assistere alle sfilate in questo formato è osservare come vengono recepite sui social, ora che anche l’ultimo grado di separazione è stato abbattuto: non arrivano lì dopo essersi svolte da qualche parte nel mondo reale, ma lì succedono direttamente. Il corto di Matteo Garrone per Dior, ad esempio, nonostante le ambientazioni meravigliose, che ricordavano Il racconto dei racconti, e il riferimento al Théâtre de la Mode – il viaggio itinerante tra Europa e America compiuto dalle creazioni dei sarti francesi nell’immediato secondo dopoguerra, un tema che più designer hanno ripreso –, è stato criticato per il cast completamente bianco e, più in generale, ha sollevato il tema cruciale della moda come puro escapismo: ha ancora senso? Speriamo davvero di sì, anche se è difficile per Maria Grazia Chiuri, che dal suo esordio a Dior cerca di trovare un difficile equilibrio tra un attivismo politico spesso percepito come performativo e una vasta gamma di ispirazioni che vanno dall’arte alla letteratura. In questo senso, il vestito unico di Iris van Herpen, indossato da Carice van Houten (Melisandre di Game of Thrones), era invece la via di fuga perfetta.
Tra gli esperimenti più riusciti, infine, ci sono quelli di Virgil Abloh da Louis Vuitton e Kim Jones da Dior Homme. Partendo, come ha fatto Chiuri, dalla moda in scatola che viaggia per il mondo, Abloh ha infatti presentato un corto spassosissimo e psichedelico, The Adventures of Zoooom with Friends, con cui ha annunciato l’intenzione di non sfilare più in calendario a Parigi secondo le tradizionali stagioni, ma di portare avanti un unico grande show che avrà diverse installazioni locali: la prima è prevista a Shanghai già ad agosto. Jones, invece, ha collaborato con l’artista ghanese Amoako Boafo, i cui intensi ritratti si sono trasformati in stampe, tessuti e tagli. Il video che racconta la collezione, con Jackie Nickerson alla regia e Chris Cunningham alla colonna sonora, è l’esempio da manuale su come lavorare oggi sugli spunti culturali senza impantanarsi nell’appropriazione. Bravi entrambi, qualora qualcuno avesse bisogno di conferme.

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.