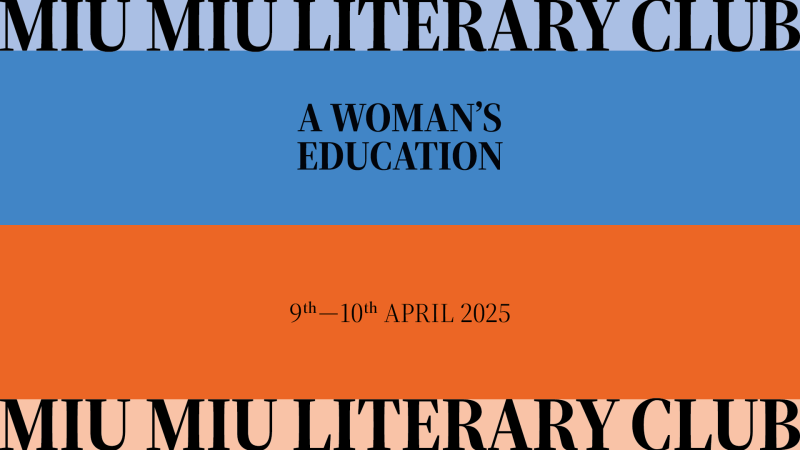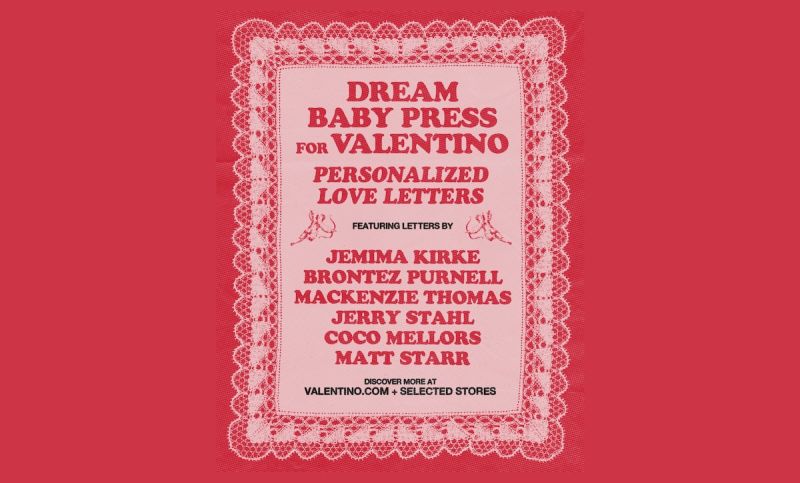La moda low cost è sostenibile?
H&M, Zara, Primark hanno rimesso in discussione tanto l’industria dell'abbigliamento quanto il concetto del “vestirsi bene”, ma con quali contraddizioni?

Durante una conferenza del Copenaghen Fashion Summit del 2014, la giornalista Vanessa Friedman (nel video più sotto) ha iniziato uno dei suoi numerosi interventi – dal titolo Reduce, Revise, Regularise – con un’ammissione: mentre tentava di scrivere un pezzo sulla sostenibilità della moda, si era resa conto che c’era un errore linguistico di base che le impediva di procedere. Quell’errore partiva dal concetto di «moda sostenibile», che, di per sé, non aveva nessun senso. È una contraddizione di termini, un ossimoro. Da una parte c’è la spinta continua verso il nuovo, dall’altra l’imperativo di mantenere, preservare, conservare: messi insieme, non possono che escludersi a vicenda. Friedman metteva anche in guardia sulla pericolosa tendenza all’accumulo – di prodotti, negozi, idee non necessarie – che era già evidente nell’industria e che ha portato alla crisi del modello di cui stiamo parlando nell’ultimo anno e mezzo. Crisi di cui il fast fashion è in parte responsabile e che ha finito per coinvolgere il lusso. Riprendere oggi quell’intervento è più utile che mai, soprattutto dopo l’arrivo in Italia di Primark, che ha appena inaugurato all’Arese Shopping Center in provincia di Milano, e la campagna Rewear It di H&M, che dal 18 al 24 aprile lancia la World Recycle Week. Per una settimana, i clienti sono invitati a depositare tutti gli abiti che non usano più presso gli store della compagnia svedese, che li ricompenserà con dei voucher e si impegnerà a riutilizzare i vecchi vestiti per crearne di nuovi.
La campagna ha come protagonista niente meno che M.I.A., sul cui «terzomondismo» molto si è scritto a partire da quel profilo di Lynn Hirschberg sul New York Times, risalente al 2010. In Rewear It, la popstar di origini tamil indossa la stessa tuta del video di Borders, che nel dicembre dell’anno scorso aveva provocato un acceso dibattito per come affrontava il tema di migranti. Nonostante il parere del Paris Saint Germain, però, l’esperimento di Borders sembra decisamente più riuscito – e in linea con quello che il personaggio M.I.A. vorrebbe rappresentare – rispetto a quello di Rewear It, che è stato subito tacciato di “greenwashing”, ovvero come tentativo di ripulire un modello di business eticamente controverso.
Eppure, H&M è al ventesimo posto della lista dei 100 brand più sostenibili del 2016 stilata da Corporate Knights, media company di ricerca di Toronto, ed è, fra i suoi diretti competitor, quella che più ha dimostrato attenzione nei confronti del problema della sostenibilità, come si nota un articolo di Quartz dal titolo Is H&M misleading customers with all its talk of sustainability? La nuova compagna, però, solleva non poche perplessità, scrive Lucy Siegle sul Guardian: «Prendendo in mano i numeri, gli annunci di H&M sembrano quantomeno fantasiosi. I problemi tecnici legati al riciclo della fibra commerciale fanno sì che solo una piccola parte di essa possa essere riciclata. H&M dovrebbe impiegare all’incirca 12 anni per riutilizzare 1000 tonnellate di abiti dismessi». La giornalista individua poi altre criticità dell’iniziativa: innanzitutto, il sistema dei voucher, che spinge i clienti a comprare altri prodotti – l’incessante bisogno del nuovo, con le parole di Friedman – e non ultimo la data, che cade in concomitanza con la Fashion Revolution Campaign, che si tiene da un paio di anni nello stesso periodo.

La campagna, che consiste nell’invito a fare acquisti consapevoli e a scegliere con attenzione i vestiti che si indossano, è nata per commemorare le vittime del crollo di Rana Plaza a Dacca in Bangladesh, quando il 24 aprile 2013 un complesso fatiscente si è accartocciato su stesso provocando 1134 vittime e più di 2500 feriti: il più grave incidente nella storia dell’industria tessile. Nel fabbricato si producevano abiti per grandi catene come Auchan, Inditex, Walmart, Bonmarché, Mango e Primark fra gli altri. In molti si sono accorti solo in quel momento del costo altissimo, in termini di diritti umani e di sfruttamento dell’ambiente, degli abiti a poco prezzo.
Lo ha spiegato lucidamente John Oliver un po’ di tempo fa durante il suo show su HBO – «Trendy clothing is cheaper than ever and cheap clothing is trendier than ever» – mentre i curatori Jennifer Farley Gordon e Colleen Hill, già autori di Sustanaible Fashion: Past, Present and Future, facevano notare in un’intervista con i-D Magazine: «Ci sono molte cose che non vanno nel fast fashion, ma l’idea che i vestiti debbano essere così economici e disponibili in fretta è uno dei problemi maggiori. La moda economica è creata con materiali economici, che sono i più dannosi per l’ambiente. La produzione di questi abiti, inoltre, conta su una manodopera a basso costo, e la maggior parte di questi vestiti sono realizzati da persone che lavorano senza essere tutelate. Nonostante queste produzioni costino molto all’ambiente e all’uomo, questi abiti spesso sono di poco valore e vengono buttati via come se niente fosse». Nel primo Zoolander, l’unico che vale la pena citare, una minacciosa setta guidata da oscuri personaggi reggeva le sorti dei Paesi in via di sviluppo, fonti di lavoratori da sfruttare fino all’esaurimento: oggi ci ritroviamo a fare i conti con una realtà del tutto simile, senza nessuna ironia naïve.
Ciò comporta due conseguenze principali, una che investe l’individuo e l’altra il modello di società nella quale vorremmo vivere. Scegliere di “vestirsi bene” o di vestirsi in un determinato modo piuttosto che in un altro, è storicamente sempre stata una dichiarazione d’intenti e oggi diventa una presa di posizione politica ed etica, esattamente come scegliere di mangiare o meno la carne o da che parte stare quando si parla di uguaglianza dei sessi. Dal punto di vista dell’industria dell’abbigliamento, il low-cost – inizialmente salutato come l’avvio di un processo di democratizzazione della moda – ha travolto e centrifugato il ready to wear, la couture, la filiera del tessile, le scuole di formazione dei designer, le piccole e grandi sartorie, il made in Italy e praticamente tutte le certificazioni tessili di qualità; in ultimo ha rimodellato i gusti del consumatore abituandolo alla voracità isterica dell’usa e getta. Che sia chiaro: non è l’unico problema serio che la moda si trova ad affrontare – dubbi simili esistono sulla manodopera sottopagata utilizzata da molti marchi del lusso o sull’uso della pelliccia – ma è sicuramente una delle questioni più stringenti dell’oggi.

In un articolo su Business of Fashion dall’eloquente titolo Should companies take a political stand?, Simon Collins si è chiesto cosa dovremmo aspettarci dai marchi che “consumiamo”: «Credo che in un periodo storico estremamente polarizzato come questo – basti pensare alla folle, surreale campagna elettorale americana – tutti i marchi, compresi quelli della moda, devono chiedersi se hanno intenzione di immolarsi a qualcos’altro che non sia il profitto». Citando alcuni casi specifici – Macy’s che ritira i prodotti di Donald Trump dopo le sue affermazioni razziste contro i messicani, il CEO Starbucks che approva il matrimonio fra persone dello stesso sesso – Collins sottolinea che sì, è difficile stabilire quanto queste prese di posizione siano un altro modo di fare marketing (ricordate la collezione di Dolce & Gabbana di hijab e abaya?) ma che lui considera la lista delle compagnie “anti-gun” stilata dalla National Rifle Association la sua personale shopping list. E ancora: «Probabilmente, se ci aspettassimo che tutte le aziende si esprimessero su quegli argomenti che riteniamo fondamentali, e di conseguenza scegliessimo solo quelle che dimostrano una buona coscienza sociale, potremmo segnare la fine del consumismo agnostico».
Riformulare il linguaggio allora è un buon punto di partenza, come nota Friedman in chiusura del suo intervento: prendendo ad esempio una vecchia zia e le sue ottime borse indossate per decenni, il suo cappotto “buono” e i suoi maglioncini di cachemire, secondo la giornalista più che di moda sostenibile, è utile parlare di guardaroba sostenibile. Comprare di meno, lavare meglio (preferibilmente a mano), conservare nella maniera corretta, riutilizzare gli abiti usati: così si costruisce un guardaroba che non teme le stagioni e si argina quel bisogno fabbricato – quindi esterno – di avere sempre qualcosa di nuovo fra le mani. E no, non è una posizione punitiva nei confronti del mercato: chi potrà mai negare che un cappotto prodotto in Italia, magari in un lanificio veneto, duri per sempre?