Cosa abbiamo letto a giugno in redazione.
Il pulsante con cui Facebook ha conquistato il mondo
Un estratto da La macchina del caos di Max Fisher, appena arrivato in Italia grazie a Linkiesta Books: in questo paragrafo, l'autore racconta le origini del tasto Mi piace, l'innovazione che ha cambiato prima i social, poi il mondo e alla fine la psiche collettiva.
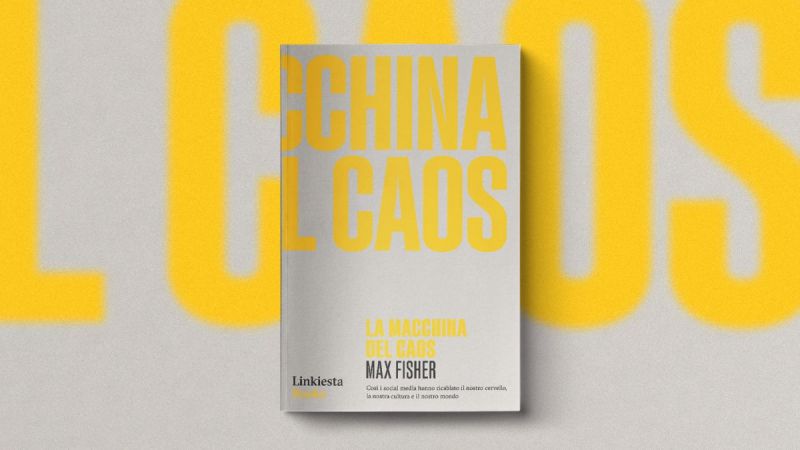
Pubblichiamo un estratto dal libro del giornalista del New York Times Max Fisher, portato in Italia da Linkiesta. La macchina del caos è un saggio che racconta la storia dei social e, quindi, la nostra degli anni Duemila: dalle “semplici” piattaforme degli inizi agli strumenti di immenso potere di oggi, in grado di mutare i comportamenti privati e determinare il destino di interi Paesi. In questo paragrafo, si racconta l’origine del tasto Mi piace, l’innovazione che ha fatto di Facebook, e di Mark Zuckerberg, la superpotenza che conosciamo.
Un anno dopo il lancio del news feed, un gruppo di sviluppatori
di Facebook riprodusse un sistema che venne chiamato “pulsante
favoloso ”: con un solo click potevi esprimere approvazione per il
post di un altro utente. Zuckerberg respinse diverse volte l’idea,
convinto che questo avrebbe distolto gli utenti da comportamenti
più attivi, come appunto postare commenti. Cominciarono a considerarlo « un progetto maledetto perché non riusciva mai a passare l’“esame Zuck” », scrisse Andrew Bosworth, uno degli sviluppatori del news feed diventato vicepresidente di Facebook. Dopo un anno e mezzo di limbo il progetto, che era diventato nel frattempo il pulsante “Mi piace”, fu ripreso da un nuovo team di sviluppatori. In un post in cui ripercorreva l’accaduto, Bosworth scrisse che nei test con gli utenti quel pulsante riusciva a incrementare il numero di commenti ai post. Di fronte a quei risultati, Zuckerberg cedette.
All’inizio del 2009 una product manager di nome Leah Pearlman, che lavorava a quella funzione da quando si era unita a Facebook a ventitré anni, pubblicò un post in cui la presentava come « un modo immediato per dire agli amici che vi piace quello che postano: basta un semplice click ». Il traffico crebbe all’istante, e ben oltre le aspettative iniziali. Ma anche il comportamento degli utenti cambiò. In barba a tutti i Nir Eyal e a tutti i Sean Parker che parlavano di utenti ossessionati e dipendenti, quella nuova funzione, così come il news feed e molti altri sviluppi a venire, fu l’ennesimo esempio di una potente violazione psicologica arrivata un po’ per caso, e che neppure le aziende di social media riuscivano a comprendere. Il fascino di quel pulsantino, e di gran parte dei social media, sta tutto in un concetto chiamato “sociometro”. Tale concetto emerse per la prima volta da una domanda posta dallo psicologo Mark Leary: a che cosa serve l’autostima? Qual è il suo scopo? L’angoscia che prova chi ha una scarsa autostima è completamente autogenerata. Non avremmo mai sviluppato una vulnerabilità tanto insolita e dolorosa, argomentava Leary, se non ci desse qualche beneficio capace di far dimenticare il tremendo costo fisico che essa comporta. La sua teoria, ormai ampiamente diffusa, era che l’autostima fosse in realtà « una misura psicologica di quanto le persone ritengano di essere apprezzate nelle loro relazioni e socialmente accettate dagli altri ».
Gli esseri umani sono tra gli animali sociali più complicati del pianeta. Ci siamo evoluti per vivere in gruppi privi di leader ben più ampi di quelli dei nostri colleghi primati: fino a circa 150 membri. Come individui la nostra capacità di prosperare dipendeva dalla nostra bravura nel gestire i rapporti con gli altri 149 membri del gruppo. Se gli altri ci stimavano potevamo contare su supporto, risorse e forse anche su un partner. Altrimenti rischiavamo di starcene a mani vuote. Era una questione di sopravvivenza, fisica e genetica. Nel corso di milioni di anni quelle pressioni sociali hanno premiato le persone più sensibili allo status e più in grado di ricavarne il massimo possibile. È quella che l’antropologo Brian Hare chiama « sopravvivenza del più amichevole ». Il risultato è stato lo sviluppo del sociometro: la tendenza inconscia a monitorare la percezione che hanno di noi le persone che formano la nostra comunità. Processiamo queste informazioni sotto forma di autostima e di emozioni a essa collegate, quali l’orgoglio, la vergogna o l’insicurezza. Sono emozioni che ci spingono a fare di più quello per cui la comunità ci apprezza, e a fare invece di meno quello per cui non siamo apprezzati. E, aspetto fondamentale, queste emozioni servono a farci credere che questa motivazione arrivi da dentro di noi. Perché, se ci rendessimo conto a livello conscio che stiamo rispondendo alla pressione sociale, la nostra performance potrebbe risultare forzata o cinica, e quindi meno convincente.
La funzione “Mi piace” di Facebook, di cui ormai esiste una qualche versione su ogni piattaforma, è l’equivalente di una batteria d’auto collegata a quel sociometro. Mette nelle mani di chi controlla i cavi elettrici un potere tremendo sui nostri comportamenti. Non solo i “Mi piace” ci danno la validazione sociale che inseguiamo con tanto dispendio di energie, ma lo fanno anche con un’immediatezza e una portata finora sconosciute nell’esperienza umana. Offline una validazione tanto esplicita è abbastanza infrequente. Ancora più rara è quella pubblica, la forma di approvazione più potente perché conferma il nostro valore alla comunità nel suo insieme. Quand’è stata l’ultima volta che cinquanta, sessanta, settanta persone vi hanno applaudito offline? Forse ci è successo una volta ogni qualche anno, se è mai successo. Giusto? Sui social invece è una cosa normale. In più, la piattaforma ha aggiunto a tutto questo un twist molto potente: un contatore in fondo a ogni post per indicare il numero di “Mi piace”, retweet o cuori ricevuti – un conteggio dell’approvazione sociale per ogni nostra singola affermazione. È per questo che addirittura LinkedIn, una bacheca online in cui postare il proprio curriculum, si è trasformato in un sito di networking ed è stato venduto a Microsoft per 26,2 miliardi di dollari. E ha aggiunto dei badge ai profili degli utenti per indicare l’ampiezza della loro rete. « Anche se all’epoca non c’era niente di utile che si potesse fare su LinkedIn, quella semplice icona ebbe un effetto potentissimo, e molti si sentirono spinti ad agire per non sembrare degli sfigati », ricorda B. J. Fogg, capo del Persuasive Tech Lab di Stanford. Ma nel 2020 perfino il co-fondatore ( e allora ceo ) di Twitter, Jack Dorsey, ammise di dubitare del ragionamento che aveva portato al pulsante “Mi piace”, e specialmente « dei numeri legati a esso ». Non si impegnò certo a eliminare la funzione dal suo social, ma riconobbe che essa aveva creato « un incentivo che potrebbe rivelarsi pericoloso ».
Quell’incentivo è talmente efficace che risulta visibile anche nell’imaging cerebrale. Quando riceviamo un “Mi piace” l’attività neurale schizza in alto in una zona del cervello chiamata nucleus accumbens, ossia la regione che attiva la dopamina. I soggetti con un nucleus accumbens più piccolo (caratteristica associata alle tendenze dipendenti-ossessive ) usano Facebook per periodi più lunghi. E quando un utente fanatico riceve un “Mi piace”, la materia grigia mostra una attività maggiore che negli utenti meno ossessionati, un po’ come accade per i dipendenti dal gioco d’azzardo che sono stati condizionati a esaltarsi a ogni tiro di leva. Pearlman, la product manager di Facebook che aveva contribuito a lanciare il pulsante “Mi piace”, scoprì tutto questo una volta lasciata la Silicon Valley, nel 2011, per mettersi a disegnare fumetti. Ovviamente anche lei promuoveva il proprio lavoro attraverso Facebook. All’inizio i suoi fumetti andavano bene. Parlavano di temi edificanti legati alla gratitudine e alla compassione, che gli algoritmi di Facebook, nei primi anni Dieci del Ventunesimo secolo, spingevano molto. Poi però, verso il 2015, la piattaforma riorganizzò i propri algoritmi per sfavorire il “clickbait”, cosa che ebbe come effetto collaterale l’eliminazione della spinta artificiale che fino a quel momento veniva data ai contenuti più ricchi di emotività. « Quando Facebook ha cambiato l’algoritmo ho perso un sacco di “Mi piace” e mi è sembrato di non avere abbastanza ossigeno », raccontò Pearlman a Vice News . « Potevo incolpare l’algoritmo, lo sapevo, ma dentro di me qualcosa mi diceva: “Non gli piaccio, non sono abbastanza brava” ».
Il suo ex datore di lavoro le aveva messo contro il suo stesso nucleus accumbens, creando una brama di “Mi piace” talmente forte da farle dimenticare ogni logica. E poi, come Skinner che si baloccava con il protagonista di un suo esperimento, le aveva tolto ogni ricompensa. « Mi sono ritrovata a pagare ads solo per riavere quell’attenzione », ammise Pearlman. Per la maggior parte di noi il processo è meno evidente. Invece di acquistare ads su Facebook, noi modifichiamo i nostri post e commenti quotidiani per tenere attiva la dopamina, di solito senza rendercene nemmeno conto. È questo il vero « circolo vizioso della validazione sociale », come lo definì Sean Parker: quando cioè inseguiamo inconsciamente l’approvazione di un sistema automatizzato fatto per usare i nostri stessi bisogni contro di noi. «È molto comune per gli esseri umani sviluppare prodotti con le migliori intenzioni del mondo e accorgersi in seguito che hanno conseguenze negative impreviste », raccontò al Guardian Justin Rosenstein, un ex ingegnere di Facebook che aveva a sua volta lavorato al pulsante “Mi piace”. « Se ci importa solo di aumentare al massimo i profitti finiremo presto a vivere in una distopia », avvisò: « Uno dei motivi per cui penso che sia molto importante parlarne adesso è che potremmo essere l’ultima generazione che si ricorda com’era la vita prima ».

Il regista inglese torna alla saga che lo ha reso famoso e decide di stravolgerla: il risultato è un film d'autore, horror ma anche politico e sentimentale, che disattende tutte le aspettative e che ha diviso i fan.





